Rivista Internazionale n° 30
- letto 29 volte
Grecia: le rivolte giovanili confermano lo sviluppo della lotta di classe
- letto 5 volte
L’esplosione di collera e la rivolta delle giovani generazioni proletarizzate in Grecia non sono per niente un fenomeno isolato particolare. Affondano le loro radici nella crisi mondiale del capitalismo ed il loro scontro con la repressione violenta mette a nudo la vera natura della borghesia e del terrore di Stato. Esse si situano direttamente nella scia della mobilitazione su un terreno di classe delle giovani generazioni in Francia contro il CPE (Contratto di Primo Impiego) del 2006 ed la LRU (Legge sulla Riforma dell'Università) del 2007, in cui gli studenti ed i liceali si riconoscono innanzitutto come proletari in rivolta contro le loro future condizioni di sfruttamento. L’insieme delle borghesie dei principali paesi europei del resto l’ha ben compreso esternando i suoi timori di contagio delle esplosioni sociali di fronte all'aggravamento della crisi. Così, e ciò è significativo, la borghesia in Francia infine ha fatto marcia indietro sospendendo precipitosamente il suo programma di riforma dei licei. Del resto, il carattere internazionale della contestazione e della combattività studentesca, soprattutto la liceale, già si esprime fortemente.
In Italia, due mesi di mobilitazione studentesca sono stati caratterizzati da massicce manifestazioni che si sono svolte il 25 ottobre ed il 14 novembre, dietro lo slogan "La crisi, non la vogliamo pagare noi", contro il decreto Gelmini contestato a causa dei tagli di bilancio nel settore scolastico e delle sue conseguenze: particolarmente il non rinnovo dei contratti di 87 000 insegnanti precari e di 45 000 lavoratori ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed anche di fronte alla riduzione dei fondi pubblici per l'Università[1].
In Germania, il 12 novembre, 120 000 liceali sono scesi in strada nelle principali città del paese (con slogan tipo: “Il capitalismo è la crisi” a Berlino, o assediando il parlamento provinciale come ad Hannover).
In Spagna, il 13 novembre, centinaia di migliaia di studenti hanno manifestato in più di 70 città del paese contro le nuove direttive europee (direttive di Bologna) sulla riforma dell’insegnamento superiore ed universitario che generalizza la privatizzazione delle facoltà e moltiplica gli stage nelle imprese.
La rivolta delle giovani generazioni di proletari di fronte alla crisi ed al deterioramento del loro livello di vita si estende anche ad altri paesi: a gennaio 2009 Vilnius (Lituania), Riga (Lettonia) e Sofia (Bulgaria) hanno conosciuto movimenti di sommosse repressi duramente dalla polizia. In Senegal, a dicembre 2008, scontri violenti contro la miseria crescente, mentre i manifestanti chiedevano una quota dei fondi minerari sfruttati da Arcelor Mittal, hanno provocato due morti a Kégoudou, a 700 km nel Sud est di Dakar. In Marocco, 4000 studenti di Marrakech già si erano rivoltati all’inizio di maggio 2008 per un’intossicazione alimentare che aveva colpito 22 di loro in un ristorante universitario. In seguito alla repressione violenta del movimento con arresti, pesanti pene di prigione e torture, tali sommosse si sono moltiplicate.
Molti di loro si sono riconosciuti nella lotta degli studenti in Grecia.
L’ampiezza di questa mobilitazione di fronte alle stesse misure dello Stato non ha niente di sorprendente. La riforma del sistema educativo intrapreso a scala europea serve a condizionare le giovani generazioni operaie ad un avvenire bloccato ed a generalizzare la precarietà e la disoccupazione.
Il rifiuto e la rivolta delle nuove generazioni di studenti proletari contro questo muro di disoccupazione e questo oceano di precarietà che il sistema capitalista in crisi riserva loro suscitano ovunque la simpatia dei proletari di ogni generazione.
Violenza minoritaria o lotta massiccia contro lo sfruttamento ed il terrore di Stato?
I media agli ordini della propaganda menzognera del capitale hanno continuamente cercato di deformare la realtà sugli avvenimenti in Grecia dopo l’omicidio, il 6 dicembre, del quindicenne Alexis Andréas Grigoropoulos, colpito da un proiettile sparato dalla polizia. Essi hanno presentato gli scontri con la polizia come semplici episodi limitati ad un pugno di autonomi anarchici e di studenti estremisti di sinistra provenienti da famiglie agiate, o di vandali emarginati. Non hanno smesso di diffondere in televisione immagini di scontri violenti con la polizia e soprattutto scene di sommosse di giovani con passamontagna che danno fuoco alle automobili, che frantumano vetrine di negozi o di banche, e che saccheggiano magazzini.
Questo è proprio lo stesso metodo di falsificazione della realtà adottato in Francia all'epoca della mobilitazione anti-CPE del 2006, quando quest’ultima fu assimilata alle sommosse nelle periferie dell'anno precedente. Lo stesso grossolano metodo fu adottato contro gli studenti che lottavano contro la LRU nel 2007 in Francia paragonati a “terroristi” e anche ai “Khmer rossi”!
Pur se il centro delle agitazioni ha avuto luogo nel quartiere universitario greco, Exarchia, è difficile far credere oggi che questi movimenti di rivolta sarebbero solo opera di bande di teppisti o di attivisti anarchici visto che si sono estesi molto velocemente all'insieme delle principali città del paese e persino alle isole (Chios, Samos) ed a città turistiche come Corfù, Heraklion a Creta.
In effetti, le rivolte si sono estese a 42 prefetture della Grecia ed anche in città dove non c’erano mai state manifestazioni. Più di 700 licei ed un centinaio di università sono state occupate.
Le ragioni della collera
C’erano tutte le condizioni affinché il malcontento di una larga parte delle giovani generazioni operaie, prese dall’angoscia e private di avvenire, esplodesse in Grecia che è un concentrato del vicolo cieco riservato dal capitalismo alle giovani generazioni operaie: quando quelli che sono chiamati "la generazione 600 euro" entrano nella vita attiva, hanno l'impressione di essere truffati. La maggior parte degli studenti deve svolgere due lavori quotidiani per sopravvivere e proseguire gli studi: questi consistono in piccoli lavori non dichiarati e sottopagati; ed anche in caso di impieghi ben rimunerati, una parte del loro stipendio non è dichiarata e ciò impedisce loro di usufruire di certi diritti, in particolare si ritrovano privi di sicurezza sociale; le loro ore supplementari non sono pagate e talvolta restano in famiglia fino a 35 anni per mancanza di redditi sufficienti per potersi pagare un tetto. Il 23% dei disoccupati in Grecia è costituito da giovani: ufficialmente il tasso di disoccupazione da 15 a 24 anni è del 25,2%. Così leggiamo su un giornale in Francia[2]: "Questi studenti non si sentono più protetti da niente: la polizia gli spara addosso, la scuola li intrappola, l'impiego li abbandona, il governo mente loro". La disoccupazione dei giovani e le loro difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro hanno creato e diffuso un clima di inquietudine, di collera e di insicurezza generalizzata. La crisi mondiale sta producendo nuove ondate di licenziamenti massicci. Nel 2009, è prevista una nuova perdita di 100 000 impieghi in Grecia e ciò corrisponde al 5% di disoccupazione in più. Nello stesso tempo, il 40% dei lavoratori guadagna meno di 1100 euro lordi e la Grecia conosce il tasso più elevato di lavoratori poveri dei 27 Stati dell'UE: il 14%.
D’altra parte, non sono stati solo i giovani a scendere nelle strade, ma anche insegnanti mal pagati e molti salariati, in preda agli stessi problemi, alla stessa miseria ed animati dallo stesso sentimento di rivolta. La brutale repressione del movimento, di cui l'omicidio di questo adolescente di 15 anni è stato l'episodio più drammatico, ha solamente amplificato questa solidarietà che si mescola al malcontento sociale generalizzato. Come viene riportato da uno studente, molti genitori di alunni sono stati profondamente impressionati e si sono anche ribellati: “i nostri genitori hanno scoperto che i loro figli possono morire così per strada, sparati da un poliziotto”[3] e hanno preso coscienza del deterioramento di una società dove i loro figli non avranno il loro stesso livello di vita. Nelle numerose manifestazioni, essi sono stati testimoni dei violenti pestaggi, degli arresti brutali, di spari ad altezza d’uomo effettuati dai poliziotti antisommossa (i MAT ) con le loro armi di servizio.
Gli occupanti del Politecnico, importante luogo della contestazione studentesca, hanno denunciato il terrore di Stato, ma questa collera contro la brutalità della repressione la si ritrova anche in tutte le manifestazioni con slogan tipo: "Proiettili per i giovani, soldi per le banche". Ancora con maggiore chiarezza, un partecipante del movimento ha dichiarato: "Non abbiamo né lavoro né denaro e lo Stato, in fallimento con la crisi, risponde a tutto ciò dando armi ai poliziotti"[4].
Questa collera non è nuova: gli studenti greci si erano già largamente mobilitati nel giugno 2006 contro la riforma universitaria la cui privatizzazione implicava l'esclusione degli studenti di famiglie modeste. Anche la popolazione aveva manifestato la sua collera contro l'incurie del governo all'epoca degli incendi dell'estate 2007 che avevano provocato 67 morti; un governo che non sempre ha indennizzato le numerose vittime che avevano perso le loro case o i loro beni. Ma sono stati soprattutto i salariati a mobilitarsi massicciamente contro la riforma delle pensioni all’inizio 2008 con due giornate di sciopero generale, molto seguite, in due mesi, con manifestazioni che ogni volta hanno riunito più di un milione di persone contro la soppressione della pensione anticipata per le professioni più usuranti e la rimessa in discussione del diritto delle operaie di pretendere la pensione fin dai 50 anni.
Di fronte alla collera dei lavoratori, lo sciopero generale del 10 dicembre inquadrato dai sindacati è servito da contromossa per cercare di deviare il movimento, con il PS e PC in testa che reclamavano le dimissioni del governo attuale ed elezioni legislative anticipate. Ciò non è servito a canalizzare la collera ed a porre fine al movimento, malgrado le molteplici manovre dei partiti di sinistra e dei sindacati per tentare di destabilizzare la dinamica d’estensione delle lotte e gli sforzi di tutta la borghesia e dei suoi media per isolare i giovani dalle altre generazioni e dall'insieme della classe operaia spingendoli in scontri sterili con la polizia. Durante queste giornate e queste notti, gli scontri sono stati incessanti: le violente cariche poliziesche a forza di manganelli e di granate lacrimogene si sono risolte in arresti e pestaggi a decine.
Sono proprio le giovani generazioni di operai ad esprimere chiaramente il sentimento di disillusione e di nausea rispetto ad un apparato politico reazionario e corrotto. Dal dopoguerra, tre famiglie si dividono il potere, e da più di trent'anni, le dinastie dei Caramanlis (a destra) e dei Papandreu (a sinistra) regnano alternativamente da soli sul paese a forza di bustarelle e scandali. I conservatori sono arrivati al potere nel 2004 dopo un periodo di super intrallazzi dei socialisti negli anni 2000. Molti rigettano l'inquadramento di un apparato politico e sindacale totalmente discreditato: "Il feticismo del denaro si è impossessato della società. Allora i giovani vogliono una rottura con questa società senza anima e cieca"[5]. Oggi, con lo sviluppo della crisi, questa generazione di proletari non solo ha preso coscienza dello sfruttamento capitalista che vive sulla sua pelle, ma esprime anche la coscienza della necessità di una lotta collettiva adottando spontaneamente i metodi e la solidarietà DI CLASSE. Al posto di affondare nella disperazione, trae fiducia da sé stessa, dalla sicurezza di essere portatrice di un altro avvenire e impiega ogni sua energia per insorgere contro la putrefazione della società che la circonda. I manifestanti rivendicano con fierezza il loro movimento: "siamo un'immagine del futuro di fronte ad un'immagine molto scura del passato".
Se la situazione ricorda maggio 68, la coscienza della posta in gioco va molto oltre.
La radicalizzazione del movimento
Il 16 dicembre, gli studenti invadono per alcuni minuti la stazione televisiva governativa Net e svolgono sotto gli schermi uno striscione che proclama: "Smettetela di guardare la televisione. Tutti in strada!" e lanciano anche quest’appello: "Lo stato uccide. Il vostro silenzio lo arma. Occupazione di tutti gli edifici pubblici"! La sede della polizia antisommossa di Atene viene attaccata ed un suo furgone è incendiato. Queste azioni sono subito denunciate dal governo come un "tentativo di capovolgimento della democrazia", ed anche condannate dal PC greco (KKE). A Salonicco, le sezioni locali del sindacato GSEE e dell'ADE-DY, la federazione dei funzionari, tentano di confinare gli scioperanti in un assembramento di fronte alla Borsa del lavoro. Tuttavia gli studenti liceali ed universitari con la loro determinazione riescono ad attirare gli scioperanti nella manifestazione. 4000 studenti e lavoratori sfilano nelle vie della città. Già l’11 dicembre alcuni militanti dell'organizzazione studentesca del Partito comunista (PKS) avevano tentato di bloccare le assemblee per impedire le occupazioni, (Università del Pantheon, Scuola di Filosofia dell'Università di Atene). I loro tentativi sono falliti mentre le occupazioni si sono sviluppate ad Atene e nel resto della Grecia. Nel quartiere di Agios Dimitrios, il municipio è occupato con un'assemblea generale alla quale hanno partecipato più di 300 persone di ogni generazione. Il 17, l’edificio sede del principale sindacato del paese, la Confederazione Generale dei Lavoratori in Grecia, GSEE, ad Atene, è occupato dai lavoratori che si proclamano insorti. Questi invitano tutti i proletari a fare di questo posto un luogo di assemblee generali aperte a tutti i salariati, agli studenti ed ai disoccupati. Uno scenario identico, con occupazioni ed assemblee generali aperte a tutti, ha avuto luogo anche all'Università di Economia di Atene ed al Politecnico.
Pubblichiamo la dichiarazione di questa lavoratori in lotta per contribuire a rompere il "cordone sanitario" dei media menzognero su queste lotte e che le presenta come violente sommosse animate da alcuni giovani teppisti anarchici che terrorizzerebbero la popolazione. Questo testo, al contrario, mostra la forza del sentimento di solidarietà operaia che anima questo movimento e che agisce anche da legame tra le differenti generazioni di proletari!
"O determineremo noi la nostra storia o lasceremo che essa venga determinata senza di noi. Noi, lavoratori manuali, impiegati, disoccupati, interinali e precari, locali o immigrati, non siamo dei telespettatori passivi. Dall'omicidio di Alexandros Grigoropoulos la sera di sabato 6, partecipiamo alle manifestazioni, agli scontri con la polizia, alle occupazioni del centro delle città come dei dintorni. Abbiamo molte volte lasciato il lavoro ed i nostri obblighi quotidiani per scendere in strada con gli studenti ed altri proletari in lotta.
ABBIAMO DECISO DI OCCUPARE L'EDIFICIO DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI IN GRECIA (GSEE):
Per trasformarla in uno spazio di libera espressione ed un punto di appuntamento per i lavoratori.
Per dissipare i miti incoraggiati dai media sull'assenza dei lavoratori negli scontri, sulla rabbia di questi ultimi giorni che sarebbe opera solo di circa 500 "incappucciati", "teppisti", con altre storie strampalate, e con la presentazione da parte dei telegiornali dei lavoratori come vittime di questi scontri, mentre la crisi capitalista in Grecia e nel mondo produce innumerevoli licenziamenti che i media ed i loro dirigenti considerano "un fenomeno naturale".
Per smascherare il ruolo vergognoso della burocrazia sindacale nel lavoro di sabotaggio contro l'insurrezione, ma anche in generale. La Confederazione generale dei lavoratori in Grecia (GSEE), e tutto l'intero apparato sindacale che la sostiene da decine e decine di anni, sabota le lotte, contratta la nostra forza lavoro con delle briciole, perpetua il sistema di sfruttamento e di schiavitù salariata. L'atteggiamento del GSEE mercoledì scorso parla da solo: il GSEE ha annullato la manifestazione degli scioperanti, già programmata, ripiegando precipitosamente su un breve assembramento sulla piazza Syntagma, assicurandosi nello stesso tempo di una rapida dispersione dei partecipanti, per paura che questi possano essere infettati dal virus dell'insurrezione.
Per aprire questo spazio, per la prima volta, come continuazione dell'apertura sociale creata dalla stessa insurrezione, spazio che è stato costruito col nostro contributo ma di cui siamo stati fino ad ora esclusi. Durante tutti questi anni, abbiamo affidato il nostro destino a salvatori di ogni natura, e alla fine abbiamo perso la nostra dignità. Come lavoratori, dobbiamo cominciare ad assumerci le nostre responsabilità, e smettere di riporre le nostre speranze nei leader "saggi" o in rappresentanti "competenti". Dobbiamo cominciare a parlare con la nostra voce, incontrarci, discutere, decidere ed agire per noi stessi. Contro gli attacchi generalizzati che subiamo la sola soluzione è la creazione di collettivi di resistenza "di base".
Per propagare l'idea dell'auto organizzazione e della solidarietà sui posti di lavoro, del metodo dei comitati di lotte e dei collettivi di base, abolire le burocrazie sindacali.
Durante tutti quest’anni, abbiamo subito la miseria, la rassegnazione, la violenza al lavoro.
Ci siamo abituati a contare i nostri feriti, i nostri morti - i sedicenti "incidenti sul lavoro".
Ci siamo abituati a ignorare che gli immigrati, nostri fratelli di classe, vengono uccisi. Siamo stanchi di vivere con l'ansia di avere assicurato il salario, di essere tassati e di garantirci una pensione che adesso somiglia ad un sogno lontano.
Lottiamo anche per non abbandonare le nostre vite nelle mani dei padroni e dei rappresentanti sindacali, come non abbandoneremo gli insorti arrestati nelle mani dello Stato e dei meccanismi giuridici!
LIBERAZIONE IMMEDIATA DEI DETENUTI!
RITIRO DELLE DENUNCE CONTRO I FERMATI!
AUTO ORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI!
SCIOPERO GENERALE!
ASSEMBLEA GENERALE DEI LAVORATORI NEGLI EDIFICI LIBERATI DEL GSEE"[6]
La sera del 17 dicembre, una cinquantina di bonzi e membri del servizio d’ordine sindacale tentano di riprendersi i locali ma vengono messi in fuga dall’intervento di studenti (in maggioranza anarchici, dell’Università di Economia, anch’essa occupata e trasformata in luogo di riunione e di discussione aperta a tutti gli operai) che vengono a dar man forte agli occupanti gridando a squarciagola "Solidarietà"!
Inoltre, l'associazione degli immigrati albanesi diffonde, per proclamare la sua solidarietà al movimento, un testo intitolato "Questi giorni sono anche i nostri!"
In modo significativo, una piccola minoranza di questi occupanti ha diffuso il seguente messaggio: "Panagopulos, il segretario generale del GSEE, ha dichiarato che noi non siamo dei lavoratori, perché i lavoratori sono al lavoro. Questo fatto, tra l’altro, rivela proprio che cosa è in realtà il ‘mestiere’ di Panagopulos. Assicurarsi che i lavoratori stiano buoni al lavoro e fare tutto ciò che è in suo potere perché i lavoratori vadano a lavorare.
Ma da una decina di giorni, i lavoratori non solo non sono al lavoro, ma li ritroviamo nelle strade. E questa è una realtà che nessun Panagopulos al mondo può nascondere (…) Siamo lavoratori, disoccupati (che paghiamo con il licenziamento le nostre partecipazioni agli scioperi indetti dal GSEE, mentre i sindacalisti sono ricompensati con promozioni), noi lavoriamo sotto contratto precario passando da un piccolo lavoro all’altro, lavoriamo senza sicurezza in modo formale o informale nei programmi di stage o negli impieghi sovvenzionati per diminuire il tasso di disoccupazione. Siamo una parte di questo mondo e siamo qui. Siamo dei lavoratori insorti, punto e basta.
Ogni moneta della nostra paga è pagato col nostro sangue, il nostro sudore, la violenza al lavoro, con teste, ginocchia, polsi, mani, e piedi rotti per incidenti di lavoro.
Il mondo intero è fabbricato da noi, lavoratori. (...)
Proletari dell'edificio GSEE liberato".
Gli appelli ad uno sciopero generale a tempo indeterminato a partire dal 18 si moltiplicano. I sindacati per questo giorno sono costretti ad indire uno sciopero di tre ore nei servizi pubblici.
Il mattino del 18 un altro liceale di 16 anni, partecipando ad un sit-in nei pressi della sua scuola in una periferia di Atene, è ferito da un colpo di pistola. Lo stesso giorno, parecchie sedi radio o televisive vengono occupate dai manifestanti, principalmente a Tripoli, Chania e Salonicco. Il palazzo della camera di commercio è occupato a Fatras dove si ripetono nuovi scontri con la polizia. La gigantesca manifestazione ad Atene viene repressa violentemente: per la prima volta, nuovi tipi di armi sono utilizzati dalle forze antisommossa: gas paralizzanti e granate assordanti. Un volantino diretto contro il "terrore dello Stato" è firmato "dalle ragazze in rivolta" e circola a partire dall'Università di Economia.
Il movimento percepisce confusamente i suoi limiti geografici: è per tale motivo che accoglie con entusiasmo le manifestazioni di solidarietà internazionale, in particolare a Berlino, a Roma, a Mosca, a Montreal o a New York e ne fa l'eco: "questo sostegno è molto importante per noi. Gli occupanti del Politecnico chiamano a "una giornata internazionale di mobilitazione contro gli omicidi di Stato" per il 20 dicembre; ma per vincere l'isolamento di questo movimento proletario in Grecia, la sola via, la sola prospettiva è lo sviluppo della solidarietà e della lotta di classe a scala internazionale che si esprime più chiaramente di fronte alla crisi mondiale.
Una maturazione portatrice di avvenire
A partire dal 20 dicembre violenti combattimenti di strada hanno luogo e la morsa si chiude in particolare intorno al Politecnico assediato dalle forze di polizia che minacciano di dare l'assalto. L'edificio del sindacato GSEE occupato viene abbandonato il 21/12 a seguito di una decisione del comitato di occupazione votata in Assemblea Generale. Il comitato di occupazione del Politecnico di Atene il 22 dicembre pubblica un comunicato che dichiara tra l’altro: "Siamo per l'emancipazione, la dignità umana e la libertà. Non è necessario spararci addosso i vostri gas lacrimogeni, già piangiamo sufficientemente da soli".
Con molta maturità, conformemente alla decisione presa dell'assemblea generale all'Università di Scienze Economiche, gli occupanti di quest’università utilizzano l’appello per la manifestazione del 24 contro la repressione poliziesca ed in solidarietà con gli arrestati come momento propizio per evacuare il palazzo in massa ed in sicurezza: "sembra esserci un consenso sulla necessità di lasciare le università e in generale di seminare lo spirito della rivolta nella società". Questo esempio sarà seguito nelle ore successive dalle assemblee generali delle altre università occupate evitando la trappola di restare chiusi dentro e di uno scontro diretto con la polizia. Sono evitati il bagno di sangue ed una più violenta repressione. Le assemblee generali hanno anche denunciato, come un atto di provocazione poliziesca, i colpi di arma da fuoco sparati contro un mezzo della polizia e rivendicati da una sedicente “Azione popolare”.
Il comitato di occupazione del Politecnico evacua simbolicamente l'ultimo bastione di Atene a mezzanotte del 24 dicembre. "L'assemblea generale e solo essa deciderà se, e quando, lasceremo l'università (…): il punto cruciale è che spetta agli occupanti, e non alla polizia, decidere del momento in cui bisogna lasciare i luoghi".
Prima, il comitato di occupazione ha pubblicato una dichiarazione: "terminando l'occupazione del Politecnico dopo 18 giorni, mandiamo la nostra più calorosa solidarietà a tutte le persone che hanno fatto parte di queste rivolte nelle differenti maniere, non solo in Grecia ma anche nei numerosi paesi europei, americani, dell’Asia ed in Oceania. Per tutti quelli che abbiamo incontrato e con cui continuiamo insieme a combattere per la liberazione dei prigionieri di questa rivolta, ed anche fino alla liberazione sociale mondiale".
In certi quartieri gli abitanti si sono impossessati degli altoparlanti, installati dalla municipalità per trasmettere canti natalizi, per leggere al microfono comunicati che, tra l’altro, chiedono, la liberazione immediata dei detenuti, il disarmo della polizia, lo scioglimento delle squadre antisommossa e l'abolizione delle leggi antiterroristiche. A Volos, la stazione radio municipale e gli uffici del giornale locale sono stati occupati per parlare degli avvenimenti e delle loro esigenze. A Lesvos, dei manifestanti hanno installato degli altoparlanti nel centro della città e hanno trasmesso dei messaggi. A Ptolemaida o a loannina, un albero di Natale è stato decorato con le foto del giovane liceale ucciso e delle manifestazioni e con le rivendicazioni del movimento.
Il sentimento di solidarietà si è nuovamente manifestato spontaneamente e con forza il 23 dicembre, dopo l'aggressione di un'impiegata dell'impresa di pulizia Oikomet, subappalto della compagnia della metropolitana di Atene (Athens Piraeus Electric Railway - ISAP -) con dell'acido solforico sul volto mentre ritornava dal lavoro. Alcune manifestazioni di solidarietà si sono svolte ed il 27 dicembre 2008 la sede della metropolitana di Atene è stata occupata mentre a Salonicco è la sede del GSEE ad essere occupata. Le due occupazioni hanno organizzato una serie di manifestazioni, di concerti di solidarietà e di "contro-informazione", occupando, per esempio, il sistema degli altoparlanti della stazione di metropolitana per leggere dei comunicati.
L'assemblea ad Atene ha dichiarato nel suo testo:
"Quando attaccano uno di noi, attaccano tutti noi!
Oggi, occupiamo l’ufficio centrale dell’ ISAP (metropolitana di Atene) come una prima risposta all'attacco omicida con il vetriolo sul volto di Constantina Kuneva il 23 dicembre, mentre ritornava dal lavoro. Constantina è in terapia intensiva all'ospedale. La settimana scorsa, ha litigato con la compagnia rivendicando tutto il premio di Natale per lei ed i suoi colleghi, denunciando gli atti illegali dei padroni. Già precedentemente, sua madre è stata licenziata dalla stessa compagnia. Lei stessa è stata trasferita lontano dalla sua prima stazione di lavoro. Sono comportamenti molto diffusi nel settore delle compagnie di pulizia che assumono lavoratori precari. (...) Oikomet (…) ha per proprietario un membro del PASOK (il partito socialista greco). In questa azienda che adopera ufficialmente 800 lavoratori (i lavoratori parlano del doppio, dal momento che negli ultimi tre anni hanno lavorato più di 3000) il comportamento mafioso illegale dei padroni è un fenomeno quotidiano. I lavoratori sono obbligati per esempio, a firmare dei contratti bianchi (le condizioni sono scritte successivamente dai padroni) che non hanno mai l'opportunità di rivedere. Lavorano 6 ore e sono pagati solo per 4,5 (salario lordo), per non superare le 30 ore, altrimenti devono essere iscritti nella categoria dei lavoratori ad alto rischio. I padroni li terrorizzano, li spostano, li licenziano e li minacciano a dimissioni forzate. Constantina è una di noi. La lotta per la DIGNITA’ e la SOLIDARIETA’ è la NOSTRA lotta".
Nello stesso tempo, l'assemblea d’occupazione del GSEE di Salonicco pubblicava un testo di cui riproduciamo degli estratti: "Oggi occupiamo la sede dei Sindacati di Salonicco per opporci all'oppressione che si manifesta attraverso gli omicidi ed il terrorismo contro i lavoratori; (...) facciamo appello a tutti i lavoratori per unirsi a questa lotta comune. (...) L'assemblea aperta di coloro che occupano la centrale sindacale che è di campi politici differenti, sindacalisti, studenti, immigrati e compagni stranieri ha adottato questa decisione comune:
- Continuare l'occupazione;
- Organizzare un assembramento in solidarietà con Constantina Kuneva; (...)
- Organizzare delle azioni di informazioni e di presa di coscienza delle città vicine;
- Organizzare un concerto nel Centro per raccogliere del denaro per Constantina".
Peraltro, questa assemblea dichiarava:
In nessuna parte nella piattaforma [dei sindacati], viene fatto riferimento alle cause della disuguaglianza e della miseria e delle strutture gerarchiche nella società. (...) Le Confederazioni Generali ed i Centri sindacali in Grecia sono parti intrinseche del regime al potere; i loro membri di base e gli operai devono girar loro la schiena, e (…) creare un polo autonomo di lotta diretto da loro stessi (…). Se i lavoratori prendono a carico le loro lotte e rompono la logica di essere rappresentati dai complici dei padroni, ritroveranno la loro fiducia e migliaia di essi riempiranno le strade nei prossimi scioperi. Lo Stato e le sue squadracce assassinano delle persone.
Auto-organizzazione! Lotte di autodifesa sociale! Solidarietà con i lavoratori immigrati e con Constantina Kuneva!"
All’inizio di gennaio 2009, manifestazioni hanno ancora luogo in tutto il paese in solidarietà con i prigionieri. 246 persone sono fermate di cui 66 sono ancora in prigione preventiva. Ad Atene 50 immigrati sono fermati nei primi tre giorni del movimento di rivolta, con pene che vanno fino a 18 mesi di prigione emesse senza interpreti e che si ritrovano minacciati di espulsione.
Il 9 gennaio giovani e poliziotti si sono di nuovo scontrati ad Atene, al termine di un corteo nella centro della città di circa 3000 insegnanti, studenti ed alunni. I loro striscioni raffiguravano slogan come: "Denaro per la scuola e non per i banchieri", "Abbasso il governo degli assassini e della povertà". Ingenti forze antisommossa hanno caricato a più riprese per disperderli, effettuando nuove numerose interpellanze.
Come in Grecia, ovunque, con la precarietà, i licenziamenti, la disoccupazione, i salari di miseria imposti dalla sua crisi mondiale, lo Stato capitalista non può che portare più polizia e repressione. Solo lo sviluppo internazionale della lotta e della solidarietà di classe tra operai, impiegati, studenti, disoccupati, lavoratori precari, pensionati, di ogni generazione, può aprire la via ad una prospettiva futura per abolire questo sistema di sfruttamento.
W. (18 gennaio 2009)
[1] Vedere l’articolo sul nostro sito Web: Mobilitazione massiccia contro la riforma dell’insegnamento in Italia.
[2] Marianne n°608 del 13 dicembre: “Grecia: le lezioni di una sommossa”.
[3] Libération del 12/12/2008.
[4] Le Monde del 10/12/2008.
[5] Marianne del 13 dicembre.
[6] La maggior parte dei testi riprodotti o le informazioni di stampa locale sono stati tradotti da siti anarchici come: indymedia, cnt-ait.info, dndf.org, emeutes.wordpress.com in francese o su libcom.org in inglese.
Geografiche:
- Grecia [1]
Patrimonio della Sinistra Comunista:
- Lotta proletaria [2]
La più grave crisi economica della storia del capitalismo
- letto 701 volte
La borghesia si è molto spaventata. Da agosto ad ottobre, un vero vento di panico ha soffiato sull'economia mondiale. A confermarlo ci sono le clamorose dichiarazioni di politici ed economisti: “Sull’orlo del baratro”, “Una Pearl Harbor economica”, “Uno tsunami che si avvicina”, “Un 11 Settembre della finanza”[1]... all’appello manca solo il riferimento al Titanic!
Bisogna dire che le più grandi banche del pianeta stavano per fallire l’una dopo l’altra e che le Borse affondavano perdendo 32.000 miliardi di dollari dall’inizio di gennaio 2008, vale a dire l’equivalente di due anni della produzione totale degli Stati Uniti. La Borsa islandese è crollata del 94 % e quella di Mosca del 71%!
Alla fine la borghesia, passando da un piano di “salvataggio” ad un piano di “rilancio”, è riuscita ad evitare la paralisi totale dell’economia. Questo significa forse che il peggio è dietro di noi? Certamente no! La recessione nella quale siamo appena entrati si presenta come la più devastante dalla Grande Depressione del 1929.
Gli economisti lo confessano chiaramente: l’attuale “congiuntura” è “la più difficile da parecchi decenni”, ha annunciato il 4 agosto HSBC, la “più grande banca del mondo”[2]. “Siamo di fronte ad uno dei climi economici e di politica monetaria più difficili mai visti” ha rilanciato il presidente della Banca Federale Americana (FED) il 22 agosto[3].
Del resto la stampa internazionale non si è ingannata, paragonando continuamente il periodo attuale al marasma economico degli anni 1930, come nel caso della copertina del Time che annunciava “The New Hard Times”, i nuovi tempi duri, su una foto di operai del 1929 che andavano a mangiare una zuppa calda alla mensa popolare. Ed infatti, tali scene si ripetono di nuovo: le associazioni di carità che distribuiscono pasti sono strapiene, mentre in numerosi paesi, file di attesa di parecchie centinaia di lavoratori disoccupati si formano ogni giorno davanti agli appositi uffici per cercare un lavoro.
E che dire dell’intervento teletrasmesso il 24 settembre 2008 di George W. Bush, Presidente degli Stati Uniti: “Noi siamo nel mezzo di una grave crisi finanziaria (...) tutta la nostra economia è in pericolo. (...) Settori chiave del sistema finanziario degli Stati Uniti rischiano di crollare. (...) l’America potrebbe sprofondare nel panico finanziario, e noi assisteremmo ad uno scenario desolante. Nuove banche fallirebbero. (...) Il mercato borsistico crollerebbe ancora di più, e ciò ridurrebbe il valore del vostro conto pensione. Il valore della vostra casa cadrebbe. I pignoramenti si moltiplicherebbero. (...) Numerose imprese dovrebbero chiudere i battenti, e milioni di americani perderebbero il loro impiego. (…) Alla fine, il nostro paese potrebbe affondare in una lunga e dolorosa recessione”.
Ebbene, questo “scenario desolante” di una “lunga e dolorosa recessione” si sta realizzando, toccando non solo “il popolo americano” ma gli operai del mondo intero!
Una brutale recessione …
Dall’ormai celebre “crisi dei subprimes” dell’estate 2007, le cattive notizie economiche non smettono di susseguirsi, giorno dopo giorno.
L’ecatombe del settore bancario per il solo anno 2008 è impressionante. Hanno dovuto essere ricomprati da un concorrente, recuperati da una banca centrale o semplicemente nazionalizzati: Northern Rock, l’ottava banca inglese, Bear Stearns, (la quinta banca di Wall Street), Freddie Mac e Fannie Mae (due organismi di rifinanziamento ipotecario americano che incidono per circa 850 miliardi di dollari), Merrill Lynch, (altro fiore all’occhiello americano), HBOS (seconda banca di Scozia), AIG (American International Group, uno dei più grandi istituti assicurativi mondiali) e Dexia (organismo finanziario del lussemburghese, belga e francese). Fallimenti clamorosi e storici hanno anche contrassegnato quest’anno di crisi. A luglio, Indymac, uno dei più grossi istituti ipotecari americani, è stato posto sotto tutela delle autorità federali. Era allora il più importante istituto bancario a fallire negli Stati Uniti negli ultimi ventiquattro anni! Ma questo record non è durato a lungo. Qualche giorno più tardi la quarta banca americana, Lehman Brothers, dichiara anch’essa fallimento. Il totale dei suoi debiti raggiunge i 613 miliardi di dollari. Record battuto! Il più clamoroso fallimento di una banca americana fino ad allora, quello della Continental Illinois del 1984, si era giocato una somma sedici volte più modesta (40 miliardi di dollari). Solo dopo due settimane, nuovo record! È la volta della Washington Mutual (WaMu), la più importante cassa di risparmio degli Stati Uniti.
Dopo questa specie di infarto di ciò che costituisce il cuore stesso del capitalismo - il settore bancario - oggi è la salute dell’insieme del corpo che vacilla e deperisce; “l’economia reale” è a sua volta brutalmente colpita. Secondo l’Ufficio nazionale della ricerca economica (NBER), gli Stati Uniti sono ufficialmente in recessione dal dicembre 2007. Nouriel Roubini, l’economista attualmente più rispettato a Wall Street, pensa anche che una contrazione dell’attività dell’economia americana dell’ordine del 5 % nel 2009 e ancora del 5 % nel 2010 sia probabile[4]! Noi non possiamo sapere se ciò accadrà, ma il semplice fatto che uno degli economisti più rinomati del pianeta possa considerare un tale scenario catastrofico rivela la reale inquietudine della borghesia. L’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) prevede che tutta l’Unione Europea entrerà in recessione nel 2009. Per la Germania, la Deutsche Bank prevede una riduzione del PIL che può arrivare fino al 4%[5]! Per avere un’idea dell’ampiezza di una tale recessione, bisogna sapere che il peggiore anno dalla seconda guerra mondiale era stato il 1975, quando il PIL tedesco era diminuito “solamente” dello 0,9%. Nessun continente viene risparmiato. Il Giappone è già in recessione e la stessa Cina, questo “Eldorado capitalista”, non sfugge a questo rallentamento brutale. Risultato: la domanda è crollata ad un punto tale che tutti i prezzi, ivi compreso il petrolio, sono in caduta. In breve, l’economia mondiale va a rotoli.
... e un’ondata di povertà senza precedenti dagli anni 1930
La prima vittima di questa crisi è evidentemente il proletariato. Negli Stati Uniti, il degrado delle condizioni di vita è particolarmente spettacolare. Dall’estate 2007, 2,8 milioni di lavoratori, non potendo rimborsare i loro crediti, si sono ritrovati in mezzo ad una strada. Secondo l’Associazione dei banchieri ipotecari, MBA, oggi, potenzialmente, quasi uno su dieci dei mutuatari immobiliari americani è minacciato di sfratto. E questo fenomeno comincia a colpire anche l’Europa, in particolare la Spagna e la Gran Bretagna.
Anche i licenziamenti si moltiplicano. In Giappone, la Sony ha annunciato un piano senza precedenti di 16.000 licenziamenti di cui 8.000 salariati a contratto a tempo indeterminato (CDI). Questo gruppo emblematico dell’industria giapponese non aveva mai licenziato impiegati con CDI. Il settore edile, con la crisi immobiliare, va a rilento. Il settore dell’edilizia e dei lavori pubblici in Spagna si aspetta di perdere 900.000 impieghi da ora al 2010! Per le banche, è un vero gioco al massacro. Citigroup, una delle più grandi banche del mondo, si appresta a sopprimere 50.000 posti di lavoro dopo che, dall’inizio del 2008, ne ha già eliminato 23.000! Nel 2008, solo in questo settore, sono stati soppressi negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna 260000 impieghi. Ora, un impiego nella finanza genera in media quattro impieghi diretti. Il crollo degli organismi finanziari significa dunque la disoccupazione per centinaia di migliaia di famiglie operaie. Altro settore particolarmente toccato è quello dell’automobile. Quest’autunno le vendite di veicoli sono crollate dovunque per oltre il 30%. Renault, primo costruttore francese, ha praticamente fermato la sua produzione da metà novembre; dalle sue fabbriche non esce più un’automobile e i suoi impianti girano già da mesi al 54% delle loro capacità. Toyota, nelle sue officine in Giappone, sta per sopprimere 3.000 impieghi temporanei su 6.000 (il 50%!). Ma, ancora una volta, è dagli Stati Uniti che giungono le notizie più allarmanti: le famose Big Three di Detroit (Generale Motors, Ford e Chrysler) sono sull’orlo del fallimento. La copertura di 15 miliardi di dollari versati dallo Stato americano non basterà a portarle fuori dai guai in maniera durevole[6] (le Big Three del resto avevano chiesto almeno 34 miliardi). Delle ristrutturazioni massicce avranno luogo necessariamente nei mesi a venire. Sono minacciati dai 2,3 a 3 milioni di impieghi. E qui, gli operai licenziati, insieme al loro impiego, perderanno anche l’assicurazione contro le malattie e la pensione!
L’inesorabile conseguenza di questa distruzione massiccia di impieghi è evidentemente l’esplosione della disoccupazione. In Irlanda, il “modello economico dell’ultimo decennio”, il numero di disoccupati è più che raddoppiato in un anno, e ciò rappresenta il più forte rialzo mai registrato! La Spagna chiude l’anno con 3,13 milioni di disoccupati, circa 1 milione in più rispetto al 2007[7]. Negli Stati Uniti, 2,6 milioni di impieghi sono stati cancellati nel 2008, cosa mai vista dal 1945[8]. Il fine anno è stato particolarmente disastroso con più di 1,1 milioni di posti persi tra novembre e dicembre. A questo ritmo, potrebbero aversi ancora 3 o 4 milioni di disoccupati in più da qui all’inizio dell’estate 2009.
E per gli scampati, quelli che vedono licenziati i loro colleghi, l’avvenire è “lavorare molto più per guadagnare molto meno”[9]. Così, secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT), intitolato “Rapporto mondiale sui salari 2008/09”, “Per 1,5 miliardi di salariati nel mondo, si profilano tempi difficili”, “la crisi economica mondiale dovrebbe determinare dolorosi tagli di salari”.
Inevitabilmente, il risultato atteso da tutti questi attacchi è un innalzamento considerevole della miseria. Dall’Europa agli Stati Uniti, tutte le associazioni caritatevoli hanno constatato in questi ultimi mesi un aumento di almeno il 10 % di affluenza alla mensa popolare. Quest’ondata di povertà significa che alloggiare, curarsi e nutrirsi diventa sempre più difficile. Ciò significa anche per i giovani di oggi che questo mondo capitalista non ha più avvenire da offrire loro!
Come la borghesia spiega questa crisi
I meccanismi economici che hanno generato l’attuale recessione cominciano ad essere relativamente conosciuti. La televisione ci ha propinato servizi che rivelano, secondo loro, tutte i retroscena del problema. Per semplificare, per anni, il consumo delle “famiglie americane” (detto diversamente, delle famiglie operaie) è stato sostenuto artificialmente da ogni sorta di credito, in particolare, un credito dal successo fulmineo: i mutui ipotecari a rischio o “subprimes”. Le banche, le istituzioni finanziarie, i fondi di pensione … tutti prestavano senza preoccuparsi della capacità reale di questi operai di rimborsare (da cui “a rischio”) purché avessero un bene immobiliare (da cui “ipotecario”). Nella peggiore delle ipotesi, pensavano, sarebbero stati risarciti dalla vendita delle case pignorate dei debitori che non fossero riusciti a sdebitarsi. Si è determinato allora un effetto a valanga: più gli operai chiedevano prestiti - principalmente per acquistare casa - più l’immobiliare si quotava; più l’immobiliare si quotava, più gli operai potevano chiedere prestiti. Tutti gli speculatori del pianeta sono allora entrati in ballo: anch’essi si sono messi ad acquistare case per rivenderle poi ad un prezzo maggiore e, soprattutto, si sono venduti gli uni con gli altri questi famosi subprimes attraverso le “titolarizzazione” (cioè la trasformazione dei crediti in valori mobiliari scambiabili sul mercato mondiale come le altre azioni ed obbligazioni). In un decennio, la bolla speculativa è diventata enorme; tutte le istituzioni finanziarie del pianeta hanno realizzato questo tipo di operazione a livello di migliaia di miliardi di dollari. In altre parole, famiglie che si sapevano come insolvibili sono diventate le galline dalle uova d’oro dell’economia mondiale.
Evidentemente, l’economia reale ha finito per ricordare a tutto questo bel mondo la dura realtà. Nella “vita reale”, tutti questi operai super indebitati hanno dovuto fare i conti anche con l’innalzamento del costo della vita ed il blocco dei salari, i licenziamenti, la riduzione dei sussidi di disoccupazione … In una parola, si sono impoveriti così tanto che una parte sempre più numerosa di loro effettivamente non è riuscita a fare fronte alle scadenze del loro prestito. I capitalisti hanno allora cacciato con la forza i cattivi pagatori per rivendere i beni immobiliari … ma le case messe in vendita sono state così numerose[10] che i prezzi hanno cominciato a calare e … patatrac ... sotto il sole estivo del 2007, la grossa palla di neve si è sciolta di colpo! Le banche si sono ritrovate con centinaia di migliaia di debitori insolvibili ed altrettante case che non valevano più niente. Ecco il fallimento, il crac.
Così riassunto, tutto ciò può sembrare assurdo. Prestare a persone che non hanno i mezzi per rimborsare va contro il buonsenso capitalista. E tuttavia, l’economia mondiale ha basato l’essenziale della sua crescita dell’ultimo decennio su un’azione così fumosa. La domanda è dunque perché? Perché una tale follia? La risposta data dai giornalisti, dai politici, dagli economisti è semplice ed unanime: è colpa degli speculatori! È colpa della cupidigia dei “padroni mascalzoni”! È colpa dei “banchieri irresponsabili”! Oggi, tutto riprendono in coro il ritornello tradizionale della sinistra e dell’estrema sinistra del capitale sulle malefatte della “dérégulation” e del “neo-liberismo” (una specie di liberismo senza freni) e reclamano un ritorno dello Stato… ciò che del resto rivela la vera natura dei propositi “anti-capitalisti” della sinistra e dell’estrema sinistra del capitale. Così, Sarkozy proclama che “il capitalismo deve rifondarsi su delle basi etiche”. La Signora Merkel insulta gli speculatori. Zapatero punta il dito accusatore sui “fondamentalisti del mercato”. E Chavez, l’illustre paladino del “socialismo del XXI secolo”, commenta le misure di nazionalizzazione di urgenza prese da Bush dicendo: “Il compagno Bush sta prendendo delle misure tipiche del compagno Lenin”[11]. Tutti ci dicono che oggi la speranza è riposta in un “altro capitalismo”, più umano, più morale … più statalista!
Menzogne! Tutto ciò che esce dalla bocca di questi politici è falso, a cominciare dalla loro pretesa spiegazione della recessione.
L’attuale catastrofe economica è il frutto di cento anni di decadenza
In realtà, è lo stesso Stato che, per primo, ha organizzato questo indebitamento generalizzato delle case. Per sostenere artificialmente l’economia, gli Stati hanno aperto tutte le porte del credito riducendo i tassi d’interesse delle banche centrali. Queste banche di Stato, concedendo prestiti a basso costo, talvolta a meno dell’1%, hanno permesso al denaro di scorrere a cascate. L’indebitamento mondiale è stato dunque il risultato di una scelta deliberata della borghesia e non di una qualsiasi “dérégulation”. Come comprendere altrimenti la dichiarazione di Bush all’indomani dell’11 settembre 2001 quando, di fronte ad un inizio di recessione, ha lanciato un appello agli operai: “Siate dei buoni patrioti, consumate”. Il Presidente americano lanciava in tal modo un messaggio chiaro a tutta la sfera finanziaria: moltiplicate i crediti per il consumo altrimenti l’economia nazionale crollerà![12]
In verità, sono decenni che il capitalismo sopravvive in questo modo, a credito. Il grafico della figura 1[13], che rappresenta l’evoluzione del debito totale americano dal 1920 - e cioè il debito dello Stato, delle imprese e delle famiglie - parla da solo. Per comprendere l’origine di questo fenomeno ed andare al di là della spiegazione semplicistica e fraudolenta della “follia dei banchieri, degli speculatori e dei padroni”, bisogna penetrare “nel grande segreto della società moderna”: “la produzione di plusvalore”[14], secondo i termini di Marx.
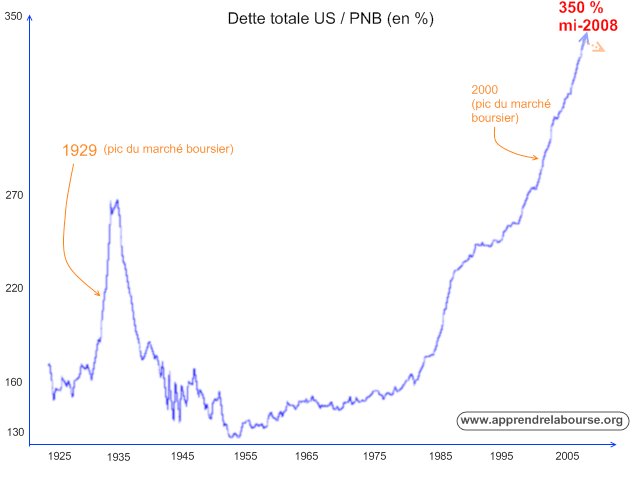
Il capitalismo porta in sé, da sempre, un tipo di malattia congenita: produce una tossina in abbondanza che il suo organismo non riesce ad eliminare, la “sovrapproduzione”. In effetti, esso produce più merci di quante il suo mercato riesca ad assimilare. Perché? Facciamo un esempio completamente teorico: un operaio che lavora su una catena di montaggio o dietro un computer e che, alla fine del mese, è pagato 800 euro. In effetti, egli ha prodotto non per l’equivalente di 800 euro - che è quello che lui riceve - ma per il valore di 1200 euro. Ha effettuato un lavoro non pagato o, detto diversamente, un plus-valore. Che fa il capitalista dei 400 euro che ha rubato all’operaio (sempre che riesca a vendere la merce)? Ne mette una parte nella sua tasca, ammettiamo 150 euro, e i 250 euro che restano li reinveste nel capitale della sua impresa, spesso sotto forma d’acquisto di macchine più moderne, ecc. Ma perché il capitalista si comporta in questo modo? Perché non ha la scelta. Il capitalismo è un sistema concorrenziale, bisogna vendere i prodotti meno cari del vicino che fabbrica lo stesso tipo di prodotti. Di conseguenza il padrone è costretto non solo ad abbassare i costi della sua produzione, e cioè i salari[15], ma anche ad utilizzare una parte crescente del lavoro non pagato per reinvestirlo prioritariamente in macchine a prestazioni migliori[16] per aumentare la produttività. Se non lo facesse, non potrebbe modernizzarsi e, prima o dopo, i suoi concorrenti - che invece lo avessero fatto - venderebbero a minor prezzo imponendosi sul mercato. Il sistema capitalista è dunque minato da un fenomeno contraddittorio: non retribuendo gli operai con l’equivalente di ciò che hanno effettivamente fornito come lavoro e costringendo i padroni a rinunciare al consumo di una gran parte del profitto così estorto, il sistema produce più valore di quanto ne possa distribuire. Mai, dunque, né gli operai né i capitalisti insieme potranno da soli assorbire tutte le merci prodotte. Chi potrà consumare questo surplus di merci? Questo sistema deve trovare necessariamente nuovi sbocchi all’infuori del contesto della produzione capitalista, ossia quelli che si chiamano mercati extra-capitalisti (ovvero in quei settori sociali che non funzionano in modo capitalista).
È perciò che, nel 18° secolo e soprattutto nel 19°, il capitalismo è partito alla conquista del mondo: doveva trovare continuamente dei nuovi mercati, dei nuovi sbocchi, in Asia, in Africa, in Sud America, per realizzare profitto vendendo le sue merci in esubero, per evitare di assistere alla paralisi della sua economia. E, d’altra parte, è sistematicamente questo che avveniva quando non riusciva abbastanza rapidamente ad ottenere nuove conquiste. Il Manifesto comunista del 1848 di Marx-Engels fa una descrizione magistrale di questo tipo di crisi: “Nelle crisi scoppia una epidemia sociale che in tutte le epoche anteriori sarebbe apparsa un assurdo: l’epidemia della sovrapproduzione. La società si trova all’improvviso ricondotta ad uno stato di momentanea barbarie; sembra che una carestia, una guerra generale di sterminio le abbiano tagliato tutti i mezzi di sussistenza; l’industria, il commercio sembrano distrutti. E perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio”. In quest’epoca, tuttavia, poiché il capitalismo era in piena crescita, poteva giustamente conquistare nuovi territori, ogni crisi lasciava in seguito il posto ad un nuovo periodo di prosperità. “Il bisogno di uno smercio sempre più esteso per i suoi prodotti sospinge la borghesia a percorrere tutto il globo terrestre. Dappertutto deve annidarsi, dappertutto deve costruire le sue basi, dappertutto deve creare relazioni (...) I bassi prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con la quale essa spiana tutte le muraglie cinesi, con la quale costringe alla capitolazione la più tenace xenofobia dei barbari. Costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe ad introdurre in casa loro la cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola, essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza.” (Il Manifesto). Ma già in quel momento, Marx percepiva in queste crisi periodiche qualche cosa di più di un semplice ciclo eterno che finirebbe sempre in prosperità. Lui ci vedeva l’espressione delle contraddizioni profonde che minano il capitalismo. “Con quale mezzo la borghesia supera la crisi? Da un lato, con la distruzione coatta di una massa di forze produttive; dall’altro, con la conquista di nuovi mercati e con lo sfruttamento più intenso dei vecchi. Dunque, con quali mezzi? Mediante la preparazione di crisi più generali e più violente e la diminuzione dei mezzi per prevenire le crisi stesse.” (idem). Ancora, in Lavoro Salariato e Capitale Marx aggiunge: “nella misura in cui la massa della produzione, cioè il bisogno di estesi mercati, diventa più grande, il mercato mondiale sempre più si contrae, i nuovi mercati da sfruttare si fanno sempre più rari, poiché ogni crisi precedente ha già conquistato al commercio mondiale un mercato fino ad allora non conquistato o sfruttato dal commercio soltanto in modo superficiale”.
Durante tutto il 18° ed il 19° secolo, le principali potenze capitaliste si lanciano in una vera corsa alla conquista del mondo; si dividono progressivamente il pianeta in colonie e formano veri imperi. Ogni tanto, si ritrovano faccia a faccia a mettere gli occhi sullo stesso territorio, e allora scoppia una breve guerra, e lo sconfitto parte rapidamente per trovare un altro angolo della terra da conquistare. Ma all’inizio del 20° secolo, le grandi potenze si sono ormai diviso il dominio di tutto il mondo, per loro quindi non è più il tempo di correre in Africa, in Asia o in America, ma di impegnarsi in una guerra spietata per difendere le loro aree di influenza ed impossessarsi, a forza di cannoni, di quelle dei loro concorrenti imperialisti. A questo punto si tratta di una vera questione di sopravvivenza per le nazioni capitaliste che devono scaricare imperativamente la loro sovrapproduzione sui mercati non capitalisti (ormai esauriti). Non è un caso che sia proprio la Germania che, avendo pochissime colonie, si mostra la più aggressiva e che, nel 1914, scatena la Prima Guerra mondiale. Questa carneficina provocò più di 11 milioni di morti, orribili sofferenze e causò un trauma morale e psicologico ad intere generazioni. Questo orrore annuncia l’entrata in una nuova epoca, l’epoca più barbara della storia. Da allora, il capitalismo, avendo raggiunto il suo apogeo, entra nel suo periodo di decadenza. Il crac del 1929 ne sarà una chiara conferma.
E tuttavia, dopo più di cent’anni di lenta agonia, questo sistema è sempre in piedi, barcollante, malmesso, ma in piedi. Come fa a sopravvivere? Come mai il suo organismo non è ancora totalmente paralizzato dalla tossina della sovrapproduzione? È qui che il ricorso all’indebitamento entra in gioco. L’economia mondiale è riuscita ad evitare un crollo clamoroso ricorrendovi sempre più massicciamente.
Come mostra la figura 1, fin dall’inizio del 20° secolo, il debito totale americano è fuori controllo per esplodere letteralmente negli anni ‘20. Le famiglie, le imprese e le banche crollano sotto i debiti. E la caduta brutale della curva dell’indebitamento negli anni ‘30 e ‘40 è in realtà ingannevole. Infatti, la grande Depressione degli anni 1930 rappresenta la prima grande crisi economica della decadenza. La borghesia non era ancora preparata ad un tale shock. Innanzitutto non reagisce, se non male. Chiudendo le sue frontiere (protezionismo) accentuò la sovrapproduzione, la tossina provocò delle devastazioni. Tra il 1929 ed il 1933, la produzione industriale americana crollò della metà[17]; la disoccupazione colpì 13 milioni di operai e si sviluppò una miseria senza precedenti, due milioni di americani si ritrovarono senza riparo[18]. In un primo tempo, il governo non intervenne a favore del settore finanziario: delle 29.000 banche censite nel 1921, non resteranno più di 12.000 alla fine del mese di marzo 1933, e questa ecatombe proseguirà ancora fino al 1939[19]. Tutti questi fallimenti sono sinonimi della scomparsa pura e semplice di montagne di debiti[20]. Per contro, ciò che non appare su questo grafico, è la crescita dell’indebitamento pubblico. Dopo quattro anni di attendismo, alla fine lo Stato americano prese delle misure: il New Deal di Roosevelt. E in che cosa consisté questo piano di cui si parla tanto oggigiorno? Si trattò di una politica di grande lavori basati su … un ricorso massiccio ed inedito all’indebitamento statale (da 17 miliardi nel 1929, il debito pubblico passò a 40 miliardi nel 1939[21]).
In seguito, la borghesia ha tratto le lezioni da questa disavventura. Alla fine della Seconda Guerra mondiale, organizzò a livello internazionale delle istituzioni monetarie e finanziarie (attraverso la conferenza di Bretton Woods) e, soprattutto, regolò il ricorso al credito. Così, dopo avere raggiunto un livello minimo nel 1953-1954 e malgrado la breve tregua degli anni 1950 e 1960[22], il debito totale americano ricominciò lentamente ma inesorabilmente ad aumentare fin dalla metà degli anni 1950. E quando la crisi fece il suo grande ritorno nel 1967, la classe dominante non aspettò questa volta quattro anni per reagire. Immediatamente, ricorse ai crediti. Infatti, questi ultimi quaranta anni possono in effetti riassumersi in una successione di crisi ed in un innalzamento esponenziale del debito mondiale. Negli Stati Uniti, ufficialmente si sono avute recessioni nel 1969, 1973, 1980, 1981, 1990 e 2001[23]. La soluzione utilizzata dalla borghesia americana per fare fronte ogni volta a queste difficoltà è nettamente visibile sul grafico: la pendenza dell’indebitamento si accentua notevolmente a partire dal 1973 e smisuratamente a partire dagli anni 1990. Tutte le borghesie del mondo hanno agito allo stesso modo.
Ma l’indebitamento non è una soluzione magica. La figura 2[24] mostra che, dal 1966, l’indebitamento è sempre meno efficace per generare crescita[25]. Si tratta di un circolo vizioso: i capitalisti producono più merci rispetto alle possibilità del mercato di assorbirle normalmente; poi, il credito crea un mercato artificiale; i capitalisti vendono dunque le loro merci e reinvestono così il loro profitto nella produzione e dunque … punto e da capo, occorrono nuovi crediti per vendere nuove merci. Qui non solo i debiti si accumulano ma, ad ogni nuovo ciclo, i nuovi debiti devono essere sempre più importanti per mantenere un tasso di crescita identico (poiché la produzione si è allargata). Inoltre, una parte sempre più grande dei crediti non è iniettata mai nel circuito della produzione ma sparisce subito, inghiottita dal baratro dei deficit. In effetti, le famiglie super indebitate contraggono spesso un nuovo prestito per rimborsare i loro debiti più vecchi. Gli Stati, le imprese e le banche funzionano allo stesso modo. Infine, in questi ultimi 20 anni, essendo “l’economia reale” continuamente in crisi, una parte crescente del denaro creato è andato ad alimentare le bolle speculative (la bolla Internet, Telecom, dell’immobiliare …)[26]. Infatti, è stato più redditizio ed alla fine meno rischioso speculare in Borsa che investire nella produzione di merci che trovano notevoli difficoltà ad essere vendute. Oggigiorno il denaro che circola in Borsa è cinquanta volte superiore a quello che circola nella produzione[27].
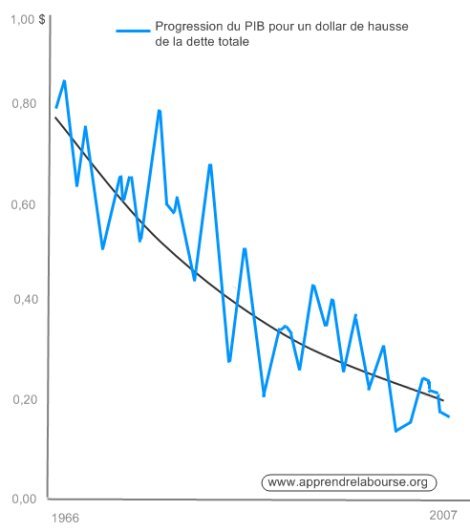
Ma questa fuga in avanti nell’indebitamento non è solo meno efficace, ma soprattutto sfocia inesorabilmente e sistematicamente in una crisi economica devastante. Il capitale non può indefinitamente tirare fuori denaro dal suo cappello. È l’abc del commercio: ogni debito deve un giorno essere rimborsato, pena il rischio per il prestatore di serie difficoltà che vanno fino al fallimento. Torniamo dunque, in qualche modo, al caso di partenza, il capitale ha guadagnato solo del tempo di fronte alla sua crisi storica. Ma peggio! Rinviando gli effetti della sua crisi nel futuro, ha preparato in realtà ogni volta convulsioni economiche ancora più violente. Ed è proprio questo quello che capita oggi al capitalismo!
Lo Stato può salvare l’economia capitalista?
Quando un individuo fallisce, perde tutto ed è gettato per strada. L’impresa chiude i battenti. Ma uno Stato? Uno Stato può fallire? Dopo tutto, non abbiamo mai visto uno Stato “chiudere bottega”. Non esattamente, infatti. Ma essere insolvente, si!
Nel 1982, quattordici paesi africani super indebitati sono stati costretti a dichiararsi ufficialmente insolventi. Negli anni 1990, dei paesi del Sud America e la Russia sono crollati. Recentemente, nel 2001, anche l’Argentina è crollata. In realtà, questi Stati non hanno smesso di esistere, e neanche l’economia nazionale si è fermata. Invece, ogni volta, c’è stato una specie di sisma economico: il valore della moneta nazionale è crollato, i prestatori (in generale altri Stati) hanno perso tutto o parte del loro investimento e, soprattutto, lo Stato ha ridotto drasticamente le sue spese licenziando una buona parte di lavoratori statali e non pagando per un certo tempo quelli che rimanevano in servizio.
Oggi, numerosi paesi sono sull’orlo di un tale baratro: l’Equador, l’Islanda, l’Ucraina, la Serbia, l’Estonia... Ma che ne è delle grandi potenze? Il governatore della California, Arnold Schwarzenegger, ha dichiarato a fine dicembre che il suo Stato si trova in “una condizione di emergenza fiscale”. Il più ricco degli Stati americani, il “Golden State”, si prepara a licenziare una buona parte dei suoi 235.000 impiegati (i rimanenti dovranno prendere due giorni di ferie non pagate ogni mese a partire dal 1 febbraio 2009)! Presentando questo nuovo bilancio, l’ex star di Hollywood ha avvertito che “ciascuno dovrà fare dei sacrifici”. Sta qua un simbolo forte delle difficoltà economiche profonde della prima potenza mondiale. Siamo ancora lontani da una cessazione dei pagamenti da parte dello Stato americano, ma questo esempio mostra chiaramente che i margini di manovra finanziari sono attualmente molto limitati per l’insieme delle grandi potenze. L’indebitamento mondiale sembra arrivare a saturazione (nel 2007 era di 60.000 miliardi di dollari e successivamente si è ancora gonfiato di parecchie migliaia di miliardi); costretta a proseguire per questa strada, la borghesia va dunque a provocare delle scosse economiche devastanti. La FED ha abbassato i suoi tassi di interesse per l’anno 2009 allo 0,25% per la prima volta dalla sua creazione nel 1913! Lo Stato americano presta dunque denaro quasi gratuitamente (e se si tiene in conto l’inflazione ci perde pure). Tutti gli economisti del pianeta richiedono un “nuovo New Deal”, sognando di vedere in Obama il nuovo Roosevelt, capace di rilanciare l’economia, come nel 1933, attraverso un immenso piano di grande lavori pubblici finanziati … a credito[28]. Piani di indebitamento statale tipo New Deal la borghesia ne lancia regolarmente dal 1967, senza un reale successo. Ed il problema sta nel fatto che una tale politica di fuga in avanti può provocare il crollo del dollaro. Oggi, infatti, sono numerosi i paesi a dubitare della capacità degli Stati Uniti di far fronte un giorno ai loro debiti e ad essere tentati di ritirare tutti i loro investimenti. Per esempio la Cina, a fine 2008, ha minacciato, in linguaggio diplomatico, lo Zio Sam di smettere di sostenere l’economia americana attraverso l’acquisto dei suoi Buoni del Tesoro: “Ogni errore sulla gravità della crisi causerebbe delle difficoltà ai mutuatari come ai creditori. L’appetito apparentemente crescente del paese per i buoni del Tesoro americano non implica che essi resteranno un investimento redditizio a lungo termine o che il governo americano continuerà a dipendere dai capitali stranieri”. Ed ecco come, in una frase, la Cina minaccia lo Stato americano di tagliare la pompa ai dollari cinesi che alimenta l’economia statunitense da parecchi anni! Se La Cina mettesse in pratica la sua minaccia[29], il disordine monetario internazionale che ne seguirebbe sarebbe allora apocalittico e le devastazioni sulle condizioni di vita della classe operaia sarebbero gigantesche. Ma non è solo l’Impero di Mezzo che comincia a dubitare: mercoledì 10 dicembre, per la prima volta della sua storia, lo Stato americano ha dovuto penare parecchio per trovare acquirenti per un prestito di 28 miliardi di dollari. E poiché tutte le grandi potenze hanno le casse vuote, conti aperti con debiti interminabili ed una economia in misera salute, lo stesso giorno, la stessa disavventura ha colpito lo Stato tedesco: anche questo, per la prima volta dagli anni 1920, ha avuto le peggiori difficoltà a trovare degli acquirenti per un prestito di 7 miliardi di euro.
Indubbiamente l’indebitamento, che riguardi le famiglie, le imprese o gli Stati, è soltanto un palliativo; non guarisce il capitalismo della malattia di sovrapproduzione; permette tutto al più di fare uscire momentaneamente l’economia da un momento difficile ma prepara sempre delle crisi successive più violente. Tuttavia, la borghesia non può che perseguire questa politica disperata perché non ha altra scelta, come dimostra, un’ennesima volta, la dichiarazione dell’8 novembre 2008 di Angela Merkel alla Conferenza Internazionale di Parigi: “Non esiste nessuna altra possibilità di lottare contro la crisi che accumulare montagne di debiti” o ancora l’ultimo intervento del capo economista del FMI, Olivier Blanchard: “Siamo in presenza di una crisi di un’ampiezza eccezionale la cui principale componente è un crollo della domanda […] È imperativo rilanciare […] la domanda privata, se si vuole evitare che la recessione si trasformi in Grande Depressione”. Come? “attraverso l’aumento delle spese pubbliche”.
Ma, se non attraverso i suoi piani di rilancio, lo Stato può essere comunque IL salvatore nazionalizzando grande parte dell’economia, in particolare le banche ed il settore automobilistico? Ebbene no, ancora cilecca! Innanzitutto, e contrariamente alle menzogne tradizionali della sinistra e dell’estrema sinistra del capitale, le nazionalizzazioni non sono mai state una buona notizia per la classe operaia. All’indomani della Seconda Guerra mondiale, l’importante ondata di nazionalizzazioni aveva per obiettivo di rimettere in piedi l’apparato produttivo distrutto aumentando i ritmi di lavoro. Non bisogna dimenticare le parole di Thorez, Segretario generale del Partito Comunista francese ed allora vice presidente del governo diretto da De Grulle, lanciate alla classe operaia in Francia ed in particolare agli operai delle imprese pubbliche: “Se dei minatori devono morire sul lavoro, le loro donne li sostituiranno”, o “Rimboccatevi le maniche per la ricostruzione nazionale!” o ancora “lo sciopero è l’arma dei trust”. Benvenuti nel mondo meraviglioso delle imprese nazionalizzate! Non c’è qui niente di stupefacente. I comunisti rivoluzionari hanno sempre messo in evidenza, dall’esperienza della Comune di Parigi del 1871, il ruolo visceralmente anti-proletario dello Stato: “Lo stato moderno, qualunque ne sia la forma, è una macchina essenzialmente capitalista: lo Stato dei capitalisti, il capitalista collettivo ideale. Più fa passare nella sua proprietà forze produttive, più diventa in effetti capitalista collettivo, più sfrutta dei cittadini. Gli operai restano dei salariati, dei proletari. Il rapporto capitalista non è soppresso, è spinto al contrario al suo colmo”. (F. Engels en 1878)[30].
La nuova ondata di nazionalizzazioni non porterà dunque niente di buono alla classe operaia. E non permetterà neanche alla borghesia di riprendere una vera crescita duratura. Al contrario! Queste nazionalizzazioni annunciano delle future burrasche economiche ancora più violente. Infatti, nel 1929, le banche americane fallite sono sprofondate insieme ai depositi di gran parte della popolazione americana, spingendo nella miseria milioni di operai. Da allora, per evitare che un tale crollo possa riprodursi, il sistema bancario è stato diviso in due: da un lato le banche di affari che finanziano le imprese e che lavorano sulle operazioni finanziarie di ogni tipo, dall’altro le banche di deposito che ricevono il denaro dei depositanti e che se ne servono relativamente per gli investimenti sicuri. Ora, rese nervose dall’ondata di fallimenti del 2008, queste banche di affari americane non esistono più. Il sistema finanziario americano si è ricomposto come prima del 24 ottobre 1929! Alla prossima burrasca, tutte le banche “scampate” grazie alle nazionalizzazioni parziali o totali, rischiano a loro volta di sparire e questa volta insieme alle magre economie ed ai salari delle famiglie operaie. Oggi, se la borghesia nazionalizza, non è dunque per effettuare un qualsivoglia nuovo piano di rilancio economico ma per evitare l’insolvenza immediata dei colossi della finanza o dell’industria. Si tratta di evitare il peggio, di salvare il salvabile[31].
La montagna di debiti accumulati durante quattro decenni si è trasformata in un vero Everest ed oggi niente può impedire al capitale di precipitare giù precipitosamente. Lo Stato dell’economia è realmente disastroso. Tuttavia, non bisogna credere che il capitalismo affonderà di colpo. La borghesia non lascerà il SUO mondo sparire senza reagire; tenterà disperatamente e con tutti i mezzi di prolungare l’agonia del suo sistema, senza preoccuparsi dei mali inflitti all’umanità. La sua folle fuga in avanti verso un indebitamento sempre più elevato proseguirà e probabilmente ci saranno anche in futuro, qua e là, dei brevi momenti di ritorno alla crescita. Ma ciò che è certo, è che la crisi storica del capitalismo ha cambiato ritmo. Dopo quaranta anni di lenta discesa agli inferi, l’avvenire si preannuncia con dei soprassalti violenti, spasmi economici ricorrenti che spazzano via non solo i paesi del Terzo Mondo ma anche gli Stati Uniti, l’Europa, l’Asia …[32].
Il motto dell'Internazionale comunista del 1919 “Perché l’umanità possa sopravvivere, il capitalismo deve morire!” è più che mai attuale.
Mehdi (10 gennaio 2009)
[1] Rispettivamente: Paul Krugman (ultimo premio Nobel per l’economia), Warren Buffet (investitore americano, soprannominato “l’oracolo di Omaha” tanto l’opinione del miliardario della piccola cittadina americana del Nebraska è rispettata dal mondo finanziario), Jaques Attali (economista e consigliere dei presidenti francesi Mitterrand e Sarkozy) e Laurence Parisot (presidentessa dell'associazione dei padroni francesi).
[2] Libération del 4.08.08.
[3] Le Monde del 22.08.08.
[4] Fonte: www.contreinfo.info [3].
[5] Les Echos del 05.12.08.
[6] Questo denaro è stato trovato nelle casse del piano Paulson, tuttavia già insufficiente per il settore bancario. La borghesia americana è obbligata a “svestire Paul per vestire Jack”, ciò che rivela anche lì lo stato disastroso delle finanze della prima potenza mondiale.
[7] Les Echos dell’08.01.09.
[8] Secondo il rapporto pubblicato il 9 gennaio dal Dipartimento del Lavoro americano, (Les Echos del 09.01.09).
[9] In Francia, il presidente Nicolas Sarkozy aveva condotto la campagna nel 2007 usando come principale slogan “Lavorare di più per guadagnare di più” (sic!).
[10] Nel 2007, circa tre milioni di famiglie americane sono in condizioni di non poter pagare (in Subprime Mortgage Foreclosures by the Numbers - www.americanprogress.org/issues/economy/news/2007/03/26/2744/subprime-mortgage-foreclosures-by-the-numbers [4]).
[11] Per una volta, siamo d’accordo con Chavez. Bush è effettivamente un suo compagno. Anche se sono contrapposti nella lotta accanita delle loro rispettive nazioni imperialiste, non per questo sono meno compagni nella difesa del capitalismo e dei privilegi della loro classe … la borghesia.
[12] Oggi, Alan Greenspan, l'ex-presidente della FED e capofila di questa economia a credito, è attaccato violentemente da tutti gli economisti e da altri esperti di questa materia. Tutto questo bel mondo ha la memoria molto corta e dimentica rapidamente che solo poco tempo fa lo portava alle stelle, soprannominandolo anche il “guru della finanza”!
[13] Fonte: eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine.
[14] Il Capitale, Libro 1, p.725, La Pléiade.
[15] O, detto diversamente, il capitale variabile.
[16] Il capitale fisso.
[17] A. Kaspi, Franklin Roosevelt, Parigi, Fayard, 1988, p.20.
[18] Queste cifre sono tanto più importanti in quanto la popolazione americana all’epoca non era che di 120 milioni. Fonte: Lester V. Chandler, America’s Greatest Depression 1929-1941, New York, Harper and Row, 1970, p.24 e successive.
[19] Da Frédéric Valloire, in Valori Attuali del 15.02.2008.
[20] Per completezza, questa caduta del debito totale si spiega anche attraverso un meccanismo economico complesso: la creazione monetaria. In effetti, il New Deal non è stato finanziato integralmente dal debito ma anche dalla pura creazione monetaria. Così il 12 maggio 1933, si autorizza il Presidente a fare aumentare i crediti delle banche federali di 3 miliardi di dollari e anche la creazione di biglietti senza contropartita in oro di 3 miliardi di $. Il 22 ottobre dello stesso anno, c’è una svalutazione del 50% dello stesso dollaro rispetto all’oro. Tutto questo spiega la relativa moderazione dei rapporti di indebitamento.
[22] Dal 1950 al 1967, il capitalismo conosce una fase di crescita importante, chiamata “i 30 Gloriosi” o “Epoca d’oro” o “Anni del boom economico”. Lo scopo di questo articolo non è di analizzare le cause di questo tipo di parentesi nel marasma economico del ventesimo secolo. Un dibattito si svolge attualmente nella CCI per comprendere meglio le motivazioni di questo periodo fausto, dibattito che abbiamo cominciato a pubblicare nella nostra stampa (leggere “Dibattito interno alla CCI: Le cause del periodo di prosperità consecutiva alla Seconda Guerra mondiale” in Revue internationale n° 133, 2° trimestre 2008). Incoraggiamo vivamente tutti i nostri lettori a partecipare a questa discussione in occasione delle nostre riunioni (permanenze, riunioni pubbliche), per posta o per mail.
[23] Fonte: www.nber.org/research/business-cycle-dating [6].
[24] Fonte: eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine.
[25] Nel 1966, un dollaro di indebitamento supplementare produceva 0,80 dollari di produzione di ricchezza in più mentre nel 2007, questo stesso dollaro non genera più di 0,20 dollari di PIL in più.
[26] Gli attivi e l’immobiliare non sono contabilizzati nel PIL.
[27] Così, contrariamente a tutto ciò che ci dicono gli economisti, giornalisti ed altri bugiardi, questa “follia speculativa” è dunque il prodotto della crisi e non l’inverso!
[28] Nel momento in cui la scrittura di quest’articolo sta per finire, Obama ha annunciato il suo piano di rilancio tanto atteso che è, a dire degli stessi economisti, “molto deludente”: vengono sbloccati 775 miliardi per permettere un “regalo fiscale” di 1000 dollari alle famiglie americane (il 95% di queste famiglie sono coinvolte) in modo che si “rimettano a spendere” e a lanciare un programma di grandi lavori nel campo dell’energia, delle infrastrutture e della scuola. Questo piano dovrebbe, promette Obama, creare tre milioni di impieghi “durante i prossimi anni”. Poiché in questo momento l’economia americana distrugge più di 500.000 impieghi al mese, questo nuovo New Deal (anche se funzionasse al meglio delle previsioni, ciò che è poco probabile) è ancora una volta veramente lontano dal cogliere l’obiettivo.
[29] Questa minaccia rivela, da sola, il vicolo cieco e le contraddizioni in cui si trova l’economia mondiale. Infatti, vendere massicciamente i suoi dollari significherebbe per la Cina segare il ramo sul quale è seduta poiché gli Stati Uniti costituiscono il principale sbocco delle sue merci. E’ per tale motivo che finora ha continuato a sostenere in grande parte l’economia americana. Tuttavia, la Cina si rende conto che questo ramo è debole, totalmente tarlato, e non ha nessuna voglia di starvi seduta fino a quando si spezzerà.
[30] Ne “L’Anti-Duhring”, Ed Sociales 1963, p.318.
[31] Così facendo, crea un terreno più propizio allo sviluppo delle lotte. Infatti, diventando il loro padrone ufficiale, gli operai avranno di fronte nella loro lotta direttamente lo Stato. Negli anni 1980, l’ondata importante di privatizzazione delle grandi imprese (con la Thatcher in Inghilterra, per esempio) aveva costituito una difficoltà supplementare per deviare la lotta di classe. Non solo gli operai erano chiamati dai sindacati a battersi per salvare le imprese pubbliche o, detto diversamente, per essere sfruttati da un padrone (lo Stato) piuttosto che da un altro (privato), ma in più essi si trovavano a scontrarsi non più con lo stesso padrone (lo Stato) ma con una serie di padroni privati differenti. Le loro lotte erano spesso sparpagliate e dunque impotenti. In avvenire, al contrario, il terreno sarà più fertile per le lotte degli operai uniti contro lo Stato.
[32] Il terreno economico è particolarmente minato, è dunque difficile sapere quale sarà la prossima bomba che esploderà. Ma nelle pagine delle riviste economiche, un nome ritorna spesso sotto la penna angosciata degli specialisti ed altri esperti in materia: i CDS. Un CDS (credit default swap) è una sorta di assicurazione attraverso la quale una istituzione finanziaria si protegge dal rischio di mancanza di pagamento di un credito pagando un premio. Il totale del mercato dei CDS era stimato a 60.000 miliardi di dollari nel 2008. Ciò significa che una crisi dei CDS sul modello della crisi dei subprimes sarebbe terribilmente devastante. In particolare affonderebbe tutti i fondi pensione americani e dunque le pensioni operaie.
Questioni teoriche:
- Economia [7]
Le cause della prosperità seguita alla Seconda Guerra mondiale (dibattito interno alla CCI)
- letto 120 volte
Nella primavera del 2005 la CCI ha aperto un dibattito interno riguardo all’analisi economica del periodo di forte crescita seguito alla Seconda Guerra mondiale (ancora oggi chiamato “I Trenta gloriosi”). Periodo che costituisce una eccezione all’interno della fase di decadenza del capitalismo dal punto di vista delle performance economiche poiché presenta il tasso di crescita più alto di tutta la storia del capitalismo[1]. Questo dibattito è scaturito dalla messa in evidenza, già precedente, di una contraddizione tra differenti testi della CCI a proposito del ruolo giocato dalla guerra rispetto alla questione cruciale dell’insufficienza di sbocchi solvibili per l’economia capitalista. Si poneva quindi una prima questione alla nostra organizzazione: le distruzioni provocate dalla guerra permettono la creazione di nuovi sbocchi? Ma questa prima questione, una volta data una risposta negativa, ne pone automaticamente un’altra: quale spiegazione coerente può essere data ai Trenta gloriosi basandosi su fattori diversi dalle distruzioni provocate dalla Seconda guerra mondiale?
Il dibattito su queste questioni è in corso e le differenti posizioni presenti sono ancora in via di definizione. Queste ultime presentano comunque un livello di elaborazione tale da poter essere già da ora pubblicate all’esterno dell’organizzazione allo scopo di alimentare il dibattito, in particolare nell’ambito degli elementi in ricerca che si orientano verso le posizioni della Sinistra Comunista.
Anche se nella realtà gli sviluppi della crisi prima e dopo la fine dei “Trenta gloriosi” hanno largamente dimostrato che questo periodo non è che un’eccezione all’interno di un secolo di decadenza del capitalismo, l’importanza delle questioni dibattute non è però da sottovalutare. In effetti queste questioni rimandano al cuore dell’analisi marxista permettendo di comprendere sia il carattere storicamente limitato del modo di produzione capitalista, che l’entrata in decadenza di questo sistema ed il carattere insolubile della crisi attuale. In altre parole esse concernono uno dei principali fondamenti obiettivi e materiali della prospettiva rivoluzionaria del proletariato.
Il contesto del dibattito: alcune contraddizioni nella nostra analisi
La rilettura critica del nostro opuscolo La decadenza del capitalism[2] ha suscitato una riflessione all’interno della nostra organizzazione ed ha dato vita ad un dibattito contraddittorio i cui termini erano stati già posti nel movimento operaio – in particolare all’interno della Sinistra comunista – e riguardano le implicazioni economiche della guerra in fase di decadenza dl capitalismo. In effetti La decadenza del capitalismo sviluppa esplicitamente l’idea che le distruzioni provocate dalle guerre della fase di decadenza, in particolare le guerre mondiali, possono costituire uno sbocco alla produzione capitalista, quello della ricostruzione:
“… gli sbocchi si sono ristretti in modo vertiginoso. A causa di ciò il capitalismo è dovuto ricorrere alla distruzione ed alla produzione dei mezzi di distruzione come palliativo per tentare di compensare le sue perdite accelerate in ‘spazio vitale’” (capitolo: Quale sviluppo delle forze produttive?. Paragrafo: La “crescita” mondiale dopo la Seconda guerra mondiale).
“Nella distruzione massiccia in vista della ricostruzione, il capitalismo scopre un’uscita pericolosa e provvisoria, ma efficace, per i suoi nuovi problemi di sbocco. Nel corso della prima guerra le distruzioni non sono state “sufficienti” (…) Dal 1929 il capitalismo mondiale è confrontato di nuovo ad una crisi.
Come se la lezione fosse stata ritenuta, le distruzioni della Seconda guerra mondiale sono molto più importanti in intensità e in estensione (…) una guerra che, per la prima volta, si pone come scopo cosciente la distruzione sistematica del potenziale industriale esistente. La “prosperità” dell’Europa e del Giappone dopo la guerra sembra già prevista sistematicamente all’indomani della guerra (Piano Marshall, ecc.)” (Paragrafo: Il ciclo guerra-ricostruzione).
Questa idea è presente anche in alcuni testi dell’organizzazione (in particolare della Rivista Internazionale) così come presso i nostri predecessori di Bilan che in un articolo intitolato “Crisi e cicli nell’economia del capitalismo agonizzante” affermano: “Da allora il massacro andrà a costituire per la produzione capitalista un immenso sbocco che apre delle “magnifiche” prospettive (…) Se la guerra è il grande sbocco della produzione capitalista, in tempo di “pace” il militarismo (in quanto insieme delle attività che preparano la guerra) realizzerà il plus-valore da produzioni fondamentali controllate dal capitale finanziario” (Bilan n. 11, settembre 1934 – ripubblicato nella Rivista Internazionale n.103, in inglese, francese e spagnolo sul nostro sito).
Per contro altri testi dell’organizzazione, apparsi prima e dopo l’opuscolo La decadenza del capitalismo, sviluppano un’analisi opposta sul ruolo della guerra in periodo di decadenza riallacciandosi in questo al “Rapporto adottato alla Conferenza del luglio 1945 della Sinistra Comunista di Francia” (Gauche Communiste de France, GCF), secondo il quale la guerra:
“fu il mezzo indispensabile al capitalismo che gli apriva delle possibilità di sviluppo ulteriori nell’epoca in cui queste possibilità esistevano e non potevano essere aperte che attraverso la violenza. Allo stesso modo, il crollo del mondo capitalista che ha storicamente esaurito ogni possibilità di sviluppo, trova nella guerra moderna, la guerra imperialista, l’espressione di questo crollo che, senza aprire alcuna possibilità di sviluppo ulteriore per la produzione, non fa che inghiottire nell’abisso le forze produttive ed accumulare a ritmo accelerato rovine su rovine” (sottolineato da noi).
Il Rapporto sul Corso storico, adottato al 3°, congresso della CCI[3], fa riferimento esplicito a questo passaggio del testo della GCF ed all’articolo “Guerra, militarismo e blocchi imperialisti nella decadenza del capitalismo” pubblicato nel 1988[4] dove si sottolinea che: “… quello che caratterizza tutte queste guerre, così come le due guerre mondiali, è che esse non mai permesso, a differenza delle guerre del secolo scorso, alcun progresso nello sviluppo delle forze produttive, ma hanno avuto come unico risultato delle distruzioni massicce che hanno lasciato completamente esangui i paesi implicati (senza contare i terribili massacri che hanno provocato)”.
Il quadro del dibattito
Per quanto importanti siano queste questioni, dato che la risposta che ne danno i rivoluzionari partecipa direttamente alla coerenza del loro quadro politico generale, conviene tuttavia precisare che esse hanno una natura diversa da certe altre che concorrono direttamente a delimitare il campo proletario da quello della borghesia, come l’internazionalismo, il ruolo antioperaio dei sindacati, la partecipazione al gioco elettorale, ecc. In altre termini, le differenti analisi in discussione sono pienamente compatibili con la piattaforma della CCI.
Se alcune idee de La decadenza del capitalismo sono state criticate e rimesse in discussione, il metodo ed il quadro globale di analisi è quello al quale si rifà la CCI sin dal momento della scrittura di questo opuscolo e che da allora ha continuato ad arricchire[5]. Ne ricordiamo gli elementi costitutivi essenziali:
1. Il riconoscimento dell’entrata del capitalismo nella sua fase di decadenza con lo scoppio della Prima Guerra mondiale all’inizio del 20° secolo e del carattere d’ora in avanti insormontabile delle contraddizioni che assillano questo sistema. Si tratta qui della comprensione delle manifestazioni e delle conseguenze politiche del cambiamento del periodo come le caratterizzava il movimento operaio a quest’epoca, in particolare quando parlava a questo proposito dell’ “era di guerre e di rivoluzioni” nella quale era ormai entrato il sistema.
2. Quando si analizza la dinamica del modo di produzione capitalista su tutto un periodo, non conviene procedere ad uno studio separato dei differenti attori capitalisti (nazioni, imprese, ecc.), ma all’entità capitalista mondiale presa nel suo insieme, la quale fornisce la chiave per comprendere le specificità per ognuna delle sue parti. Questo è anche il metodo di Marx quando, studiando la riproduzione del capitale, precisa: “Per sgomberare l’analisi generale da incidenti inutili, bisogna considerare il mondo commerciale come una sola nazione” (I libro del Capitale)
3. “Contrariamente a quanto pretendono gli adoratori del capitale, la produzione capitalistica non crea automaticamente e a volontà i mercati necessari alla sua crescita. Il capitalismo si sviluppa in un mondo non capitalista, ed è in questo mondo che trova gli sbocchi che gli permettono questo sviluppo. Ma generalizzando i suoi rapporti all’insieme del pianeta e unificando il mercato mondiale, esso ha raggiunto un grado critico di saturazione degli stessi sbocchi che gli avevano permesso la formidabile espansione del 19° secolo. Inoltre, la crescente difficoltà per il capitale a trovare mercati in cui realizzare il suo plusvalore accentua la pressione verso il ribasso che viene esercitata sul suo tasso di profitto dall’accrescimento costante della proporzione tra il valore dei mezzi di produzione e quello della forza-lavoro che li mette in opera. Da tendenziale, questa caduta del tasso di profitto diventa sempre più reale, cosa che intralcia ancor più il processo di accumulazione del capitale e dunque il funzionamento dell’insieme degli ingranaggi del sistema” (Piattaforma della CCI).
4. E’ Rosa Luxemburg che, basandosi sul lavoro di Marx e criticandone quelli che lei considerava essere delle insufficienze, mette in evidenza che l’arricchimento del capitalismo, come un tutto, dipende dalle merci prodotte al suo interno e scambiate con delle economie precapitaliste, cioè quelle che praticano lo scambio mercantile ma non hanno ancora adottato il modo i produzione capitalista: “In realtà, le condizioni reali dell’accumulazione del capitale totale sono del tutto diverse da quelle del capitale singolo e della riproduzione semplice. Il problema si pone così: come si configura la riproduzione sociale nella premessa che una parte crescente del plus-valore non sia consumato dai capitalisti ma impiegata all’allargamento della produzione? Il passaggio del prodotto sociale, prescindendo dalla sostituzione del capitale costante, nel consumo dei lavoratori e dei capitalisti, è qui escluso, e questa circostanza è il punto essenziale del problema. Ma con ciò è anche escluso che capitalisti e lavoratori possano consumare essi stessi il prodotto totale. Essi possono realizzare solo il capitale variabile, la parte consumata del capitale costante e la parte consumata del plus-valore, e, in tale modo assicurare soltanto le condizioni del rinnovo della produzione sulla scala precedente. La parte da capitalizzare del plusvalore, invece, non può essere realizzata dagli stessi lavoratori e capitalisti. La realizzazione del plus-valore ai fini dell’accumulazione è dunque, in una società composta unicamente di lavoratori e capitalisti, un problema insolubile” (Rosa Luxemburg, L’accumulazione del capitale; capitolo: La riproduzione del capitale e del suo ambiente).
La CCI fa sua questa posizione, il che non vuol dire che non possano esistere all’interno dell’organizzazione altre posizioni che criticano l’analisi economica di Rosa, come vedremo in particolare a proposito di una delle posizioni presenti nel dibattito. Del resto queste analisi sono state combattute al loro tempo non solo dalle correnti riformiste, per le quali il capitalismo non era condannato a provocare catastrofi crescenti, ma anche da alcune correnti rivoluzionarie, e non tra le minori, rappresentate in particolare da Lenin e Pannekoek, per le quali il capitalismo era diventato un modo di produzione storicamente obsoleto anche se le loro implicazioni differivano da quelle di Rosa Luxemburg.
5. Il fenomeno dell’imperialismo deriva giustamente dall’importanza che rappresenta per i paesi sviluppati l’accesso ai mercati extra-capitalisti: “L’imperialismo è l’espressione politica del processo di accumulazione del capitale nella sua lotta di concorrenza intorno ai residui di ambienti non capitalistici non ancora posti sotto sequestro” (Rosa Luxemburg, L’accumulazione del capitale; capitolo: Protezionismo e accumulazione).
6. IL carattere storicamente limitato degli sbocchi extra-capitalisti costituisce il fondamento economico della decadenza del capitalismo. La Prima Guerra mondiale è l’espressione di questa contraddizione. Conclusa la ripartizione del mondo tra le grandi potenze, le potenze meno ricche di colonie per accedere ai mercati extra-capitalisti non hanno altra scelta che intraprendere una ripartizione del mondo attraverso la forza militare. L’entrata del capitalismo nella fase di declino significa che le contraddizioni che assillano questo sistema sono ormai insormontabili.
7. La messa in opera di misure di capitalismo di Stato costituisce un mezzo che la borghesia si dà nella decadenza del capitalismo per frenare, attraverso differenti palliativi, la depressione nella crisi e attenuarne le manifestazioni più brutali al fine di evitare che queste si manifestino di nuovo con la brutalità della crisi del 1929.
8. Nel periodo di decadenza il credito costituisce un mezzo essenziale attraverso il quale la borghesia tenta di far fronte all’insufficienza di sbocchi extra-capitalisti. L’accumulazione di un debito mondiale sempre meno controllabile, l’insolvibilità crescente dei differenti attori capitalisti e le minacce di destabilizzazione profonda dell’economia mondiale che ne risulta illustrano l’impasse di questo palliativo.
9. Una manifestazione tipica della decadenza del capitalismo è data, sul piano economico, dall’impennata delle spese improduttive. Queste sono la manifestazione del fatto che lo sviluppo delle forze produttive è sempre più intralciato dalle contraddizioni insormontabili del sistema: le spese militari (armamenti, operazioni militari) per far fronte all’esacerbazione mondiale delle tensioni imperialiste; le spese per mantenere ed equipaggiare le forze di repressione per fronteggiare, in ultima istanza, la lotta di classe; la pubblicità, arma di guerra commerciale per vendere su un mercato saturo, ecc. Dal punto di vista economico queste spese costituiscono una pura perdita per il capitale.
Le posizioni emerse nel dibattito
All’interno della CCI esiste una posizione che, pur essendo d’accordo con la nostra piattaforma, è in disaccordo con numerosi aspetti del contributo di Rosa Luxemburg sui fondamenti economici della crisi del capitalismo[6]. Secondo questa posizione le basi di fondo della crisi stanno nell’altra contraddizione messa in evidenza da Marx, la caduta tendenziale del tasso di profitto. Pur rigettando le concezioni (in particolare quelle bordighiste e consiliariste) che immaginano che il capitalismo può generare automaticamente ed eternamente l’espansione del suo proprio mercato alla semplice condizione che il tasso di profitto sia sufficientemente elevato, questa posizione sottolinea che la contraddizione fondamentale del capitalismo non si situa tanto nei limiti del mercato in se stessi (cioè la forma sotto la quale si manifesta la crisi), ma piuttosto in quelli che si impongono all’espansione della produzione.
Il dibattito di fondo nella discussione di questa posizione è nei fatti quello condotto in polemica con altre organizzazioni (anche se esistono delle differenze) a proposito della caduta del tasso di profitto e della saturazione dei mercati[7]. Tuttavia, come vedremo in seguito, nella discussione attuale esiste una certa convergenza tra questa posizione ed un’altra detta del “capitalismo di Stato keynesiano-fordista” che presentiamo di seguito. Queste due posizioni riconoscono l’esistenza di un mercato interno ai rapporti di produzione capitalista che ha costituito un fattore di prosperità nel corso del periodo dei “Trenta gloriosi” ed analizzano la fine di quest’ ultima come il prodotto della contraddizione “caduta tendenziale del tasso di profitto”.
Le altre posizioni che si sono espresse nel dibattito rivendicano la coerenza sviluppata da Rosa Luxemburg, accordando alla questione dell’insufficienza dei mercati extra-capitalisti un ruolo centrale nella crisi del capitalismo. E’ proprio basandosi su questo quadro di analisi che una parte dell’organizzazione ha valutato che esistevano delle contraddizioni nell’opuscolo La decadenza del capitalismo dove, pur rivendicandosi a questo quadro, si fa derivare l’accumulazione che è stata alla base della prosperità dei Trenta gloriosi dall’apertura di un mercato, quello della ricostruzione, che non ha niente di extra-capitalista.
Di fronte a questo disaccordo si è sviluppata una posizione – presentata sotto il titolo “L’economia di guerra ed il capitalismo di Stato” – che, sebbene critica riguardo ad alcuni aspetti del nostro opuscolo (rimprovera a questo in particolare una mancanza di rigore ed una assenza di riferimento al piano Marshall per spiegare la ricostruzione propriamente detta) costituisce al fondo “una difesa dell’idea che la prosperità del periodo degli anni ‘50 e ’60 è determinata dalla situazione globale dei rapporti imperialisti e l’instaurazione di un’economia di guerra permanente seguita alla seconda guerra mondiale”.
Nella parte dell’organizzazione che rimette in causa l’analisi fatta attraverso La decadenza del capitalismo della fase dei Trenta gloriosi, esistono nei fatti due interpretazioni della prosperità di questo periodo.
La prima interpretazione, presentata qui di seguito sotto il titolo “Mercati extra-capitalisti ed indebitamento”, fa suoi e valorizza questi due fattori già avanzati dall’organizzazione in diverse tappe della sua esistenza[8]. Secondo questa posizione “questi due fattori sono sufficienti a spiegare la prosperità dei Trenta gloriosi”.
La seconda interpretazione, presentata con il titolo “Il capitalismo di Stato keynesiano-fordista”, “parte dalla stessa constatazione stabilita nel nostro opuscolo sulla decadenza – la constatazione della saturazione relativa dei mercati nel 1914 rispetto ai bisogni dell’accumulazione raggiunta a livello mondiale – e sviluppa l’idea che il sistema vi ha risposto instaurando una variane di capitalismo di Stato che si basa su una tri-ripartizione forzata (keynésianismo) di forti guadagni di produttività (fordismo) a vantaggio dei profitti, dei redditi dello Stato e dei salari reali”.
L’obiettivo di questo primo articolo circa il dibattito al nostro interno sui Trenta gloriosi è di limitarsi ad una presentazione generale di questo, come abbiamo appena fatto, e di esporre sinteticamente le tre posizioni principali che hanno alimentato la discussione[9]. In seguito saranno pubblicati dei contributi più sviluppati di dibattito tra i differenti punti di vista qui evocati o altri che potranno emergere dalla discussione.
L’economia di guerra e il capitalismo di Stato
Il punto di partenza di questa posizione è stato già esplicitato dalla Sinistra comunista di Francia nel 1945. Questa considera che a partire dal 1914 i mercati extra-capitalisti che hanno fornito al capitalismo il suo necessario campo di espansione durante il suo periodo di ascesa non sono più capaci di assolvere questo ruolo: “Questo periodo storico è quello della decadenza del sistema capitalista. Cosa significa questo? La borghesia che prima della prima guerra imperialista vive e non può vivere che in un’estensione crescente della sua produzione, è arrivata ad un punto della sua storia dove non può più, nel suo insieme, realizzare questa estensione. (…) Oggi, a parte regioni lontane inutilizzabili, a parte avanzi irrisori del mondo non capitalista, insufficienti per assorbire la produzione mondiale, essa si ritrova padrona del mondo, ma non esistono più davanti a sé paesi extra-capitalisti che avrebbero potuto costituire per il suo sistema dei nuovi mercati: così il suo apogeo è anche il punto dove comincia la sua decadenza”[10].
La storia economica dopo il 1914 è quella dei tentativi della classe borghese, in diversi paesi e in diversi momenti, di superare questo problema fondamentale: come continuare ad accumulare il plus-valore prodotto dall’economia capitalista in un mondo già spartito tra le grandi potenze imperialiste ed il cui mercato è incapace di assorbire l’insieme di questo plus-valore? E poiché le potenze imperialiste possono ormai estendersi solo a spese dei loro rivali, finita una guerra bisogna prepararsi alla seguente. L’economia di guerra diventa il modo di vita permanente della società capitalista. “La produzione di guerra non ha lo scopo di risolvere un problema economico. All’origine essa è frutto della necessità per lo Stato capitalista, da una parte, di difendersi contro le classi sfruttate e mantenere il loro sfruttamento attraverso la forza, dall’altra, di assicurare sempre con la forza le sue posizioni economiche ed allargarle a spese degli altri Stati imperialisti (…) La produzione di guerra diventa così l’asse della produzione industriale ed il principale campo economico della società” (Internationalisme, “Rapporto sulla situazione internazionale”, luglio 1945).
Il periodo della Ricostruzione –i “Trenta Gloriosi” – è un momento particolare di questa storia.
E’ necessario qui sottolineare tre caratteristiche economiche mondiali del 1945:
- In primo luogo c’è l’enorme preponderanza economica e militare degli Stati Uniti, fatto raro nella storia del capitalismo. Gli Stati Uniti da soli rappresentano la metà della produzione mondiale e detengono quasi l’80% delle riserve mondiali di oro. Sono il solo paese belligerante il cui apparato produttivo è uscito indenne dalla guerra: tra il 1940 e il 1945 il suo PIL è raddoppiato. Hanno assorbito tutto il capitale accumulato dall’impero britannico durante due secoli di espansione coloniale, più buona parte di quello dell’impero francese.
- In secondo luogo, c’è una forte coscienza tra le classi dominanti del mondo occidentale del fatto che è indispensabile elevare il livello di vita della classe operaia se si vuole evitare il pericolo di disordini sociali che possono fare il gioco degli Stalinisti e dunque del blocco imperialista avversario. L’economia di guerra integra dunque un nuovo aspetto, di cui i nostri predecessori della GCF non avevano una chiara coscienza all’epoca: l’insieme delle prestazioni sociali (sanità, assegni di disoccupazione, pensioni, ecc.) che la borghesia – e soprattutto la borghesia del blocco occidentale – mette in opera a partire dall’inizio della Ricostruzione negli anni ’40.
- In terzo luogo, il capitalismo di Stato, che prima della seconda guerra mondiale aveva espresso una tendenza all’autarchia delle differenti economie nazionali, è ora inquadrato in una struttura di blocchi imperialisti che determinano le relazioni economiche tra gli Stati (sistema Bretton Woods per il blocco americano, Comecon per il blocco russo).
Durante la Ricostruzione il capitalismo di Stato conosce una evoluzione qualitativa: il peso dello Stato nell’economia nazionale diventa preponderante[11]. Anche oggi, dopo trenta anni di presunto “liberismo”, le spese dello Stato continuano a rappresentare tra il 30 ed il 60% del PIL dei paesi industrializzati.
Questo nuovo peso dello Stato rappresenta una trasformazione da quantità a qualità. Lo Stato non è più solo il “comitato esecutivo” della classe dominante ma è anche il maggiore datore di lavoro ed il maggiore mercato. Negli Stai Uniti, da esempio, il Pentagono diventa il principale datore di lavoro del paese (3-4 milioni di persone, compresi civili e militari). In quanto tale, esso gioca un ruolo critico nell’economia e permette uno sfruttamento più a fondo dei mercati esistenti. La messa in opera del sistema Bretton Woods permette anche l’instaurazione di meccanismi di credito più sofisticati e meno fragili rispetto al passato: il credito al consumo si sviluppa e le istituzioni economiche messe in piazza dal blocco americano (FMI, Banca Mondiale, GATT) permettono di evitare crisi finanziarie e bancarie.
L’enorme preponderanza economica degli Stati Uniti ha permesso alla borghesia americana di non badare a spese per assicurare il suo dominio militare rispetto al blocco russo: ha sostenuto due guerre cruenti e costose (in Corea ed in Vietnam); i piani tipo Marshall e gli investimenti all’estero hanno finanziato la ricostruzione delle economie rovinate in Europa ed in Asia (in particolare in Corea ed in Giappone). Ma questo enorme sforzo – determinato non dal funzionamento “classico” del capitalismo ma dallo scontro imperialista che caratterizza la decadenza del sistema – ha finito per rovinare l’economia americana. Nel 1958 la bilancia dei pagamenti americana è già deficitaria e nel 1970 gli Stati Uniti hanno solo il 16% delle riserve mondiali di oro. Il sistema Bretton Woods fa acqua da tutte le parti ed il mondo si immerge in una crisi dalla quale non è più uscito fino ai nostri giorni.
I mercati extra-capitalisti e l’indebitamento
Lungi dal partecipare allo sviluppo delle forze produttive su basi comparabili a quelle dell’ascesa del capitalismo, il periodo dei Trenta Gloriosi si caratterizza per un enorme spreco di plus-valore che segnala l’esistenza di intralci allo sviluppo delle forze produttive propri della cadenza di questo sistema.
La ricostruzione seguita alla Prima Guerra mondiale aprì una fase di prosperità di pochi anni durante i quali, come prima dello scoppio del conflitto, la vendita ai mercati extra-capitalisti ha costituito lo sbocco necessario all’accumulazione capitalista. In effetti, anche se il mondo era allora diviso tra le più grandi potenze industriali, i rapporti di produzione capitalisti non lo avevano ancora dominato completamente. Tuttavia, dato che la capacità di assorbimento dei mercati extra-capitalisti diventava insufficiente rispetto alla massa di merci prodotte dai paesi industrializzati, la ripresa si infrange rapidamente sullo scoglio della sovrapproduzione con la crisi del 1929.
Completamente differente fu il periodo aperto dalla ricostruzione seguita alla Seconda Guerra mondiale che supera i migliori indici economici della fase di ascesa del capitalismo. Per oltre due decenni si è avuta una crescita sostenuta basata su livelli di produttività tra i più importanti della storia del capitalismo dovuti in particolare al perfezionamento del lavoro alla catena di montaggio (fordismo), all’automatizzazione della produzione ed alla loro generalizzazione ovunque era possibile.
Ma non è sufficiente produrre delle merci, bisogna anche smaltirle sul mercato. In effetti la vendita delle merci prodotte dal capitalismo serve a coprire il rinnovo dei mezzi di produzione consumati e della forza lavoro (salario degli operai). Essa assicura dunque la riproduzione semplice del capitale (cioè senza aumento dei mezzi di produzione o di consumo), ma deve anche finanziare le spese improduttive – che vanno dalle spese per gli armamenti al mantenimento dei capitalisti, includendo anche molte altre voci sulle quali torneremo. Se poi sussiste un saldo positivo questo può rientrare nell’accumulazione del capitale. Nelle vendite effettuate annualmente dal capitalismo, la parte che può essere dedicata all’accumulazione del capitale, e che partecipa anche all’arricchimento reale di questo, è necessariamente limitata perché è il saldo di tutte le spese obbligatorie. Storicamente questa rappresenta solo una debole percentuale della ricchezza prodotta annualmente[12] e corrisponde essenzialmente alle vendite realizzate nel commercio con dei mercati extra-capitalisti (interni o esterni)[13]. Questo è effettivamente il solo mezzo che permette al capitalismo di svilupparsi (al di fuori del saccheggio, legale o no, delle risorse delle economie non capitaliste), cioè di non trovarsi in questa situazione in cui “dei capitalisti scambiano tra loro e consumano la loro produzione”, la qual cosa come dice Marx “non permette affatto una valorizzazione del capitale”: “Come sarebbe altrimenti possibile che possa far difetto la domanda per quelle stesse merci di cui il popolo ha bisogno, e come sarebbe possibile che si debba cercare questa domanda all’estero, su mercati lontani, per poter pagare agli operai del proprio paese la media dei mezzi di sussistenza necessari? Precisamente perché solo in questo nesso, specificamente capitalistico, il prodotto in eccesso riveste una forma tale che colui che lo possiede può metterlo a disposizione del consumo solo quando esso si riconverte per lui in capitale. Infine, quando si afferma che i capitalisti non hanno che da scambiare fra di loro e consumare essi stessi le loro merci, si perde di vista il carattere essenziale della produzione capitalista, il cui scopo è la valorizzazione del capitale e non il consumo”[14].
Con l’entrata in decadenza del capitalismo, i mercati extra-capitalisti sono tendenzialmente sempre più insufficienti ma non scompaiono semplicemente e la loro sopravvivenza dipende anche, come nella fase di ascesa, dai progressi dell’industria. Ora, cosa succede quando i mercati extra-capitalisti sono sempre meno capaci di assorbire le quantità crescenti di merci prodotte dal capitalismo? Il risultato è la sovrapproduzione e con essa la distruzione di una parte della produzione, a meno che il capitalismo non perviene ad utilizzare il credito come palliativo. Ma più i mercati extra-capitalisti si rarefanno e meno il credito usato come palliativo potrà essere rimborsato.
Così, lo sbocco solvibile per la crescita dei Trenta Gloriosi è stato costituito dalla combinazione dello sfruttamento dei mercati extra-capitalisti ancora esistenti all’epoca e l’indebitamento nella misura in cui i primi non bastavano più ad assorbire tutta l’offerta. Non esiste nessun altro mezzo possibile (salvo nuovi saccheggi di ricchezze extra-capitaliste) che permetta l’espansione del capitalismo, allora come in ogni altra epoca successiva. Pertanto i Trenta Gloriosi danno già il loro piccolo contributo alla formazione dell’attuale massa di debiti che non saranno mai rimborsati e che diventano una vera e propria spada di Damocle sulla testa del capitalismo.
Un’altra caratteristica dei Trenta gloriosi è il peso delle spese improduttive nell’economia. Queste costituiscono una parte importante delle spese dello Stato e aumentano considerevolmente nella maggior parte dei paesi industrializzati a partire dalla fine degli anni ’40. Questa è una conseguenza della tendenza storica allo sviluppo del capitalismo di Stato, in particolare del peso del militarismo nell’economia che si mantiene ad un livello molto alto dopo la Guerra mondiale, e delle politiche keynesiane allora praticate e destinate a sostenere artificialmente la domanda. Se una merce o un servizio è improduttivo il suo valore d’uso non permette la sua integrazione nel processo produttivo[15] per contribuire alla riproduzione semplice o allargata del capitale. Bisogna considerare improduttive anche alcune spese relative alla domanda all’interno del capitalismo non necessarie ai bisogni della riproduzione semplice o allargata. Questo fu il caso in particolare durante i Trenta gloriosi di aumenti salariali a dei tassi che si avvicinavano a volte a quelli della crescita della produttività del lavoro, aumenti di cui hanno “beneficiato” alcune categorie di lavoratori, in alcuni paesi, in applicazione delle stesse dottrine keynesiane.
In effetti, il versamento di un salario maggiore di quello che è strettamente necessario alla riproduzione della forza lavoro (così come i sussidi versati ai disoccupati o le spese improduttive dello Stato) ha per corollario lo spreco di capitali che non possono essere consacrati alla valorizzazione del capitale globale. In altri termini, il capitale destinato alle spese improduttive, quali che esse siano, è sterilizzato.
La creazione attraverso il keynesismo di un mercato interno capace di dare una soluzione immediata allo smaltimento di una produzione industriale massiccia ha potuto dare l’illusione di un ritorno duraturo alla prosperità della fase di ascesa del capitalismo. Ma poiché questo mercato era completamente staccato dai bisogni di valorizzazione del capitale, il corollario è stato la sterilizzazione di una parte significativa di capitale. La possibilità del suo mantenimento era condizionata da una congiuntura di fattori eccezionali che non poteva durare: la crescita sostenuta della produttività del lavoro che, pur finanziando le spese improduttive, fosse insufficiente ad individuare un’eccedenza tale da permettere di continuare l’accumulazione; l’esistenza di mercati solvibili – o extra-capitalisti o derivanti dall’indebitamento – che permettesse la realizzazione di questa eccedenza.
Una crescita della produttività del lavoro comparabile a quella dei Trenta gloriosi non si è mai più realizzata in seguito. In ogni caso, anche se questa fosse stata possibile, l’esaurimento tortale dei mercati extra-capitalisti e l’aver raggiunto quasi i limiti del rilancio dell’economia attraverso nuovi aumenti del debito mondiale già smisurato, rendono impossibile il ripetersi di un tale periodo di prosperità. Contrariamente all’analisi sviluppata ne La decadenza del capitalismo, il mercato della ricostruzione non è un fattore che può spiegare la prosperità dei Trenta gloriosi. Alla conclusione della Seconda Guerra mondiale, il ripristino dell'apparato produttivo non ha costituito in sé un mercato extra-capitalista né ha generato il nuovo valore. Questa prosperità fu in buona parte il risultato di un trasferimento della ricchezza già accumulata dagli Stati Uniti verso i paesi da ricostruire, poiché il finanziamento dell’operazione è stato fatto attraverso il piano Marshall che consisteva essenzialmente di donazioni del Tesoro americano. Un mercato della ricostruzione non può essere invocato neanche per spiegare la breve fase di prosperità seguita alla Prima Guerra mondiale. Per tale motivo lo schema “guerra-ricostruzione/prosperità” che, in modo empirico, ha effettivamente corrisposto alla realtà del capitalismo in decadenza, non ha tuttavia un valore di legge economica secondo la quale esisterebbe un mercato della ricostruzione che permette un arricchimento del capitalismo.
Il capitalismo di Stato keynesiano-fordista
L’analisi che facciamo delle forze motrici dei Trenta gloriosi parte da un insieme di constatazioni oggettive tra le quali le principali sono le seguenti.
Il prodotto mondiale per abitante raddoppia durante la fase ascendente del capitalismo[16] ed il tasso di crescita industriale continuerà ad aumentare per culminare alla vigilia della Prima Guerra mondiale[17]. In questo momento i mercati che gli avevano fornito il campo di espansione arrivano alla saturazione rispetto ai bisogni raggiunti dall’accumulazione a livello internazionale. E’ l’inizio della fase di decadenza segnalata dalle due guerre mondiali, la più grande crisi di sovrapproduzione di tutti i tempi (1913-33) ed un freno brutale alla crescita delle forze produttive (tanto la produzione industriale che il prodotto mondiale per abitante saranno quasi dimezzati tra il 1913 ed il 1945: rispettivamente 2,8% e 0,9% l’anno).
Ciò non impedirà al capitalismo di conoscere una formidabile crescita durante i Trenta gloriosi: il prodotto mondiale per abitante triplica, mentre la produzione industriale aumenterà più del doppio (rispettivamente 2,9% e 5,2% l’anno). Non solo questi tassi sono ben superiori a quelli del periodo ascendente, ma i salari reali aumentano con una rapidità quattro volte superiore (si moltiplicano per quattro là dove erano appena raddoppiati durante un periodo due volte più lungo tra il 1850 ed il 1913)!
Come è potuto avvenire un tale miracolo?
* né per una residua domanda extra-capitalista perché questa era già insufficiente nel 1914 ed è diminuita ancora in seguito[18];
* né per l’indebitamento statale o il deficit buggettario perché questi diminuiscono fortemente durante i Trenta gloriosi[19];
* né per il credito che aumenta sensibilmente solo con il ritorno della crisi[20];
* né per l’economia di guerra perché essa è improduttiva: i paesi più militarizzati sono i meno efficienti e viceversa;
* né per il piano Marshall il cui impatto è limitatamente importante e duraturo[21];
* né per le distruzioni della guerra perché quelle consecutive alla prima non avevano prodotto prosperità[22];
* né per il solo aumento del peso dello Stato nell’economia perché il fatto di essere raddoppiato tra le due guerre non ha avuto un tale effetto[23], nel 1960 il suo livello (19%) è inferiore a quello del 1937 ed in più comprende numerose spese improduttive.
Il “miracolo” resta da spiegare, tanto più che: (a) all’indomani della guerra le economie sono esangui; (b) il potere d’acquisto di tutti gli attori economici è al minimo; (c) questi ultimi sono tutti pesantemente indebitati; (d) l’enorme potenza acquisita dagli Stati Uniti si fonda su di una economia di guerra improduttiva e che ha grandi difficoltà di riconversione, e (e) questo “miracolo” avrà tuttavia luogo malgrado la sterilizzazione di masse crescenti di plus-valore nelle spese improduttive!
In realtà questo non è più un mistero se si combinano le analisi di Marx sulle implicazioni dei guadagni di produttività[24] e gli apporti della Sinistra Comunista sullo sviluppo del capitalismo di Stato in decadenza. In effetti questo periodo si caratterizza per:
a) Dei guadagni di produttività mai visti in tutta la storia del capitalismo, guadagni che si basano sulla generalizzazione ed il mantenimento del lavoro alla catena di montaggio (fordismo).
b) Considerevoli aumenti dei salari reali, un pieno impiego e la messa in opera di un salario indiretto costituito da diversi sussidi sociali. Del resto, i paesi dove questi aumenti sono più forti saranno quelli più efficienti e viceversa.
c) Una presa in mano da parte dello Stato di parti intere dell’economia ed un suo forte intervento nel rapporto capitale-lavoro[25].
d) Tutte queste politiche keynesiane sono state anche inquadrate su certi piani a livello internazionale attraverso l’OCSE, il GATT, il FMI, la Banca Mondiale, ecc.
e) Infine, contrariamente ad altri periodi, i Trenta gloriosi sono stati caratterizzati da una crescita auto centrata (cioè con relativamente poco scambio fra i paesi dell'OCSE ed il resto del mondo) e senza alcuna delocalizzazione nonostante i forti aumenti dei salari reali e la piena occupazione. In effetti, la mondializzazione e le delocalizzazioni sono fenomeni che arriveranno solo alla fine degli anni ’80 e soprattutto ’90.
Così, garantendo in modo costrittivo e proporzionato la tri-ripartizione dei guadagni di produttività tra i profitti, le imposte ed i salari, il capitalismo di Stato keynesiano-fordista garantirà il completamento del ciclo di accumulazione tra un'offerta calante di beni e servizi a prezzo decrescente (fordismo) ed una domanda solvibile crescente perché indicizzata su questi stessi guadagni di produttività (keynesianismo).
Essendo i mercati così garantiti, il ritorno della crisi si manifesterà con un rovesciamento al ribasso del tasso di profitto che, dopo l’esaurimento dei guadagni fordisti di produttività, diminuirà di metà tra la fine degli anni 1960 e 1982[26]. Questo abbassamento drastico della redditività del capitale spinge allo smantellamento delle politiche del dopo guerra a vantaggio di un capitalismo di Stato senza regole all’inizio degli anni ’80. Se questa svolta ha permesso un ristabilimento spettacolare del tasso di profitto, grazie alla compressione della parte salariale, la riduzione della domanda solvibile che ne deriva mantiene i tassi di accumulazione e la crescita in magro[27]. Pertanto in un contesto ormai strutturale di deboli guadagni di produttività, il capitalismo è costretto a fare pressione sui salari e le condizioni di lavoro per garantire l’aumento dei profitti, ma così facendo restringe al tempo stesso i suoi mercati solvibili.
Queste sono le radici:
a) delle sovra-capacità e della sovrapproduzione endemica;
b) dell’indebitamento sempre più sfrenato come palliativo al restringimento della domanda;
c) delle delocalizzazioni alla ricerca di mano d’opera a basso costo;
d) della mondializzazione per vendere al massimo come esportazione;
e) dell’instabilità finanziaria a ripetizione derivante dagli spostamenti speculativi di capitali che non hanno più l’occasione di procedere ad investimenti di espansione.
Oggi il tasso di crescita è ridisceso al livello di quello tra le due guerre ed un remake dei Trenta Gloriosi è ormai impossibile. Il capitalismo è condannato ad una crescente barbarie.
Non avendo ancora avuto l’occasione di essere presentate in quanto tali, le radici e le implicazioni di questa analisi saranno sviluppate ulteriormente in seguito perché è necessario un ritornare su delle nostre analisi al fine di pervenire ad una comprensione più ampia e coerente del funzionamento e dei limiti del modo di produzione capitalista[28].
Un dibattito aperto agli elementi in ricerca
Come i nostri predecessori di Bilan o della Sinistra comunista di Francia, noi non pretendiamo di essere i detentori della verità “assoluta ed eterna”[29] e siamo pienamente coscienti che i dibattiti che sorgeranno nella nostra organizzazione non possono che beneficiare di apporti e critiche costruttive che si esprimono al di fuori di essa. Per questo tutti i contributi che ci arriveranno saranno benvenuti e presi in considerazione nella nostra riflessione collettiva.
Corrente Comunista Internazionale
[1] Tra il 1950 ed il 1973 il PIL mondiale per abitante è aumentato ad un ritmo annuale vicino al 3%, mentre tra il 1870 ed il 1913 era aumentato al ritmo dell’1,3% (Maddison Angus, L’economia mondiale. OCSE, 2001, pag. 284).
[2] Raccolta di articoli della stampa della CCI pubblicata nel gennaio 1981.
[3] Terzo congresso della CCI, Rivista Internazionale n. 18, 3° trimestre 1979 (in inglese, francese e spagnolo).
[4] Rivista Internazionale n. 52, 1° trimestre 1988 (idem).
[5] Soprattutto con la pubblicazione della serie “Comprendere decadenza del capitalismo” nella Rivista Internazionale (in particolare l’articolo del n. 56) e la pubblicazione nella Rivista Internazionale n. 59 (4° trimestre 1989) della presentazione sulla situazione internazionale dell’8° congresso della CCI relativa al peso dell’indebitamento nell’economia mondiale.
[6] Il fatto che questa posizione minoritaria esiste già da molto tempo all’interno della nostra organizzazione – i compagni che la difendono attualmente la difendevano già quando sono entrati nella CCI – e permette la partecipazione all’insieme delle nostre attività, sia di intervento che i elaborazione politico-teorica, illustra la correttezza della decisione della CCI di non aver fatto della sua analisi del legame tra saturazione dei mercati e abbassamento del tasso di profitto e del rispettivo peso di questi fattori una condizione di adesione all’organizzazione.
[7] Vedi a questo proposito l’articolo “Risposta alla CWO sulla guerra nella fase i decadenza del capitalismo” pubblicato in due parti nei nn. 127 e 128 della Rivista Internazionale (inglese, francese e spagnolo).
[8] L’idea di un miglior sfruttamento dei mercati extra-capitalisti è già presente nella Decadenza del capitalismo. Essa viene ripresa e messa in evidenza nel 6° articolo della serie “Comprendere la decadenza del capitalismo” pubblicato nel n°56 della Rivista Internazionale dove viene avanzato anche il fattore indebitamento mentre il concetto di “mercato della ricostruzione” non viene ripreso.
[9] All’interno di queste tre posizioni esistono delle sfumature che non sono state espresse nel dibattito. Non possiamo renderne conto nel quadro di questo articolo, ma queste potranno essere espresse, in funzione dell’evoluzione del dibattito, in futuri contributi che pubblicheremo.
[10] Internationalisme n°1, gennaio 1945: “Tesi sulla situazione Internazionale”.
[11] Solo negli Stati Uniti le spese dello Stato federale, che rappresentavano solo il 3% del PIL nel 1930, arrivano a circa il 20% nel periodo 1950-60.
[12] A titolo d’esempio, durante il periodo 1870-1913 la vendita ai mercati extra-capitalisti doveva rappresentare una percentuale media annuale vicina al 2,3% del PIL mondiale (cifra calcolata in funzione dell’evoluzione del PIL mondiale tra queste due date. Fonte: The World Economy [8]). Trattandosi di un valore medio è ovvio che questa cifra è inferiore a quella realmente avutasi negli anni di forte crescita come quelli prima della Prima guerra mondiale.
[13] A tale proposito per il destinatario finale poco importa se le sue vendite sono produttive o meno, come le armi.
[14] Libro III, sezione III: la legge tendenziale dell’abbassamento del tasso di profitto, Capitolo X: Lo sviluppo delle contraddizioni immanenti della legge, pletora di capitale e sovrappopolazione.
[15] Per illustrare questo fatto basta considerare la differenza d’uso finale tra, da una parte, un’arma, un annuncio pubblicitario, un corso di formazione sindacale e, dall’altra, un attrezzo, un alimento, dei corsi scolastici o universitari, delle cure mediche, ecc.
[16] Dallo 0,53% l’anno nel periodo 1820-70 all’1,3% nel periodo 1870-1913 (Angus Maddison, L’economia mondiale, OCSE, pag 284).
[17] Tasso di crescita annuale della produzione industriale mondiale:
1786-1820 2,5 %
1820-1840 2,9 %
1840-1870 3,3 %
1870-1894 3,3 %
1894-1913 4,7 %
W.W. Rostow, The World Economy, p. 662.
[18] Molto importante alla nascita del capitalismo, questo potere d’acquisto interno ai paesi sviluppati rappresentava solo dal 5 al 20% già nel 1914 e divenne marginale nel 1945: dal 2 al 12% (Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975, A Data Handbook, Vol II, Campus, 1987). Quanto all’accesso al Terzo Mondo questo è amputato di due terzi con il restringimento del mercato mondiale della Cina, del blocco dell’Est, dell’India e di diversi altri paesi sottosviluppati. Il commercio con la restante parte diminuisce della metà tra il 1952 ed il 1972 (P. Bairoch, Il Terzo Mondo nell’impasse, pag. 391-192)!
[19] I dati sono pubblicati nel n. 114.
[20] I dati sono pubblicati nel n. 121.
[21] Il piano Marshall ha avuto un impatto debole sull’economia americana: “Dopo la seconda guerra mondiale… la percentuale delle esportazioni americane in rapporto all’insieme della produzione è diminuita in misura non trascurabile. Lo stesso Piano Marshall non ha provocato in questo dominio cambiamenti considerevoli” (Fritz Sternberg, Il conflitto del secolo, pag.577) e l’autore ne deriva che ad essere determinante nella ripresa è stato quindi il mercato interno.
[22] I dati e l’argomentazione sono sviluppati nel nostro articolo del n. 128. Ci ritorneremo perché, conformemente a Marx, la svalutazione e la distruzione di capitali permette effettivamente di rigenerare il ciclo di accumulazione ed aprire nuovi mercati. Tuttavia uno studio minuzioso ci ha mostrato che se questo fattore ha potuto avere ruolo, questo è stato relativamente debole, limitato nel tempo ed all’Europa ed al Giappone.
[23] La parte di spesa pubblica totale nel PIL dei paesi dell’OCSE passa dal 9% al 21% dal 1913 al 1937 (vedi n. 114).
[24] In effetti la produttività non è che un’altra espressione della legge del valore – poiché rappresenta l’inverso del tempo di lavoro – ed è alla base dell’estrazione di plus-valore relativa così caratteristico di questo periodo.
[25] La parte della spesa pubblica nei paesi dell’OCSE diventa più del doppio tra il 1960 e il 1980: dal 19% al 45% (n. 114).
[26] Grafici nei n. 115,121 e 128.
[27] Grafici e dati nel n°121 e nell’articolo di analisi sulla crescita nell’Asia dell’Est: https://fr.internationalism.org/ICConline/2008/crise_economique_Asie_Sud_est.htm [9].
[28] Il lettore tuttavia potrà trovare numerosi elementi fattuali, così come alcuni sviluppi teorici nei diversi articoli apparsi nei nn. 114, 115, 121, 127,128 e nella nostra analisi della crescita nell’Asia dell’Est.
[29] “Nessun gruppo possiede in esclusiva la ‘verità assoluta ed eterna’” come diceva la Sinistra comunista di Francia. Vedi a questo proposito il nostro articolo “60 anni fa: una conferenza di rivoluzionari internazionalisti”, Rivista Internazionale n. 131.
Questioni teoriche:
- Economia [7]
90 anni fa, la rivoluzione tedesca: di fronte alla guerra il proletariato ritrova i suoi principi internazionalisti
- letto 29 volte
90 anni fa, la rivoluzione proletaria culminava in modo tragico in Germania nelle lotte del 1918 e 1919. Dopo l‘eroica presa del potere da parte del proletariato in Russia nell’ ottobre del 1917, il cuore della battaglia per la rivoluzione mondiale si spostò in Germania. Là fu condotta la battaglia decisiva, ed essa fu persa. La borghesia mondiale ha sempre voluto mantenere questi avvenimenti nell'oblio. Tuttavia, non potendo negare l'esistenza delle lotte in quel periodo, la borghesia afferma pretestuosamente che quest'ultime sono state condotte in nome della "democrazia" e della "pace" – in altri termini, per le stesse "meravigliose" condizioni che attualmente regnano nella Germania capitalista.
Lo scopo della serie che iniziamo con quest'articolo è quello di mostrare come la borghesia tedesca si sia trovata molto vicino alla perdita del potere di fronte al movimento rivoluzionario. Malgrado la sua sconfitta, la rivoluzione tedesca, come la rivoluzione russa, attualmente deve essere un incoraggiamento per noi. Essa ci ricorda che non è solo necessario ma anche possibile rovesciare il dominio del capitalismo mondiale.
Questa serie sarà costituita da cinque articoli. Il primo è dedicato alla maniera in cui il proletariato rivoluzionario si è riappropriato dei suoi principi internazionalisti di fronte alla I guerra mondiale. Il secondo tratterà le lotte rivoluzionarie del 1918. Il terzo verrà dedicato al dramma che si è svolto durante la costituzione del Partito comunista fin dal 1918. Il quarto esaminerà la sconfitta del 1919. L'ultimo tratterà il significato storico dell'assassinio di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht, insieme all'eredità che questi rivoluzionari ci hanno tramandato.
La sconfitta e lo smarrimento
L'ondata rivoluzionaria internazionale, iniziata durante la I Guerra mondiale, si è avuta solo dopo qualche anno dalla grande sconfitta politica subita dal movimento operaio: il crollo dell'Internazionale socialista nell’agosto del 1914. Esaminare perché la guerra è potuta scoppiare, e perché sia fallita l'Internazionale, costituisce pertanto un elemento essenziale per comprendere la natura ed il corso delle rivoluzioni in Russia ed in Germania.
La strada verso la guerra
All'inizio del XX secolo, la minaccia della guerra mondiale era nell'aria. Le grandi potenze la stavano preparando febbrilmente. Il movimento operaio la prevedeva e si allertava contro di essa. Il suo scoppio fu ritardato per due motivi: il primo fu l'insufficienza della preparazione militare dei principali protagonisti. La Germania stava ancora completando la costruzione di una marina militare (da guerra) in grado di rivalizzare con quella della Gran Bretagna, già padrona degli oceani. Essa stava trasformando l’isola di Helgoland in base navale, e terminava la costruzione del canale tra il Mare del Nord ed il Baltico, ecc. Alla fine del primo decennio del secolo, questi preparativi erano compiuti. Ciò conferiva ancora più importanza all'altro motivo: la paura che incuteva la classe operaia. Questa paura non era solo un'ipotetica speculazione del movimento operaio. Anche importanti rappresentanti della borghesia la esprimevano con estrema chiarezza. Von Bulow, cancelliere tedesco, dichiarava che era proprio per la socialdemocrazia che la guerra veniva rinviata. Paul Rohrbach, infame sostenitore di certi circoli guerrafondai, apertamente imperialisti, di Berlino, scriveva: "a meno che non abbia luogo una catastrofe, la sola cosa che possa costringere la Germania a mantenere la pace, è la fame di coloro che non hanno il pane". Il generale von Bernhardi, eminente teorico militare dell'epoca, sottolineava nel suo libro La guerra di oggi
(1913) che la guerra moderna comportava elevati rischi perché essa per avere luogo avrebbe dovuto mobilitare ed irreggimentare milioni di persone. Questo punto di vista non si basava solo su considerazioni teoriche, ma sull'esperienza pratica della prima guerra imperialista del XX secolo tra paesi di prima importanza. Questa guerra, svoltasi tra la Russia ed il Giappone (1904-1905), aveva prodotto il movimento rivoluzionario del 1905 in Russia.
Questo tipo di considerazioni mantenevano viva all'interno del movimento operaio la speranza che la classe dominante non avrebbe osato scatenare la guerra. Questa speranza dissimulava le divergenze all'interno dell'Internazionale socialista, in un momento in cui era necessario fare chiarezza, all'interno del proletariato, attraverso un dibattito aperto. Il fatto che nessuna componente del movimento socialista internazionale "volesse" la guerra dava un'impressione di forza e di unità. Tuttavia l'opportunismo ed il riformismo non si opponevano alla guerra per principio ma semplicemente perché temevano che il suo scoppio avrebbe provocato la perdita delle loro istituzioni legali e finanziarie. Da parte sua, il "centro marxista" vicino a Kautsky temeva la guerra principalmente perché essa avrebbe distrutto l'illusione di un movimento operaio che lui voleva mantenere unito a tutti i costi.
Ciò che in realtà convinceva sulla capacità della classe operaia di impedire la guerra, era soprattutto l'intensità della lotta di classe in Russia. In questo paese, gli operai non avevano impiegato molto tempo a riprendersi dalla sconfitta del movimento del 1905. Alla vigilia della Prima Guerra mondiale, una nuova ondata di scioperi di massa raggiungeva il suo culmine nell'impero degli Zar. In un certo senso, la situazione della classe operaia in questo paese può avere qualche somiglianza con quella della Cina di oggi: essa costituiva una minoranza della popolazione, ma era altamente concentrata in fabbriche moderne finanziate dal capitale internazionale, ferocemente sfruttata in un paese arretrato che non disponeva di meccanismi di controllo politico tipo liberalismo parlamentare borghese. Tuttavia, c'è una importante differenza: il proletariato russo era stato educato nelle tradizioni socialiste dell'Internazionalismo, mentre gli operai cinesi attuali soffrono ancora l'incubo della contro rivoluzione stalinista.
Tutto ciò faceva della Russia una minaccia per la stabilità capitalista.
Ma la Russia non era un esempio significativo del rapporto di forza internazionale tra le classi. Il cuore del capitalismo e delle tensioni imperialiste si situava nell’Europa occidentale e centrale. La chiave della situazione internazionale non si trovava in Russia ma in Germania. La Germania era il paese che contestava l'ordine mondiale delle vecchie potenze coloniali. Ed era anche il paese in cui il proletariato era il più forte, il più concentrato, con la più sviluppata educazione socialista. Il ruolo politico della classe operaia tedesca si evidenziava principalmente attraverso il fatto che i principali sindacati erano stati fondati dal partito socialista, mentre in Gran Bretagna – l'altra nazione capitalista dominante in Europa – il socialismo appariva solo come appendice del movimento sindacale. In Germania, le lotte quotidiane degli operai avevano tradizionalmente luogo nell'ottica del grande scopo socialista finale.
Tuttavia, alla fine del XIX secolo era cominciato in Germania un processo di involuzione politica dei sindacati socialisti, di "emancipazione" di questi ultimi rispetto al partito socialista. I sindacati mettevano apertamente in discussione l'unità tra il movimento e lo scopo finale. Il teorico del partito, Edouard Bernstein, non fece che generalizzare questo orientamento con la sua celebre formulazione: “il movimento è tutto, lo scopo finale è nullo”. Questa messa in discussione del ruolo dirigente della Socialdemocrazia all'interno del movimento operaio, della predominanza dello scopo sul movimento, provocò un conflitto all'interno del partito socialista (SPD) e dei suoi sindacati. Dopo lo sciopero di massa del 1905 in Russia, questo conflitto s'intensificò. Esso finì con la vittoria dei sindacati sul partito. Sotto l'influenza del "centro" animato da Kautsky – che voleva mantenere "l'unità" del movimento ad ogni costo, il partito decise che la questione dello sciopero di massa era compito dei sindacati[1]. Ma lo sciopero di massa conteneva tutta la questione della futura rivoluzione proletaria! Così, alla vigilia della Prima Guerra mondiale, la classe operaia tedesca ed internazionale si venne a trovare completamente disarmata.
Dichiarare il carattere non politico dei sindacati costituiva una preparazione all'integrazione del movimento sindacale nello Stato capitalista. Ciò forniva alla classe dominante l'organizzazione delle masse di cui essa aveva bisogno per mobilitare gli operai per la guerra. A sua volta, questa mobilitazione nel cuore del capitalismo, andava a determinare la demoralizzazione ed il disorientamento degli operai in Russia – per i quali la Germania costituiva il principale referente – ed ad imbrigliare il movimento degli scioperi di massa che in essa si svolgevano.
Il proletariato russo, che conduceva scioperi di massa dal 1911, aveva già dietro di sé un'esperienza recente di crisi economiche, di guerre e di lotte rivoluzionarie. Ciò non accadeva in Europa occidentale e centrale. Là, la guerra veniva scatenata dopo un lungo periodo di sviluppo economico, durante il quale la classe operaia aveva conosciuto reali miglioramenti delle sue condizioni d'esistenza, aumenti salariali e caduta della disoccupazione, ma anche lo sviluppo di illusioni riformiste; un periodo in cui le guerre si erano principalmente svolte alla periferia del capitalismo. La prima grande crisi economica mondiale non sarebbe scoppiata che 15 anni dopo, nel 1929. La fase di decadenza del capitalismo non cominciava con una crisi economica, come si aspettava il movimento operaio, ma con la crisi della guerra mondiale. Con la sconfitta e l'isolamento dell'ala sinistra del movimento operaio sulla questione dello sciopero di massa, non c'era più ragione per la borghesia di rinviare oltre la corsa alla guerra imperialista. Al contrario, ogni ritardo poteva esserle fatale. Attendere significava attendere lo sviluppo della crisi economica, la lotta di classe e la coscienza rivoluzionaria del suo becchino!
Il crollo dell'Internazionale
Il corso alla guerra mondiale era così aperto. La sua esplosione provocò il crollo dell'Internazionale socialista. Alla vigilia della guerra, la Socialdemocrazia organizzò dimostrazioni di protesta in tutta l'Europa. La direzione del SPD inviò Friedrich Ebert (futuro assassino della rivoluzione) a Zurigo in Svizzera con fondi del partito per impedire che fossero confiscati, e Bruno Haase, eterno esitante, a Bruxelles per organizzare la resistenza internazionale contro la guerra. Ma una cosa è opporsi alla guerra prima che esploda, ed un'altra è prendere posizione una volta che è cominciata. E là, i sermoni della solidarietà proletaria, pronunciati solennemente ai congressi internazionali di Stoccarda nel 1907 e a Basilea nel 1912 in gran parte si rivelarono platonici. Anche alcuni membri dell'ala sinistra che avevano sostenuto azioni immediate apparentemente radicali contro la guerra - Mussolini in Italia, Hervé in Francia – in quel momento si unirono al campo dello sciovinismo.
L'estensione del fiasco dell'Internazionale sorprese tutto il mondo. È ben noto come inizialmente Lenin pensasse che le dichiarazioni della stampa del partito tedesco in favore della guerra fossero opera della polizia per destabilizzare il movimento socialista all'estero. Anche la borghesia sembrava sorpresa alla notizia del tradimento dei suoi principi da parte della Socialdemocrazia. Essa aveva puntato principalmente sui sindacati per mobilitare gli operai effettuando accordi segreti con la loro direzione alla vigilia della guerra. In alcuni paesi, i grandi partiti socialdemocratici si opposero realmente alla guerra. Ciò dimostra che l'apertura politica del corso alla guerra non significò automaticamente il tradimento da parte delle organizzazioni politiche. E fu per tale motivo che il fallimento della Socialdemocrazia nei principali paesi in guerra si dimostrò più sorprendente. In Germania, in alcuni casi, anche gli elementi più risoluti contro la guerra all'inizio non fecero sentire la loro voce. Al Reichstag dove 14 membri della frazione parlamentare della Socialdemocrazia erano contro il voto sui crediti di guerra e 78 a favore; lo stesso Karl Liebknecht si sottomise all'inizio alla tradizionale disciplina della frazione.
Come spiegarlo?
Per farlo, bisogna porre gli avvenimenti nel loro contesto oggettivo. A tale proposito, il fondamentale cambiamento nelle condizioni della lotta di classe, provocato dall'ingresso in una nuova epoca storica di guerre e rivoluzioni, è determinante. E' in questo contesto che è possibile comprendere appieno che il passaggio dei sindacati nel campo borghese era storicamente inevitabile. Poiché queste organizzazioni erano l'espressione di una tappa particolare della lotta di classe nel corso della quale la rivoluzione non era ancora all'ordine del giorno, essi per loro natura non sono mai stati degli organismi rivoluzionari; con il nuovo periodo, durante il quale la difesa degli interessi immediati di qualsiasi parte del proletariato implicava automaticamente una dinamica verso la rivoluzione, essi non potevano più servire la loro classe d'origine e potevano solo sopravvivere passando al campo nemico.
Ma ciò che si spiega chiaramente per i sindacati si dimostra insufficiente per i partiti socialdemocratici. Resta chiaro che con la Prima Guerra mondiale, i partiti persero il loro vecchio centro di gravità, la mobilitazione per le elezioni. E' anche vero che il cambiamento delle condizioni determinava ugualmente la sparizione dei fondamenti stessi dell'esistenza dei partiti di massa della classe operaia. Di fronte alla guerra ed alla rivoluzione un partito rivoluzionario deve essere capace di andare controcorrente e nello stesso tempo di andare contro lo stato d'animo dominante nella classe nel suo insieme. Ma il compito principale di un'organizzazione politica della classe operaia – la difesa di un programma e, in particolare, dell'internazionalismo proletario – non varia col variare del periodo. Al contrario, esso diventa ancora più importante. Così, benché fosse storicamente inevitabile che il partito socialista conoscesse una crisi di fronte alla guerra mondiale e che le correnti al suo interno infestate dal riformismo e dall'opportunismo tradissero, ciò non bastò, tuttavia, a spiegare ciò che Rosa Luxemburg definì come “la crisi della Socialdemocrazia”.
E' ugualmente vero che un cambiamento storico fondamentale provoca necessariamente una crisi programmatica; le vecchie tattiche utilizzate da molto tempo ed anche i principi apparvero improvvisamente superati – come la partecipazione alle elezioni parlamentari, il sostegno ai movimenti nazionalisti ed alle rivoluzioni borghesi. Ma su alcuni punti dobbiamo ricordare che molti rivoluzionari dell'epoca, pur non comprendendo ancora le implicazioni programmatiche e tattiche del nuovo periodo, rimasero fedeli all'internazionalismo proletario.
Cercare di spiegare ciò che è successo solo a partire dalle condizioni oggettive ci porta a considerare che tutto ciò che fa parte della storia è fin dall'inizio inevitabile. Da questo punto di vista, si rimette in discussione la possibilità di trarre delle lezioni storiche giacché noi stessi siamo il prodotto di “condizioni oggettive”. Nessun vero marxista negherà l'importanza di queste condizioni oggettive. Ma se noi esaminiamo la spiegazione che gli stessi rivoluzionari dell'epoca hanno dato sulla catastrofe che ha conosciuto il movimento socialista nel 1914, vedremo che essi hanno posto per primo l'importanza dei fattori soggettivi.
Una delle ragioni principali del fallimento del movimento socialista risiede nel suo sentimento illusorio d'invincibilità, nella sua convinzione errata che la vittoria era certa. La Seconda internazionale basava questa convinzione su tre elementi essenziali già identificati da Marx: la concentrazione del capitale e dei mezzi di produzione ad un polo della società e dall'altro il proletariato spossessato; l'eliminazione degli strati sociali intermedi la cui esistenza confondeva la principale contraddizione sociale; e la crescente anarchia del modo di produzione capitalista, che si esprimeva principalmente sotto la forma della crisi economica e che costringeva l’affossatore del capitalismo, il proletariato, a mettere in discussione lo stesso sistema. Per se stesso, questo punto di vista era completamente valido. Queste tre condizioni per il socialismo sono il prodotto di contraddizioni oggettive che si sviluppano indipendentemente dalla volontà delle classi sociali e, a lungo termine, inevitabilmente si impongono. Tuttavia, esse danno origine a due problematiche conclusioni. La prima, è che la vittoria è ineluttabile. La seconda, è che la vittoria può essere ostacolata solo dal suo scoppio prematuro, e se il movimento operaio cede alle provocazioni.
Queste conclusioni erano tante più pericolose in quanto esse erano, benché parzialmente, profondamente giuste. E' vero che il capitalismo crea inevitabilmente le condizioni materiali della rivoluzione e del socialismo. Ed il pericolo della provocazione, da parte della classe dominante, di scontri prematuri è molto veritiero. Vedremo tutta l'importanza tragica rivestita da quest'ultima questione nella terza e quarta parte di questa serie.
Ma il problema di questo schema dell’avvenire socialista è che esso non concede alcun posto ai fenomeni nuovi come le guerre imperialiste tra le potenze capitaliste moderne. La questione della guerra mondiale non entrava in questo schema. Noi abbiamo già visto che già da tempo il movimento operaio riconosceva l'inevitabilità della guerra prima che essa veramente scoppiasse. Ma per l'insieme della Socialdemocrazia, riconoscerla non la portò a concludere che la vittoria del socialismo non era inevitabile. Queste due parti dell'analisi della realtà rimasero separate una dall'altra in un modo che può apparire quasi schizofrenico. Questa incoerenza, capace d'essere fatale, non è insolita. Molte delle grandi crisi e delle grandi confusioni nella storia del movimento operaio provengono dall'irrigidirsi sugli schemi del passato, dal ritardo della coscienza sull'evoluzione della realtà. Possiamo, per esempio, citare il sostegno al Governo provvisorio ed alla prosecuzione della guerra del Partito bolscevico dopo febbraio 1917 in Russia. Il partito era prigioniero dello schema della rivoluzione borghese legata al 1905 e che si rilevò inadeguato nel nuovo contesto della guerra mondiale. Sono state necessarie Le Tesi di aprile di Lenin e mesi di discussioni intense per venire fuori dalla crisi.
Poco prima della sua morte nel 1895, Friedrich Engels fu il primo a tentare di trarre le necessarie conclusioni dalla prospettiva di una guerra generalizzata in Europa. Dichiarò che essa avrebbe posto l'alternativa storica: socialismo o barbarie. L'inevitabilità della vittoria del socialismo fu apertamente messa in discussione. Ma lo stesso Engels non riuscì immediatamente a trarre tutte le conclusioni da questa visione. Per tale motivo, non riuscì a capire che l'apparizione della corrente d'opposizione dei Die Jungen (“I Giovani”) nel partito tedesco, nonostante tutte le sue debolezze era un'espressione autentica del malcontento giustificato di fronte al quadro delle attività del partito (principalmente orientato verso il parlamentarismo) divenuto largamente insufficiente. Di fronte all'ultima crisi del partito che conobbe prima della sua morte, Engels esercitò tutto il suo peso in favore della difesa del mantenimento dello status quo nel partito, in nome della pazienza e della necessità di evitare le provocazioni.
È Rosa Luxemburg che, alla svolta del secolo, nella sua polemica contro Bernstein, trarrà delle conclusioni decisive della visione sostenuta da Engels sulla prospettiva "socialismo o barbarie". Benché la pazienza costituisca una delle virtù principali del movimento operaio e che è necessario evitare scontri prematuri, da un punto di vista storico, il principale pericolo che si presentava non era più l'avvento di una rivoluzione prematura ma proprio il fatto che essa potesse scoppiare troppo tardi. Questo punto di vista porta tutta la sua insistenza sulla preparazione attiva della rivoluzione, sull'importanza centrale del fattore soggettivo.
Questa condanna del fatalismo che cominciava a dominare la Seconda Internazionale, questa revisione del marxismo, stava per divenire una delle linee di demarcazione di tutta l'opposizione della sinistra rivoluzionaria prima e durante la Prima Guerra mondiale[2].
Come Rosa Luxemburg scriverà nella sua brouchure La crisi della Socialdemocrazia: "Il socialismo scientifico ci ha insegnato a comprendere le leggi obiettive dello sviluppo storico. Gli uomini non fanno la loro storia inventandosela. Ma comunque sono essi a farla. Il proletariato dipende nella sua azione dal grado di sviluppo sociale dell'epoca, ma l'evoluzione sociale non si fa al di fuori del proletariato, quest'ultimo è il suo impulso e la sua causa, suo prodotto e sua conseguenza".
Proprio perché ha scoperto le leggi obiettive della storia, per la prima volta una forza sociale, la classe del proletariato cosciente, può mettere in pratica in modo deliberato la sua volontà. Essa non fa solo la storia, ma può influenzarne consapevolmente il corso.
"Nella storia, il socialismo è il primo movimento popolare che si stabilisce come scopo, e che sia incaricato dalla storia, a dare all'azione sociale degli uomini un senso cosciente, di introdurre nella storia un pensiero metodico e, attraverso di esso, una volontà libera. Ecco perché Friedrich Engels dice che la vittoria definitiva del proletariato socialista costituisce un salto che fa passare l'umanità dal regno animale al regno della libertà. Ma questo stesso 'salto' non è estraneo alle leggi ferree della storia, esso è legato alle migliaia di scalini precedenti dell'evoluzione, un'evoluzione dolorosa e purtroppo lenta. E questo salto non potrebbe essere portato a termine se, dall'insieme delle premesse materiali accumulate dall'evoluzione, non scocchi la scintilla della volontà cosciente della grande massa popolare" (ibid.).
Il proletariato deve fare il "suo apprendistato (...) e [tentare] di prendere in mano il proprio destino, di impadronirsi del governo della vita sociale. Lui che era il giocattolo passivo della sua storia, tenta di divenirne il lucido pilota" (ibid.).
Per il marxismo, riconoscere l'importanza delle leggi obiettive della storia e delle contraddizioni economiche - ciò che gli anarchici negano o ignorano - va di pari passo col riconoscimento degli elementi soggettivi[3]. Essi sono intimamente legati e si influenzano reciprocamente. Li possiamo osservare in relazione ai più importanti fattori che hanno sabotato poco a poco la vita proletaria nell'Internazionale. Uno di questi fattori era l'erosione della solidarietà all'interno del movimento operaio. Quest'ultima evidentemente fu favorita dall'espansione economica che ha preceduto il 1914 e dalle illusioni riformiste che questa ha generato. Ma essa fu anche il risultato della capacità della classe nemica di imparare dalla sua esperienza. Bismarck aveva introdotto procedimenti di assicurazione sociale (e nello stesso tempo leggi anti-socialiste) con lo scopo di sostituire la solidarietà tra i lavoratori con la loro dipendenza individuale di fronte a quello che più tardi diventerà "lo Stato assistenziale". Dopo che il tentativo di Bismarck di distruggere il movimento operaio mettendolo fuori legge fallì, il governo della borghesia imperialista che gli successe alla fine del XIX secolo, rovesciò la sua tattica. Avendo preso coscienza che le condizioni di repressione stimolavano la solidarietà operaia, il governo ritirò le leggi anti-socialiste ed invitò ripetutamente la Socialdemocrazia a partecipare alla "vita politica", (cioè alla direzione dello Stato) accusandola di rinunciare in modo "settario" al "solo mezzo pratico" che potesse permettere un reale miglioramento della vita dei lavoratori.
Lenin ha mostrato il legame esistente tra i livelli oggettivo e soggettivo relativamente ad un altro fattore decisivo nel decadimento dei principali partiti socialisti: la trasformazione della lotta per la liberazione dell’umanità in una routine quotidiana e vuota. Identificando tre correnti all’interno della Socialdemocrazia, egli presentava la seconda corrente "‘detta del centro’ che esita tra i socialsciovinisti ed i veri internazionalisti" caratterizzandola: "'il centro', questi sono uomini di routine, erosi da un legalismo putrido, corrotti dall'ambiente del parlamentarismo, ecc., funzionari civili abituati alle sinecura ed ad un lavoro 'tranquillo'. Storicamente ed economicamente, essi non rappresentano uno strato distinto. Ma rappresentano soltanto la transizione tra una fase passata del movimento operaio, quella del 1871-1914 (...) ed una fase nuova, divenuta obiettivamente necessaria dopo la Prima guerra imperialista mondiale, che ha inaugurato l’era della rivoluzione sociale"[4].
Per i marxisti dell'epoca, la "crisi della Socialdemocrazia" non era qualche cosa che accadeva fuori del loro campo d'azione. Essi si sentivano personalmente responsabili per quello che stava accadendo. Per loro, il fallimento del movimento operaio dell'epoca era il loro fallimento. Infatti, Rosa Luxemburg affermava: "noi abbiamo le vittime della guerra sulla coscienza".
Quello che è straordinario nel fallimento dell'Internazionale socialista, è che esso non è stato determinato in primo luogo né da un'inadeguatezza del programma, né da un'analisi erronea della situazione mondiale.
"Il proletariato mondiale non soffre di una mancanza di principi, di programmi o di slogan ma di una mancanza d'azione, di resistenza efficace, di capacità di attaccare l'imperialismo al momento decisivo"[5].
Per Kautsky, l'incapacità a mantenere l'internazionalismo provava l'impossibilità a farlo. Ne deduceva che l'Internazionale era essenzialmente uno strumento dei tempi di pace che doveva essere accantonato durante la guerra. Per Rosa Luxemburg e per Lenin, l'insuccesso dell'agosto 1914 proveniva soprattutto dall'erosione dell'etica della solidarietà proletaria ed internazionale all'interno della direzione dell'Internazionale.
"Allora si produsse l'orribile, l'incredibile 4 agosto 1914. Doveva accadere? Un evento di una tale importanza non può essere un semplice incidente. Esso deve avere delle cause obiettive profonde, significative. Ma forse queste cause si trovavano negli errori dei dirigenti del proletariato, nella stessa Socialdemocrazia, nel fatto che la nostra volontà di lottare era fiaccata, che il nostro coraggio e le nostre convinzioni ci avevano abbandonato" (ibidem, sottolineato da noi).
L'inversione di corrente
Il fallimento dell'Internazionale socialista fu un evento di un'importanza storica ed una sconfitta politica crudele. Ma esso non costituì una sconfitta decisiva, irreversibile, per tutta una generazione. Una prima prova ci venne data dal fatto che gli strati più politicizzati del proletariato rimasero fedeli all'internazionalismo proletario. Richard Müller, dirigente del gruppo "Revolutionäre Obleute", dei delegati di fabbriche della metallurgia ricordava: "Nella misura in cui le grandi masse popolari, già prima della guerra, erano state educate sotto l'influenza della stampa socialista e dei sindacati, ed avevano opinioni precise sullo Stato e la società, anche se all'inizio non si espressero apertamente, esse rifiutarono direttamente la propaganda di guerra e la guerra"[6]. Ciò costituisce un contrasto impressionante con la situazione degli anni ‘30, in seguito alla vittoria dello Stalinismo in Russia e del fascismo in Germania, dove gli operai più avanzati furono coinvolti sul terreno politico del nazionalismo e della difesa della patria "antifascista (imperialista)" o "socialista".
La mobilitazione per la guerra non era dunque la prova di una sconfitta profonda ma di un temporaneo abbattimento delle masse. Questa mobilitazione venne accompagnata da scene di isterismo di massa. Ma non bisogna confondere queste dimostrazioni con un coinvolgimento attivo della popolazione come era accaduto durante le guerre nazionali della borghesia rivoluzionaria in Olanda o in Francia. L'intensa agitazione pubblica del 1914 trova le sue radici soprattutto nel carattere massiccio della società borghese moderna e nei suoi mezzi di propaganda e di manipolazione a disposizione dello Stato capitalista fino allora sconosciuti. In questo senso, l'isterismo del 1914 non era completamente nuovo. In Germania, già avevamo assistito ad un fenomeno simile durante la Guerra franco-prussiana del 1870. Ma esso prese un nuovo aspetto col cambio di natura della guerra moderna.
La follia della guerra imperialista
Sembra che il movimento operaio abbia sottovalutato la potenza del gigantesco sisma politico, economico e sociale provocato dalla guerra mondiale. Avvenimenti di un livello e di una violenza così colossali, al di là del controllo di ogni forza umana, sono capaci di provocare le più estreme emozioni. Alcuni antropologi pensano che la guerra risvegli un istinto di difesa di "auto-conservazione", cosa che gli esseri umani condividono con altre specie. Vero o no, ciò che è sicuro, è che la guerra moderna risveglia vecchie paure dormienti nella nostra memoria storica e collettiva, trasmesse di generazione in generazione dalla cultura e dalle tradizioni in un modo consapevole o no: la paura della morte, la fame, lo stupro, l’esodo, l'esclusione, la privazione, l'asservimento. Il fatto che la guerra imperialista moderna generalizzata non sia più limitata a soldati di mestiere ma che coinvolga tutta la società ed introduce armamenti aventi un potere distruttivo senza precedenti, non può che aumentare il panico che essa crea. A ciò bisogna aggiungere le profonde implicazioni morali. Nella guerra mondiale, non solo una casta particolare di soldati ma milioni di lavoratori arruolati nell'esercito sono portati ad ammazzarsi. Il resto della società, nelle retrovie, deve funzionare per lo stesso scopo. In questa situazione, i principi morali fondamentali che rendono ogni possibile società umana, non si applicano più. Come dice Rosa Luxemburg: "ogni popolo che intraprende l'assassinio organizzato si trasforma in un'orda barbarica"[7].
Tutto ciò produsse nel momento dell'esplosione della guerra una vera psicosi di massa ed un'atmosfera di pogrom generalizzato. Rosa Luxemburg rende conto del modo in cui le popolazioni di intere città si trasformarono in plebaglia impazzita. I germi di tutta la barbarie del secolo XX secolo, compresi Auschwitz e Hiroshima, erano già contenuti in questa guerra.
Come avrebbe dovuto reagire all'esplosione della guerra il partito dei lavoratori? Decretando lo sciopero di massa? Chiamando i soldati alla diserzione? Un non senso, risponde Rosa Luxemburg. Il primo compito dei rivoluzionari era di resistere a quello che, in passato, Wilhelm Liebknecht aveva definito ciclone di passioni umane quando si riferiva alla guerra del 1870.
"Tali esplosioni de 'l'anima popolare' sono stupefacenti, strabilianti, schiaccianti per la loro furia elementare. Uno si sente impotente, come di fronte ad una potenza superiore. È come una forza maggiore. Essa non ha un avversario tangibile. E' come un'epidemia, presso le persone, nell'aria, dappertutto. (...) Così, questa non era affatto un'epoca in cui era possibile andare contro corrente"[8].
Nel 1870, la Socialdemocrazia nuotò contro corrente. Commento di Rosa Luxemburg: "Essi sono rimasti al loro posto e, per quarant'anni, la Socialdemocrazia è vissuto sulla forza morale con la quale si era opposta ad un mondo di nemici"[9].
E là, essa arriva al punto cruciale della sua argomentazione: "La stessa cosa sarebbe potuta accadere oggi. All'inizio, non avremmo potuto fare altro che salvare l'onore del proletariato, e le migliaia di proletari che muoiono nelle trincee in un'oscurità spirituale, non sarebbero morti in una confusione mentale, ma con la certezza che quello che aveva per loro rappresentato tutto durante la loro vita, l'Internazionale, la Socialdemocrazia liberatrice andava oltre un frammento di sogno. La voce del nostro partito avrebbe agito come guastafeste verso l'avvelenamento sciovinista delle masse. Essa avrebbe preservato il proletariato intelligente dal delirio, ed avrebbe frenato la capacità dell'imperialismo di avvelenare ed ad abbrutire le masse nel giro di poco tempo. Con l'avanzare della guerra, (...) ogni elemento vivente, elementi onesti, progressisti ed umani si sarebbero raccolti sotto la bandiera della Socialdemocrazia"[10].
Conquistare questo "incomparabile prestigio morale" costituisce il primo compito dei rivoluzionari di fronte alla guerra.
Per Kautsky ed i suoi seguaci era impossibile comprendere tali preoccupazioni verso gli ultimi pensieri che avrebbero avuto i proletari in divisa prima di morire. Per lui, provocare la rabbia della folla e la repressione dello Stato una volta esplosa la guerra, era solamente un gesto inutile e vano. Il socialista francese Jaurès aveva dichiarato in passato: l'Internazionale rappresenta tutta la forza morale del mondo. Ora, molti dei suoi vecchi dirigenti non sapevano più che l'internazionalismo non è un gesto vano ma la prova di vita o morte del socialismo internazionale.
La svolta ed il ruolo dei rivoluzionari
Il fallimento del Partito socialista condusse ad una situazione realmente drammatica. Come prima conseguenza, esso permise una perpetuazione apparentemente indefinita della guerra. La strategia militare della borghesia tedesca era la seguente: evitare l'apertura di un secondo fronte, ottenere una vittoria rapida sulla Francia e poi inviare tutte le sue forze sul fronte orientale per provocare la capitolazione della Russia. La sua strategia contro la classe operaia seguì lo stesso principio: coglierlo di sorpresa ed ottenere la vittoria prima che quest'ultimo avesse il tempo di riprendersi dal disorientamento.
A settembre 1914 (Battaglia della Marna), l'invasione della Francia falliva, e, con essa, l'intera strategia fondata su una vittoria rapida. Non solo la borghesia tedesca ma quella di tutto il mondo si trovò intrappolata nel dilemma se ritirarsi o non. Seguirono massacri senza precedente di milioni di soldati, completamente insensati anche dal punto di vista capitalistico. Lo stesso proletariato fu intrappolato nell'assenza di alcuna prospettiva immediata che potesse mettere fine alla guerra con una propria iniziativa. Il pericolo che sorse poi fu la distruzione della principale condizione materiale e culturale per il socialismo: lo stesso proletariato.
I rivoluzionari sono legati alla propria classe come la parte lo è al tutto. Le minoranze non si potranno mai sostituire alla capacità di organizzarsi e alla creatività delle masse, ma la storia ci insegna che esistono circostanze in cui l'intervento dei rivoluzionari può assumere un'importanza determinante.Tali circostanze vanno ricercate nel processo rivoluzionario quando le masse lottano per la vittoria. E' allora fondamentale aiutare la classe a trovare la strada giusta, a riconoscere le trappole tese dal nemico, ad evitare di arrivare in anticipo o in ritardo all'appuntamento con la storia. Ma esse esistono anche nei momenti di sconfitta, quando è vitale trarne i giusti insegnamenti. Tuttavia, in questo caso, è necessario fare delle distinzioni. Di fronte ad una sconfitta schiacciante, questo compito è fondamentale a lungo termine per trasmettere delle lezioni alle generazioni future. Nel caso della sconfitta del 1914, l’impatto decisivo che i rivoluzionari avrebbero potuto avere era così immediato come durante la stessa rivoluzione, e ciò non solo a causa del carattere non definitivo della sconfitta subita, ma perché le condizioni della guerra, facendo letteralmente della lotta di classe una questione di vita o di morte, fecero emergere una straordinaria accelerazione della politicizzazione.
Di fronte alle privazioni della guerra, era inevitabile che la lotta economica della classe si sviluppasse e prendesse immediatamente un carattere apertamente politico, ma i rivoluzionari non potevano aspettare che ciò si verificasse. Il disorientamento della classe, come abbiamo visto, era soprattutto il prodotto di una mancanza di direzione politica. Era perciò responsabilità di tutti quelli che rimasero rivoluzionari nel movimento operaio d'iniziare l'inversione di corrente. Ben prima degli scioperi sul "fronte interno", anche prima delle rivolte dei soldati nelle trincee, i rivoluzionari dovevano mostrarsi ed affermare il principio della solidarietà proletaria internazionale.
Cominciarono questo lavoro in Parlamento denunciando la guerra e votando contro i crediti di guerra. Fu l'ultima volta che questa tribuna fu usata a fini rivoluzionari. Ma ciò fu accompagnato, fin dall'inizio, dalla propaganda e dall'agitazione rivoluzionarie illegali e dalla partecipazione alle prime manifestazioni per chiedere pane. Un compito di elevata importanza per i rivoluzionari era anche quello di organizzarsi per chiarire il loro punto di vista e, soprattutto, stabilire contatti con i rivoluzionari all'estero e preparare la fondazione di una nuova Internazionale. Il Primo Maggio 1916, lo Spartakusbund (la Lega Spartakus), nucleo del futuro partito comunista (KPD), si sentì per la prima volta abbastanza forte per scendere apertamente in strada e massicciamente. Era il giorno in cui, tradizionalmente, la classe operaia celebrava la sua solidarietà internazionale. Lo Spartakusbund indisse manifestazioni a Dresda, Jena, Hanau, Braunschweig e soprattutto a Berlino. 10.000 persone si concentrarono sulla Postdamer Platz per ascoltare Karl Liebknecht denunciare la guerra imperialista. Una battaglia di strada esplose nel vano tentativo di impedire il suo arresto.
Le proteste del Primo Maggio privarono l'opposizione internazionalista del suo più conosciuto leader. Altri arresti seguirono. Liebknecht fu accusato d'irresponsabilità ed anche di esibizionismo. In realtà, la sua azione del Primo Maggio era stata decisa collettivamente dalla direzione dello Spartakusbund. E' vero che il marxismo critica gli atti vani del terrorismo e l'avventurismo, contando sull'azione collettiva delle masse, ma il gesto di Liebknecht fu ben più che un atto di eroismo individuale. Incarnava le speranze e le aspirazioni di milioni di proletari di fronte alla pazzia della società borghese. Come Rosa Luxemburg scriverà più tardi: “Tuttavia non dimentichiamoci che la storia del mondo non si fa senza grandezza di anima, senza elevati principi morale, senza gesti nobili"[11]. Questa grandezza d'anima si estende rapidamente dallo Spartakusbund ai metallurgici. Il 27 giugno 1916 a Berlino, alla vigilia del processo di Karl Liebknecht, arrestato per avere condotto un'agitazione pubblica contro la guerra, una riunione di delegati di fabbriche fu prevista a seguito alla manifestazione illegale di protesta indetta dallo Spartakusbund. All'ordine del giorno c'era la solidarietà con Liebknecht; contro la resistenza di Georg Ledebour, unico rappresentante presente del gruppo d’opposizione all'interno del Partito socialista, l'azione fu proposta per il giorno seguente. Non ci fu discussione. Tutti si alzarono e rimasero in silenzio.
Il giorno seguente alle 9, i tornitori fermarono le macchine delle grandi fabbriche d'armamento del capitale tedesco. 55.000 lavoratori di Löwe, AEG, Borsig Schwarzkopf deposero i loro attrezzi e si riunirono davanti alle porte delle fabbriche. Nonostante la censura militare, la notizia si estese come un lampo attraverso tutto l'impero: gli operai delle fabbriche d'armamento andarono a solidarizzare con Liebknecht! E non solo a Berlino, ma a Braunschweig, sui cantieri navali di Brema, ecc. Azioni di solidarietà vi furono anche in Russia.
La borghesia spedì migliaia di scioperanti al fronte. I sindacati lanciarono nelle fabbriche una caccia ai "caporioni". Ma non appena veniva arrestato qualcuno la solidarietà degli operai aumentava ancora. Solidarietà proletaria internazionale contro la guerra imperialista: era l'inizio della rivoluzione mondiale, il primo sciopero di massa nella storia della Germania.
La fiamma che si era accesa sulla Postdamer Platz si estese ancora più velocemente fra la gioventù rivoluzionaria. Inspirati dall'esempio dei loro capi politici, prima ancora degli esperti metallurgici, i giovani avevano lanciato il primo più grande sciopero contro la guerra. A Magdeburgo e, soprattutto, nello Braunschweig che era un bastione di Spartakus, le manifestazioni illegali di protesta del Primo Maggio si trasformarono in un movimento di sciopero contro la decisione del governo di versare d'autorità una parte del salario degli apprendisti e dei giovani operai su un conto speciale per finanziare lo sforzo di guerra. Gli adulti entrarono in sciopero di sostegno. Il 5 Maggio, le autorità militari dovettero ritirare questa misura per impedire una maggiore estensione del movimento.
Dopo la battaglia dello Skagerrak nel 1916, solo ed unico scontro di tutta la guerra tra i marinai britannici e tedeschi, un piccolo gruppo di marinai rivoluzionari progettò di impadronirsi della corazzata Hyäne e deviarla verso la Danimarca per fare "una dimostrazione di fronte al mondo intero" contro la guerra[12]. Anche se questo progetto venne rivelato e fatto fallire, esso prefigurava le prime rivolte aperte che ebbero luogo nella marina di guerra, a partire dall’ agosto 1917. Queste presero il via dalle paghe e dalle condizioni di vita degli equipaggi. Ma, rapidamente, i marinai posero un ultimatum al governo: o terminate la guerra, o noi scendiamo in sciopero. Lo Stato rispose con un'ondata di repressione. Due leader rivoluzionari, Albin Köbis e Max Reichpietsches, furono giustiziati.
Dalla metà di aprile 1917, un'ondata di scioperi massicci ebbe luogo a Berlino, Lipsia, Magdeburgo, Halle, Braunschweig, Hannover, Dresda e nelle altre città. Anche se i sindacati e la SPD non osarono più opporsi apertamente, tentarono comunque di limitare il movimento a questioni economiche; ma i lavoratori di Lipsia avevano formulato una serie di richieste politiche - in particolare fermare la guerra - che furono riprese in altre città.
Gli ingredienti di un profondo movimento rivoluzionario esistevano dunque fin dall'inizio 1918. L'ondata di scioperi di aprile 1917 costituì il primo intervento massiccio di centinaia di migliaia di operai in tutto il paese per difendere i loro interessi materiali su un terreno di classe ed opporsi direttamente alla guerra imperialista. Questo movimento fu anche inspirato dalla rivoluzione che era cominciata in Russia a febbraio 1917 e solidarizzava apertamente con questa. L'internazionalismo proletario si era impadronito del cuore della classe operaia.
D'altra parte, con il movimento contro la guerra, la classe operaia aveva ricominciato a produrre la propria direzione rivoluzionaria. Non si trattava solo dei gruppi politici come lo Spartakusbund o la Sinistra di Brema che formeranno nel 1918 il KPD (Partito Comunista tedesco). Parliamo anche della comparsa di strati altamente politicizzati e di centri di vita e di lotta di classe, legati ai rivoluzionari e che simpatizzavano con le loro posizioni. Uno di questi centri si trovava nelle città industriali, in particolare nella metallurgia, e si esprimeva nel fenomeno dell’Obleutes, delegati di fabbriche. "Nella classe operaia industriale esisteva un piccolo nucleo di proletari che non solo rigettavano la guerra, ma che avevano voluto impedire la sua esplosione a qualsiasi costo; e quando scoppiò, decisero che era loro dovere di farla smettere con tutti i mezzi. Erano pochi. Ma persone molto determinate ed attive. Costituivano la contrapposizione a quelli che andavano a morire al fronte per i loro ideali. La lotta contro la guerra nelle fabbriche e negli uffici non conosceva la stessa celebrità della lotta al fronte ma essa comportava gli stessi pericoli. Quelli che la conducevano erano motivati dai più alti ideali dell'umanità"[13].
Un altro di questi centri esisteva nella nuova generazione di operai, fra gli apprendisti ed i giovani operai che non avevano altra prospettiva che essere spediti a morire nelle trincee. Il centro di gravità di questo fermento fu costituito dalle organizzazioni della gioventù socialista che, già prima della guerra, si era caratterizzato rivoltandosi contro "la routine" che stava caratterizzando la vecchia generazione.
Anche all'interno delle forze armate, dove la rivolta contro la guerra impiegò più tempo per svilupparsi rispetto al fronte "interno", si stabilì una posizione politica avanzata. Come in Russia, il centro di resistenza nacque fra i marinai che erano in diretto contatto con gli operai e le organizzazioni politiche nei loro porti d'ormeggio ed il cui lavoro e le condizioni di vita somigliavano molto a quelle degli operai delle fabbriche, da cui in generale essi provenivano. Inoltre, molti marinai furono arruolati nella marina mercantile "civile", e questi erano giovani che avevano viaggiato in tutto il mondo e per i quali la fraternità internazionale non era una formula ma un modo di vita.
Inoltre, la comparsa e la moltiplicazione di queste concentrazioni di vita politica s'accompagnavano ad un'intensa attività teorica. Tutti i testimoni diretti di questo periodo danno conto dell'alto livello teorico dei dibattiti nelle riunioni e nelle conferenze illegali. Questa vita teorica trova la sua espressione nella brochure di Rosa Luxemburg La crisi della Socialdemocrazia, negli scritti di Lenin contro la guerra, negli articoli della rivista di Brema Arbeiterpolitik ed, anche, nella massa di volantini, manifesti e dichiarazioni che circolavano nell'illegalità più totale e che fanno parte delle più profonde e coraggiose produzioni della cultura umana realizzata durante il XX secolo.
Era stata raggiunta la tappa perché venisse aperta la tempesta rivoluzionaria contro uno dei più potenti e più importanti bastioni del capitalismo mondiale.
La seconda parte di questa serie tratterà delle lotte rivoluzionarie del 1918. Esse ebbero inizio dagli scioperi massicci del gennaio 1918 e dal primo tentativo di formare dei consigli operai in Germania che culminarono negli eventi rivoluzionari del 9 novembre che posero fine alla Prima Guerra mondiale.
Steinklopfer
[1] Decisione presa dal Congresso del Partito tedesco a Mannheim, nel 1906.
[2] Nelle sue memorie sul movimento della gioventù proletaria, Willi Münzenberg che era a Zurigo durante la guerra, ricorda il punto di vista di Lenin: "Lenin ci ha spiegato l'errore di Kautsky e della sua scuola teorica di falso marxismo che si attende tutto dallo sviluppo storico dei rapporti economici e quasi niente dai fattori soggettivi d'accelerazione della rivoluzione. All'opposto, Lenin ha sottolineato il significato dell'individuo e delle masse nel processo storico. Ha sottolineato la tesi marxista secondo la quale sono soprattutto gli uomini che, nel quadro di rapporti economici determinati, fanno la storia. Questa insistenza sul valore personale degli individui e dei gruppi nelle lotte sociali ha determinato in noi una grande impressione e ci ha incitati a fare i più grandi sforzi possibili". (Münzenberg, Die Dritte Front "Il terzo fronte" tradotto da noi dal tedesco).
[3] Difendendo giustamente, contro Bernstein, l'esistenza di una tendenza alla scomparsa degli strati intermedi ed alla tendenza alla crisi ed all'impoverimento del proletariato, la sinistra tuttavia non riuscì a capire fino a che punto il capitalismo era temporaneamente arrivato, negli anni che hanno preceduto la guerra, ad attenuare queste tendenze. Questa mancanza di chiarezza si esprime, per esempio nella teoria di Lenin su "l'aristocrazia operaia" secondo la quale solamente una minoranza privilegiata e non grandi settori della classe operaia, aveva ottenuto degli aumenti salariali sostanziali. Ciò portò a sottovalutare l'importanza della base materiale sulla quale si erano sviluppate le illusioni riformiste che hanno permesso alla borghesia di mobilitare il proletariato nella guerra.
[4] "I compiti del proletariato nella nostra rivoluzione", 28 maggio 1917.
[5] "Rosa Luxemburg Speaks" "Discorsi di Rosa Luxemburg" nella Crisi della Socialdemocrazia, Pathfinder Press 1970, tradotta dall'inglese da noi.
[6] Richard Müller, Vom Kaiserreich zur Republik, 1924-25 ("Dall'Impero alla Repubblica"), tradotto da noi dal tedesco.
[7] "Rosa Luxemburg Speaks" "Discorsi di Rosa Luxemburg" ibid. nota 5.
[8] Ibid., nota 5.
[9] Ibid., nota 5.
[10] Ibid., nota 5.
[11] Ibid., nota 5.
[12] "Against Capital Punishment", novembre 1918, ibid., nota 5.
[13] Dieter Nelles: Proletarische Demokratie und Internationale Bruderschaft - Das abenteuerliche Leben des Hermann Knüfken.
Geografiche:
- Germania [10]
Storia del movimento operaio:
Patrimonio della Sinistra Comunista:
Disastri ambientali, inquinamento, variazioni climatiche. Il mondo sulla soglia di un collasso ambientale. 1a parte
- letto 1123 volte
I prodromi della catastrofe
«La fame si sviluppa nei paesi del terzo mondo e ben presto raggiungerà i paesi che si pretendevano “socialisti”, mentre in Europa occidentale e nel Nord America si distruggono stock di prodotti agricoli, si pagano i contadini perché coltivino sempre meno terra, si penalizzano se producono più delle quote imposte. In America Latina, le epidemie, come quella del colera, uccidono migliaia di persone, mentre questo flagello era stato vinto da tempo. Per tutto il mondo inondazioni o terremoti uccidono decine di migliaia di individui in poche ore proprio quando la società è perfettamente in grado di costruire dighe e case che potrebbero evitare una simile ecatombe. Non si può neanche invocare la “fatalità” o i “capricci della natura” quando a Chernobyl, nel 1986, l’esplosione di una centrale atomica uccise centinaia (se non migliaia) di persone e contaminò parecchie province, quando, nei paesi più sviluppati, assistiamo a catastrofi micidiali nel cuore stesso delle grandi città: 60 morti in una stazione parigina, più di 100 morti in un incendio della metropolitana a Londra non molto tempo fa. Ugualmente questo sistema si rivela incapace di contrastare il degrado dell’ambiente, le piogge acide, l’inquinamento di tutti i generi e soprattutto nucleare, l’effetto serra, la desertificazione, cose che mettono in gioco la stessa sopravvivenza della specie umana.»[1]
Se la questione ambientale è stata sempre presente nella propaganda dei rivoluzionari, dalle denunce di Marx ed Engels delle condizioni invivibili della Londra a metà del XIX secolo a quelle di Bordiga sui disastri ambientali provocati dall’irresponsabilità del capitalismo, oggi essa assume una valenza ancora più forte e richiede uno sforzo accresciuto da parte delle organizzazioni rivoluzionarie per mostrare come l’alternativa storica che si pone di fronte all’umanità, socialismo o barbarie, non si gioca più soltanto a livello di guerre, locali o generalizzate che siano, perché si manifesta in maniera sempre più chiara all’orizzonte il rischio di un collasso ecologico-ambientale.
Con questa serie di articoli la CCI intende sviluppare la questione ambientale affrontando, progressivamente, i seguenti aspetti:
- in questo primo articolo una denuncia dello stato attuale delle cose, cercando di mostrare l’entità del rischio di fronte al quale si trova l’umanità ed in particolare i fenomeni più laceranti che esistono a livello planetario come:
- l’incremento dell’effetto serra,
- la gestione dei rifiuti;
- la sempre maggiore diffusione dei contaminanti con i relativi processi di biomagnificazione,
- l’esaurimento delle risorse naturali e/o la loro compromissione per contaminazione;
- nel secondo articolo cercheremo di mostrare come i problemi ambientali non possono essere attribuiti a delle singole persone - benché esistano anche chiare responsabilità personali – nella misura in cui la vera responsabilità è del capitalismo e della sua logica di massimo profitto. A tale proposito vedremo come la stessa evoluzione della scienza e della ricerca scientifica non sono casuali ma subordinate all’imperativo capitalista della realizzazione del massimo profitto;
- nel terzo articolo analizzeremo le risposte date dai vari movimenti verdi, ecologisti, ecc. per dimostrarne - malgrado la buona fede e tutta la buona volontà di chi vi partecipa – la totale inefficacia e per affermare al contrario che l’unica soluzione possibile è la rivoluzione comunista internazionale;
1. I prodromi della catastrofe
Di problemi ambientali ormai si parla sempre più frequentemente, non fosse altro per il fatto che sono nati addirittura dei partiti nei vari paesi del mondo che hanno fatto della questione ambientale la loro bandiera. Ma possiamo stare tranquilli? Tutt’altro. Tanto clamore su questo tema ha la sola funzione di confonderci ancora più le idee. Motivo per cui abbiamo scelto di partire proprio dalla descrizione dei singoli fenomeni che nel loro insieme stanno spingendo la nostra società sempre più speditamente verso il collasso ambientale. Come vedremo – e contrariamente a quello che ci raccontano per televisione o sulle riviste patinate più o meno specializzate – la situazione è ben più grave e rischiosa di quanto si voglia far credere e soprattutto non è responsabilità di questo o quel mafioso o camorrista, di questo o quel capitalista avido e irresponsabile, ma del sistema capitalista in quanto tale.
1.1 L’incremento dell’effetto serra
L’effetto serra è una di quelle cose di cui tutti parlano ma non sempre con cognizione di causa. Cominciamo dunque col dire che l’effetto serra è un fenomeno del tutto benefico per la vita sulla terra - almeno per il tipo di vita che conosciamo - nella misura in cui permette che sulla superficie del nostro pianeta vi sia una temperatura media (sulle quattro stagioni e alle varie latitudini) di circa +15°C piuttosto che di -17°C, temperatura prevista in assenza di effetto serra. C’è da immaginarsi cosa sarebbe un mondo permanentemente sotto gli 0°C, con mari ghiacciati, fiumi ghiacciati … Ma a cosa dobbiamo questo surplus di ben 32°C di temperatura? All’effetto serra, ovvero al fatto che mentre la luce del sole attraversa gli strati bassi dell’aria senza essere assorbita (il sole non riscalda l’aria!), la radiazione che emana dalla terra (così come da qualunque altro corpo celeste), essendo costituita essenzialmente di radiazioni infrarosse, viene intercettata e assorbita abbondantemente da alcune componenti dell’aria come l’anidride carbonica, il vapor d’acqua, il metano ed altri composti di sintesi come i CFC (clorofluorocarburi). Ciò fa sì che il bilancio termico della terra usufruisca di questo calore trattenuto dagli strati bassi dell’atmosfera incrementando la temperatura della propria superficie del valore citato. Il problema dunque non sta nell’effetto serra in quanto tale, quanto nel fatto che, con lo sviluppo della società industriale, sono state immesse in atmosfera molte sostanze “ad effetto serra” facendone aumentare sensibilmente la concentrazione e incrementando di conseguenza lo stesso effetto serra. Ad esempio è stato dimostrato, attraverso studi condotti sull’aria intrappolata in carote di ghiaccio estratte dalle calotte polari e risalenti fino a 650.000 anni fa, che la concentrazione di anidride carbonica attuale, di 380 parti per milione (ppm), è la più elevata in tutto questo periodo e forse addirittura degli ultimi 20 milioni di anni. Ancora che le temperature registrate durante il 20° secolo risultano essere le più elevate degli ultimi 20.000 anni. Il ricorso forsennato ai combustibili fossili come fonte di energia e la crescente deforestazione della superficie terrestre hanno compromesso, a partire dall’era industriale, l’equilibrio naturale dell’anidride carbonica dell’atmosfera, che si basa da un lato sulla sua liberazione in atmosfera attraverso la combustione e la degradazione di materiali organici, dall’altro sulla cattura dall’atmosfera della stessa anidride carbonica attraverso il processo di fotosintesi per trasformarla in zucchero e dunque in materiali organici complessi. Lo squilibrio tra liberazione (combustione) e cattura (fotosintesi) della CO2 è alla base dell’attuale effetto serra.
Ma, come già detto, non c’è solo l’anidride carbonica, ma anche l’acqua e il metano. Il maggiore o minore contributo del vapore d’acqua procede parallelamente all’evolvere dell’effetto serra essendo il vapore d’acqua presente nell’atmosfera in misura tanto maggiore quanto maggiore è la temperatura. Per cui l’incremento dell’effetto serra si rinvigorisce a sua volta grazie ad una maggiore evaporazione dell’acqua. L’incremento del metano in atmosfera proviene invece da una serie di fonti naturali, ma anche dal maggiore uso che si fa di questo gas come combustibile e dalle perdite che si producono dai vari gasdotti disseminati sulla superficie terrestre. Tra l’altro il metano, detto anche gas di palude, è tipicamente quel gas che si produce dalla fermentazione di materiali organici in assenza di ossigeno e sempre più le valli boscose inondate per la costruzione di dighe di centrali idroelettriche sono all’origine di produzioni locali di metano. Ma il problema del metano, che attualmente contribuisce all’incremento dell’effetto serra per circa un terzo rispetto al biossido di carbonio, è ben più grave di quanto non possa apparire da questi elementi esposti. Anzitutto il metano ha una capacità di assorbire le radiazioni infrarosse che è 23 superiore a quella della CO2, il che è già tanto. Ma c’è di più! Tutte le previsioni attuali, già sufficientemente catastrofiche, non tengono conto dello scenario che si potrebbe presentare in conseguenza della liberazione di metano dall’enorme serbatoio naturale della terra costituito dalle sacche di gas intrappolato a circa 0°C e a qualche atmosfera di pressione in strutture particolari di ghiaccio, i cosiddetti clatrati (o gas idrati), dove 1 litro di cristallo è capace di trattenere oltre 50 litri di gas metano. Tali giacimenti si trovano soprattutto in mare lungo le scarpate continentali e all’interno del permafrost, terreno ghiacciato presente a pochi metri di profondità in varie zone della Siberia, Alaska e Nord Europa. Ecco il parere di alcuni esperti del settore:
“Se il riscaldamento globale superasse certi limiti (3-4° C) e si innalzasse la temperatura delle acque costiere e del permafrost, si potrebbe avere una enorme emissione, in tempi brevi (decine di anni) di metano liberato dagli idrati resi instabili e ciò innescherebbe un incremento dell’effetto serra di tipo catastrofico. Si tenga presente che nell’ultimo anno le emissioni di metano dal suolo svedese a nord del circolo polare artico sono aumentate del 60% e che l’aumento di temperatura degli ultimi 15 anni è limitato come media globale, ma è molto più intenso (alcuni gradi) nelle aree più settentrionali dell’Eurasia e dell’America (d’estate si è aperto il mitico passaggio a Nord-Ovest che consente di andare in nave dall’Atlantico al Pacifico).”[2]
Ma già senza questa chicca finale, le previsioni sviluppate da strutture riconosciute a livello internazionale come l’Agenzia IPCC dell’ONU e l’MIT di Boston prevedono per il secolo in corso un incremento di temperatura medio che va da un minimo di 0,5°C fino ad un massimo di 4,5°C nell’ipotesi che, come sta avvenendo, nulla si muova a livello sostanziale. E tali previsioni non tengono neanche conto dell’emergenza delle due nuove potenze industriali divoratrici di energia quali la Cina e l’India.
“Un ulteriore riscaldamento di qualche grado centigrado provocherebbe una più intensa evaporazione delle acque oceaniche, ma le analisi più sofisticate suggeriscono che vi sarebbero disparità accentuate nella piovosità su differenti regioni. Le aree aride si estenderebbero e diventerebbero ancora più aride. Le zone degli oceani con temperature superficiali maggiori di 27° C, valore critico per la formazione di cicloni, aumenterebbero del 30-40%. Ciò creerebbe eventi meteorologici catastrofici in continuazione, con inondazioni e devastazioni ricorrenti. La fusione di buona parte dei ghiacciai antartici e groenlandesi e l’aumento di temperatura degli oceani farebbero innalzare l’altezza di questi ultimi (…) con l’invasione di acque salate in molte zone costieri fertili e la sommersione di intere regioni (parte del Bangladesh e molte isole oceaniche”.[3]
Non c’è qui lo spazio per sviluppare ancora in dettaglio questo tema, ma vale la pena almeno di accennare al fatto che il cambiamento climatico provocato dall’incremento dell’effetto serra, anche se non arrivasse all’effetto feed-back prodotto potenzialmente dalla liberazione di metano, rischierebbe ugualmente di essere catastrofico anche perché il mutato clima provocherebbe:
· una maggiore energia degli eventi meteorologici, un maggiore dilavamento dei terreni da parte di piogge molto più intense con una conseguente perdita di fertilità e l’innesco di processi di desertificazione anche in zone a clima meno temperato, come già sta succedendo in Piemonte (Italia);
· la creazione, nel Mediterraneo ed in altri mari una volta temperati, di condizioni ambientali favorevoli alla sopravvivenza di specie marine tropicali, con la conseguente migrazione di specie aliene e dunque con lo scombussolamento dell’equilibrio ecologico;
· il ritorno di vecchie malattie già debellate come la malaria, dovuto all’instaurazione di condizioni climatiche favorevoli alla crescita e diffusione degli organismi vettori come le zanzare, ecc.
1.2 Il problema della produzione e della gestione dei rifiuti
Un secondo tipo di problema tipico di questa fase della società capitalista è l’eccessiva produzione di rifiuti e la conseguente difficoltà a smaltirli adeguatamente. Se recentemente è arrivata all’“onore” della cronaca internazionale la notizia della presenza di cumuli di rifiuti sparsi per tutte le strade di Napoli e della Campania, questo è dovuto solo al fatto che questa regione del mondo è ancora considerata, tutto sommato, come facente parte di un paese industrializzato e dunque avanzato. Ma il fatto che le periferie di tante grandi città di paesi del terzo mondo siano diventate esse stesse discariche libere e abusive a cielo aperto è una realtà ormai consolidata.
Questo accumulo enorme di rifiuti è il risultato della logica di funzionamento del capitalismo. Infatti, se è vero che l’umanità ha sempre prodotto rifiuti, in passato questi venivano sempre reintegrati, riutilizzati, recuperati. E’ soltanto oggi, con il capitalismo, che il rifiuto diventa un problema per i meccanismi specifici secondo i quali funziona questa società e che partono tutti da un principio fondamentale: qualunque prodotto dell’attività umana viene considerato come merce, cioè qualcosa destinata ad essere venduta per realizzare il massimo profitto in un mercato dove l’unica legge è quella della concorrenza. Ciò ha una serie di conseguenze nefaste:
- una produzione delle merci non può essere programmata per la concorrenza tra capitalisti, segue dunque una logica irrazionale, dove ogni singolo capitalista punta sull’allargamento della propria produzione per vendere a più bassi prezzi e ricavare i suoi profitti, con la conseguenza di avere un’eccedenza di merci invendute. Peraltro proprio questa necessità di vincere la concorrenza e di abbassare i prezzi spinge i produttori ad abbassare la qualità dei manufatti, con la conseguenza che il tempo di vita della merce si riduce drasticamente trasformandosi più velocemente in rifiuto;
- una produzione abnorme di involucri, imballaggi, ecc. costituiti tra l’altro in larga misura da sostanze tossiche non degradabili che si accumulano nell’ambiente. Questi imballaggi, che spesso non hanno alcuna funzionalità se non quella di rendere la merce più appetibile per il potenziale acquirente, costituiscono quasi sempre una parte preminente, a livello di peso e di volume, rispetto al contenuto di merce venduta. Si pensi che ormai un sacchetto di rifiuti urbani indifferenziati è per metà occupato solo da materiali provenienti dagli imballaggi.
- una produzione di rifiuti accentuata da nuovi stili di vita che ci vengono imposti dalla vita moderna. Mangiare fuori casa ad un self-service in piatti di plastica e bere acqua minerale da bottiglie di plastica è ormai una realtà di centinaia di milioni di persone per il mondo tutti i giorni. Ugualmente l’uso di buste di plastica per fare acquisti è una comodità a cui quasi nessuno riesce a fare a meno. Tutto questo fa male all’ambiente evidentemente, ma fa tanto bene alle tasche del gestore del self-service che non ha l’onere di un lavapiatti al lavoro per tutta la giornata e fa ancora tanto bene alle tasche del gestore del supermercato o anche del negoziante rionale perché permette al cliente di comprare quello che vuole in ogni momento anche se non aveva programmato di fare acquisti perché il sacchetto è pronto per servirlo.
Tutto ciò ha portato ad un incremento considerevole della produzione di rifiuti in tutto il mondo, arrivando a circa 1 kg al giorno per ogni cittadino del mondo, ovvero a svariati milioni di tonnellate di rifiuti … al giorno!
Si pensi che solo in Italia, negli ultimi 25 anni, a parità di popolazione, la quantità di rifiuti è più che raddoppiata grazie ai materiali che costituiscono gli imballaggi.
Il problema dei rifiuti è uno di quelli che tutti pensano di poter risolvere ma che di fatto trovano nel capitalismo degli ostacoli insormontabili. Ma tali ostacoli non sono legati alla mancanza di tecnologia, tutt’altro, ma ancora una volta alla logica secondo la quale questa società viene gestita. In realtà la gestione dei rifiuti è parte di un processo che parte dalla produzione dei beni, passa attraverso l’utilizzazione di questi ultimi fino a che questi non diventano rifiuti. Ora, fermo restando il fatto che è possibile - attraverso la raccolta differenziata - il riciclo e il riuso di materiali e oggetti vari, quest’ultima sezione ha comunque dei costi di gestione e richiede anche un certa capacità politica di coordinamento che manca in genere alle economie più deboli. Per cui nei paesi più poveri e dove le attività imprenditoriali sono in declino per la crisi galoppante di questi ultimi decenni, gestire i rifiuti diventa solo un onere.
Ma qualcuno obietta: se nei paesi avanzati la gestione dei rifiuti funziona, ciò significa che è solo questione di buona volontà, di civiltà e di buona capacità imprenditoriale. Il problema è che, come in tutti i settori della produzione, anche in quello dei rifiuti i paesi forti scaricano su quelli deboli (o al loro interno sulle loro regioni economicamente più depresse) il peso di una parte della loro gestione.
“Due gruppi ambientalisti americani, Basel Action Network e Silicon Valley Toxics hanno recentemente pubblicato un rapporto che afferma che dal 50 all’80 per cento dei rifiuti elettronici degli Stati americani dell’Ovest sono caricati sui container di navi in partenza per l’Asia (Sopratutto India e Cina), dove i costi di smaltimento sono nettamente più bassi e le leggi ambientali meno severe. Non si tratta di progetti di sostegno, ma di un commercio di rifiuti tossici che i consumatori hanno deciso di gettare. Il rapporto delle due associazioni fa per esempio riferimento alla discarica cinese di Guiyu, che raccoglie soprattutto monitor e stampanti. I lavoratori di Guiyu usano strumenti di lavoro rudimentali per estrarre componenti destinate a essere rivendute: “Un’impressionante quantità di rifiuti elettronici non viene riciclata ma viene semplicemente abbandonata all’aperto nei campi, sulle rive dei fiumi, negli stagni, nelle paludi, nei fiumi e nei canali di irrigazione”. A lavorare senza nessuna precauzione vi sono donne, uomini e bambini.”[4]
“In Italia (…) si stima un volume di affari per le ecomafie di 26.000 miliardi annui, di cui 15.000 per il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti (Rapporto Ecomafia 2007 di Lega Ambiente). (…) L’Agenzia delle Dogane ha sequestrato nel 2006 circa 286 container con oltre 9.000 t. di rifiuti. Lo smaltimento legale di un container di 15 t. di rifiuti pericolosi costa circa 60.000 euro; per la stessa quantità, il mercato illegale in Oriente ne chiede solo 5.000.
Tra le mete principali dei traffici illegali vi sono molti paesi asiatici in via di sviluppo: i materiali esportati prima vengono lavorati e poi reintrodotti in Italia, o in altri paesi occidentali, come derivati degli stessi rifiuti per essere destinati, in particolare, a fabbriche di materiali plastici.
La FAO, nel giugno del 1992, annunciò che gli Stati in via di sviluppo e soprattutto africani erano diventati una “pattumiera” a disposizione dell’Occidente. La Somalia sembra oggi essere uno degli Stati africani più a rischio, un vero e proprio crocevia di scambi e traffici di questo genere: in un recente rapporto l’UNEP fa notare il costante aumento delle falde acquifere avvelenate trovate in Somalia, che genera malattie incurabili nella popolazione. Il porto di Lagos, in Nigeria, è il più importante scalo del traffico illegale di componenti tecnologiche obsolete dirette verso l’Africa.
Nel maggio scorso il Parlamento panafricano (PAP) ha chiesto ai Paesi occidentali un risarcimento per i danni procurati dall’effetto serra e dall’abbandono di rifiuti nel continente, due problemi che, secondo le autorità africane, sono responsabilità dei paesi più industrializzati del mondo.
Ogni anno nel mondo si producono dai 20 ai 50 milioni di t. di “spazzatura elettronica”; in Europa si parla di 11 milioni di t., di cui l’80% finisce in discarica. Si stima che entro il 2008 nel mondo si conteranno almeno un miliardo di pc (uno ogni sei abitanti); entro il 2015 saranno più di due miliardi. Questo dato costituirà un ulteriore e gravissimo pericolo per il problema dello smaltimento della tecnologia obsoleta.” [5]
Ma, come dicevamo prima, lo scaricare il problema dei rifiuti sulle aree più depresse avviene anche all’interno di uno stesso paese. E’ proprio il caso della Campania in Italia arrivata alle cronache internazionali per l’accumulo di rifiuti rimasti per le strade per mesi e mesi. Ma ben pochi sanno che la Campania, come - a livello internazionale - la Cina, l’India o i paesi nordafricani, è il ricettacolo di tutti i rifiuti tossici delle industrie del nord che hanno fatto delle ridenti e fertili zone agricole del casertano una delle aree più contaminate del pianeta. Nonostante le diverse azioni della magistratura che si accavallano l’una all’altra, lo scempio continua indisturbato. Ancora una volta non è la camorra, la mafia, la malavita a produrre i guasti, ma la logica del capitalismo. Infatti, mentre la procedura ufficiale per smaltire correttamente 1 chilo di rifiuti tossici comporta una spesa che può superare i 60 centesimi, attraverso dei canali illegali e con la manovalanza della malavita lo stesso servizio costa si e no una diecina di centesimi. E così che ogni fosso, ogni cava abbandonata, è diventata una discarica a cielo aperto. Addirittura in un paesino della Campania, dove stanno per costruire anche un inceneritore, questi materiali tossici, mischiati a del terreno per camuffarli, sono stati utilizzati per creare un fondo stradale di un lungo viale in “terra battuta”. Come dice Saviano, nel libro che in Italia è diventato un cult:
“Se i rifiuti illegali gestiti dalla camorra fossero accorpati diverrebbero una montagna di 14.600 metri con una base di tre ettari: la più grande montagna mai esistita sulla terra.”[6]
D’altra parte, come vedremo meglio nel prossimo articolo, il problema dei rifiuti nasce anzitutto dal tipo di produzione che la società attuale porta avanti. Al di là dell’“usa e getta”, il problema sta spesso nei materiali che si utilizzano per fare i singoli oggetti. In particolare il ricorso a materiali sintetici e particolarmente ai materiali plastici praticamente indistruttibili pone dei problemi immensi all’umanità di domani. E stavolta non si tratta neanche più di paesi ricchi o poveri perché la plastica è non degradabile in qualunque paese del mondo, come possiamo evincere da questo stralcio di articolo:
“Lo chiamano Pacific Trash Vortex, il vortice di spazzatura dell’Oceano Pacifico che ha un diametro di circa 2500 chilometri, è profondo 30 metri ed è composto per l'80% da plastica e il resto da altri rifiuti che giungono da ogni dove. “E' come se fosse un’immensa isola nel mezzo dell’Oceano Pacifico composta da spazzatura anziché rocce. Nelle ultime settimane la densità di tale materiale ha raggiunto un tale valore che il peso complessiva di questa “isola” di rifiuti raggiunge i 3,5 milioni di tonnellate”, spiega Chris Parry del California Coastal Commission di San Francisco (…). Questa incredibile e poco conosciuta discarica si è formata a partire dagli anni Cinquanta, in seguito all’esistenza della North Pacific Subtropical Gyre, una lenta corrente oceanica che si muove in senso orario a spirale, prodotta da un sistema di correnti ad alta pressione. (….) La maggior parte della plastica giunge dai continenti, circa l'80%, solo il resto proviene da navi private o commerciali e da navi pescherecce. Nel mondo vengono prodotti circa 100 miliardi di chilogrammi all’anno di plastica, dei quali, grosso modo, il 10% finisce in mare. Il 70% di questa plastica poi, finirà sul fondo degli oceani danneggiando la vita dei fondali. Il resto continua a galleggiare. La maggior parte di questa plastica è poco biodegradabile e finisce per sminuzzarsi in particelle piccolissime che poi finiscono nello stomaco di molti animali marini portandoli alla loro morte. Quella che rimane si decomporrà solo tra centinaia di anni, provocando da qui ad allora danni alla vita marina”.[7]
Una massa di rifiuti estesa quanto due volte la superficie degli Stati Uniti! L’hanno vista solo ora? Niente affatto: è stata scoperta nel 1997 da un ex petroliere che navigava sul suo yacht e adesso si viene a sapere che “un rapporto dell’ONU del 2006 calcola che un milione di uccelli marini e oltre 100 mila pesci e mammiferi marini all’anno muoiano a causa dei detriti di plastica e che ogni miglio quadrato nautico di oceano contenga almeno 46 mila pezzi di plastica galleggiante” [8].
Ma cosa è stato fatto in questi dieci anni da chi ha il mano le redini della società? Assolutamente nulla! D’altra parte situazioni simili, anche se non altrettanto drammatiche, si lamentano anche nel Mediterraneo nelle cui acque ogni anno si riversano 6,5 milioni di tonnellate di spazzatura, di cui l’80% costituita da plastica, e sui cui fondali si arrivano a contare circa 2000 pezzi di plastica per chilometro quadrato.[9]
Eppure le soluzioni esistono. La plastica biodegradabile fatta con una percentuale fino all’85% di amido di mais e completamente biodegradabile ad esempio è una realtà già oggi: esistono buste, penne e oggetti vari fatti di questo materiale. Ma l’industria difficilmente abbraccia una strada se questa non è la più redditizia, e poiché la plastica a base di amidi costa di più, nessuno si accolla i costi in più di un materiale biodegradabile per evitare di uscire dal mercato[10]. Il problema è che i capitalisti sono abituati a fare i bilanci economici escludendo sistematicamente alcune voci, che non sono esprimibili in danaro perché giustamente non si possono né comprare né vendere, e si tratta della salute della popolazione e dell’ambiente. Tutte le volte che un industriale produce un materiale che al termine del suo ciclo di vita diventa rifiuto, le spese materiali per la gestione di questo rifiuto non sono quasi mai computate, ma soprattutto non sono mai computati i danni che la permanenza di questo materiale sulla terra comporta.
C’è da fare un’ulteriore considerazione sul problema dei rifiuti, cioè che il ricorso a discariche o agli stessi inceneritori comporta uno spreco di tutto il valore energetico e di tutti i materiali utili che essi contengono. E’ provato, ad esempio, che produrre alcuni materiali come rame e alluminio da materiali riciclati comporta un abbattimento delle spese di produzione che può arrivare ad oltre il 90%. Questo fa sì che nei paesi periferici le discariche diventino una vera fonte di sussistenza per migliaia e migliaia di persone che hanno abbandonato le campagne ma che non riescono a integrarsi nel tessuto economico delle città. Si cerca tra i rifiuti qualunque cosa possa essere rivenduto:
“Sono sorte così vere e proprie “città discariche”. Quelle africane della baraccopoli di Korogocho a Nairobi - più volte descritta da padre Zanotelli - e quelle meno note di Kigali in Rwanda; ma anche nello Zambia, dove il 90 per cento di spazzatura non viene raccolto e si accumula nelle strade, mentre la discarica di Olososua, in Nigeria, accoglie ogni giorno oltre mille camion di rifiuti. In Asia, a Manila, è tristemente famosa Payatas a Quezon City, una baraccopoli dove vivono oltre 25 mila persone: è sorta sul pendio di una collina di rifiuti, la “montagna fumante” dove adulti e bambini si contendono materiali da rivendere. Ma c’è anche Paradise Village che non è un villaggio turistico, bensì una bidonville cresciuta sopra un acquitrino dove gli allagamenti sono puntuali come le piogge monsoniche. E poi “Dumpsite Catmon”, la discarica sulla quale si è sviluppata la baraccopoli che sovrasta Paradise Village. In Cina, a Pechino, le discariche sono abitate da migliaia di persone che riciclano rifiuti illeciti, mentre l’India con i suoi slums metropolitani è il paese più densamente popolato dai “sopravvissuti dei rifiuti”.[11]
1.3 La diffusione dei contaminanti
I contaminanti sono sostanze, naturali o sintetiche, che risultano tossiche per l’uomo e/o per il mondo vivente. A parte le sostanze naturalmente presenti da sempre sul nostro pianeta e usate in vario modo nella tecnologia industriale, tra cui i metalli pesanti, l’amianto, ecc., di sostanze tossiche l’industria chimica ne ha prodotte a diecine di migliaia e in quantità … industriali. La mancanza di conoscenze sulla pericolosità di tutta una serie di sostanze ma soprattutto il cinismo della produzione capitalista ha prodotto disastri inimmaginabili producendo una situazione ambientale che sarà veramente difficile rimettere in sesto una volta estromessa la classe dominante attuale.
Uno degli episodi tra i più catastrofici dell’industria chimica è stato senz’altro quello di Bhopal, in India, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984 nella fabbrica della Union Carbide, multinazionale chimica americana. Una nube tossica di 40 tonnellate di pesticidi uccise, alcune subito, altre negli anni successivi, almeno sedicimila persone e segnò per la vita con danni pesantissimi un altro mezzo milione di persone. Le indagini successive hanno poi appurato che, contrariamente a quanto era presente nell’impianto gemello collocato in Virginia, in quello di Bhopal non c’erano misuratori di pressione, sistemi di refrigerazione, la torre di raffreddamento era temporaneamente chiusa e che era noto ai dirigenti della compagnia che i sistemi di sicurezza erano inadeguati per un impianto di quelle dimensioni. Ma la verità è che l’impianto indiano, condotto con mano d’opera a bassissimo prezzo, era per gli americani un investimento a tutto tondo con ricavi eccezionali visto il ridotto investimento di capitali fissi e variabili …
Altro episodio storico è poi quello dell’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl del 1986.
“È stato stimato che il rilascio di radioattività dal reattore n.4 di Chernobyl sia stato circa 200 volte superiore alle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki messe insieme. In tutto, sono state seriamente contaminate aree in cui vivono 9 milioni di persone tra Russia, Ucraina e Bielorussia, dove il 30 per cento del territorio è contaminato dal cesio-137. Nei tre paesi circa 400 mila persone sono state evacuate, mentre altre 270 mila vivono in aree in cui vigono restrizioni all’uso del cibo prodotto localmente.”[12]
Ovviamente resta la miriade di disastri ambientali prodotti dalla cattiva gestione di impianti o da incidenti, come le innumerevoli dispersioni di greggio in mare, tra cui quello provocato dalla petroliera Exxon Valdez il 24 marzo 1989 che, incagliatasi sulla costa dell’Alaska, provocò la fuoriuscita di almeno 30.000 tonnellate di petrolio, o ancora la prima guerra del Golfo conclusasi con i vari pozzi petroliferi in fiamme e con un disastro ecologico prodotto da dispersione di petrolio nel golfo persico che è a tutt’oggi il più grave della storia. Più in generale si pensi che, secondo la U.S. National Academy of Sciences, la quantità di idrocarburi che si perde ogni anno in mare si aggirerebbe su una media di 3-4 milioni di tonnellate, con tendenza ad aumentare nonostante i vari interventi preventivi a causa del continuo incremento dei consumi.
Ma, al di là dei contaminanti che, per le dosi a cui si trovano nell’ambiente, provocano un’intossicazione acuta, non bisogna sottovalutare un altro meccanismo di intossicazione, più lento e più subdolo, che è quello dell’intossicazione cronica. Infatti un tossico assorbito lentamente e a piccole dosi, se chimicamente stabile, si può accumulare progressivamente negli organi e tessuti di un organismo vivente fino a raggiungere concentrazioni tali da risultare letale. Questo è quello che, dal punto di vista eco-tossicologico, prende il nome di bioaccumulo. Esiste poi un altro meccanismo che prende il nome di biomagnificazione e che corrisponde al fatto che un tossico si possa trasmettere, attraverso la rete alimentare, da stadi trofici inferiori a stadi trofici superiori, aumentando ogni volta la propria concentrazione di due o tre ordini di grandezza.
Per capire questo fenomeno la cosa migliore è riferirsi immediatamente ad un caso reale che si è verificato nel 1953 nella baia di Minamata, in Giappone, dove viveva una povera comunità di pescatori che si alimentavano essenzialmente del pesce da loro stessi pescato. Nelle prossimità di quella baia esisteva un insediamento industriale che produceva acetaldeide, un composto chimico di sintesi per la cui preparazione era necessario l’uso di un derivato del mercurio. Gli scarichi a mare di questa industria comportavano anche una leggera contaminazione da mercurio, che però era dell’ordine di grandezza di 0,1 microgrammi per litro di acqua marina, ovvero una concentrazione che, con le strumentazioni ben più sofisticate oggi disponibili, si prova ancora difficoltà a determinare. Quale fu la conseguenza di questa contaminazione apparentemente appena percettibile? 48 persone morirono in pochi giorni, 156 rimasero intossicati con gravi conseguenze, i gatti dei pescatori, che si erano essi stessi cibati a lungo degli avanzi di pesce, finirono “suicidi” a mare, assumendo un comportamento del tutto inusuale per un felino. Cosa era successo? Il mercurio presente nelle acque del mare era stato assorbito e organicato dal fitoplancton, poi successivamente si era trasferito da questo allo zooplancton, poi ancora ai piccoli molluschi, successivamente ai pesci di taglia piccola e media, seguendo sempre le linee di sviluppo della rete trofica in cui lo stesso materiale contaminante, chimicamente indistruttibile, si trasmetteva nel nuovo organismo ospite ad una concentrazione crescente ed inversamente proporzionale al rapporto tra la taglia del predatore e la massa di alimento predato nella propria vita. Così si scoprì che nei pesci questo metallo era arrivato alla concentrazione di 50 milligrammi per ogni kilogrammo, cioè si era concentrato di ben 500.000 volte, ed ancora che in alcuni pescatori colti dalla “sindrome di Minamata”, nei cui organismi si era prodotto un ulteriore incremento di concentrazione, era stata riscontrata una concentrazione che superava il mezzo grammo di mercurio per ogni chilo di capelli.
Nonostante il fatto che dall’inizio degli anni ’60 il mondo scientifico fosse consapevole del fatto che, nei confronti delle sostanze tossiche, non è affatto sufficiente un’azione di diluizione in natura perché, come mostrato, i meccanismi biologici sono capaci di concentrare quello che l’uomo diluisce, l’industria chimica ha continuato e continua ancora a contaminare in lungo e in largo il nostro pianeta, e stavolta senza neanche più la scusa che “non si sapeva quello che sarebbe potuto succedere …”.
Così una seconda Minamata si produce in anni molto più recenti a Priolo, in Sicilia (Italia), in una striscia di terra avvelenata che ospita nel raggio di pochi chilometri ben cinque raffinerie, dove viene accertato che l’Enichem scarica illegalmente mercurio dall’impianto di produzione elettrolitica di cloro e soda. Tra il 1991 e il 2001 circa 1000 bambini nascono con gravi handicap mentali e forti malformazioni sia al cuore che all’apparato urogenitale, famiglie intere vengono stroncate da tumori e numerose donne disperate sono costrette ad abortire per liberarsi dei figli-mostri che avevano concepito. Eppure l’episodio di Minamata aveva già mostrato tutti i rischi del mercurio sulla salute umana! Quella di Priolo non è più dunque una distrazione, un tragico errore, ma un atto di banditismo vero e proprio perpetrato dal capitalismo italiano, anzi proprio da quel capitalismo “statale” che alcuni vorrebbero più “di sinistra” rispetto a quello privato. Nella realtà si è scoperto che la dirigenza dell’Enichem agiva come la peggiore ecomafia: per risparmiare i costi dello smaltimento (si parla di diversi milioni di euro risparmiati) i rifiuti contenenti mercurio venivano miscelati con altri liquami e gettati in mare, nei tombini oppure sotterrati; inoltre si producevano certificati falsi, si utilizzavano cisterne con doppi fondi per camuffare il traffico di rifiuti pericolosi, e così via. Quando finalmente la magistratura si è messa in moto arrestando la dirigenza dell’industria, la responsabilità è stata così palese che l’Enichem si è decisa a rimborsare le famiglie colpite con 11 milioni di euro, una cifra equivalente a quella che avrebbe dovuto pagare in caso di condanna da parre del tribunale.
Ma al di là delle fonti di contaminazione puntuali, è tutta la società che, per come funziona oggigiorno, produce continuamente contaminanti che vanno ad accumularsi nell’aria, nelle acque e nei terreni e - come già detto - in tutta la biosfera, compresi noi umani. L’uso massiccio di detergenti e altri prodotti hanno condotto a fenomeni di eutrofizzazione di fiumi, laghi e mari. Negli anni ’90, per ogni anno, il Mare del Nord ha ricevuto 6.000-11.000 tonnellate di piombo, 22.000-28.000 t di zinco, 4.200 t di cromo, 4.000 t di rame, 1450 t di nickel, 530 t di cadmio, 1.5 milioni di tonnellate di azoto combinato ed oltre 100.000 t di fosfato. Questi scarichi così ricchi di materiali inquinanti sono particolarmente pericolosi proprio in mari caratterizzati da estesa platea continentale (ovvero poco profondi anche al largo), come appunto il mare del Nord, ma anche il Baltico, l’Adriatico settentrionale, il Mar Nero, perché la scarsa massa di acqua marina, oltre alla difficoltà di miscelamento tra le acque dolci di fiume e quelle saline e più dense del mare, non permette un’opportuna diluizione della contaminazione.
Ancora prodotti di sintesi come lo storico insetticida DDT, messo fuori legge nei paesi industrializzati ormai da una trentina di anni, o ancora i PCB, policlorobifenili, usati una volta nell’industria elettrica ed anch’essi ormai fuori produzione perché proibiti dalla normativa attuale, entrambi di una solidità chimica indescrivibile, si ritrovano attualmente inalterati un po’ dappertutto, nelle acque, nei terreni e … nei tessuti degli organismi viventi. Grazie sempre alla biomagnificazione questi materiali si sono a volte concentrati pericolosamente in alcune specie animali provocandone una forte moria o il declino della popolazione per danni importanti all’apparato riproduttivo degli animali. Naturalmente va preso in considerazione in questo ambito quanto abbiamo riportato più sopra a proposito dei traffici di rifiuti pericolosi che, collocati spesso in maniera abusiva in luoghi privi di ogni protezione per le matrici ambientali, provocano dei danni incalcolabili all’ecosistema e a tutta la popolazione della zona.
Per chiudere con questo argomento - ma in tutta evidenza ci sarebbe ancora da riportare le centinaia e centinaia di casi reali che si presentano a livello mondiale – c’è ancora da ricordare che proprio questa contaminazione diffusa del territorio sta portando ad un fenomeno nuovo e drammatico: la creazione di aree della morte, come appunto in Italia il triangolo tra Priolo, Melilli e Augusta in Sicilia - una zona dove la percentuale di bambini con gravi malformazioni congenite è quattro volte superiore alla media nazionale - o ancora l’altro triangolo della morte vicino Napoli, tra Giugliano, Qualiano e Villaricca, dove l’incidenza di casi di tumore è decisamente superiore alla media nazionale.
1.4 L’esaurimento delle risorse naturali e/o la loro compromissione per contaminazione
L’ultimo esempio di fenomeno globale che sta portando il mondo verso la catastrofe è quello relativo alle risorse naturali, che si stanno in parte esaurendo e in parte compromettendo per problemi di contaminazione. Prima di sviluppare in dettaglio questo argomento vogliamo far presente che problemi di questo tipo, in scala ridotta, il genere umano li ha già incontrati, e con conseguenze catastrofiche. Se oggi siamo qui a raccontarne una è solo perché la regione interessata dal collasso è solo una piccola parte della terra. Riportiamo qui di seguito alcuni passaggi tratti da un saggio di Jared Diamond, Collasso, relativi alla storia di Rapa Nui, l’Isola di Pasqua, terra famosa per le grandi statue di pietra. Come è noto l’isola fu scoperta dall’esploratore olandese Jacob Roggeveen il giorno di Pasqua del 1722 (da cui il nome) ed è stato ormai accertato scientificamente che l’isola “era ricoperta da una fitta foresta subtropicale ricca di grossi alberi e arbusti legnosi” e che era ricca di uccelli e selvaggina. Ma all’arrivo dei colonizzatori l’impressione fu tutt’altra:
“Roggeveen si scervellava per capire come fossero state erette quelle enormi statue. Per citare ancora una volta il suo diario: “Le immagini di pietra ci fecero grande meraviglia, perché non riuscivamo a capire come questo popolo, sprovvisto di legno spesso e robusto necessario alla costruzione di un qualsiasi strumento meccanico, e completamente privo di funi resistenti, fosse stato capace di erigere tali effigi alte 9 metri (…). All’inizio, da una certa distanza, avevamo creduto che l’isola di Pasqua fosse un deserto, poiché avevamo scambiato per sabbia la sua erba ingiallita, il fieno e gli arbusti inariditi e bruciati (…)”. Che cosa era accaduto a tutti gli alberi che un tempo dovevano esserci stati? Per scolpire, trasportare e innalzare le statue ci volevano molti uomini, che dunque dovevano vivere in un ambiente sufficientemente ricco da poterli sostenere. (…) La storia dell’isola di Pasqua è il caso più eclatante di deforestazione mai verificatosi nel Pacifico, se non nel mondo intero: tutti gli alberi sono stati abbattuti e tutte le specie arboree si sono estinte”.[13]
“La deforestazione iniziò da subito, raggiunse il suo culmine nel 1400, e si completò, in varie date, da zona a zona, concludendosi alla fine del XVII secolo. Le conseguenze immediate furono la perdita di materie prime per la costruzione di moai (le grandi statue, ndr) e di canoe per la navigazione in alto mare. Dal 1500, privi di canoe, gli abitanti dell’isola non poterono più cacciare delfini e tonni.
La deforestazione impoverì l’agricoltura esponendo il suolo all’azione corrosiva e depauperante del vento e della pioggia, eliminando altresì il concime frutto delle foglie e dei frutti degli alberi.
La mancanza di proteine animali e la riduzione della terra coltivabile portò ad un’estrema pratica di sopravvivenza: il cannibalismo. Nelle tradizioni orali dei suoi abitanti compariva spesso il richiamo a questo modo di alimentarsi. L’insulto tipico fatto ad un nemico era: “Mi è rimasta tra i denti la carne di tua madre”.[14]
“Per il loro completo isolamento, gli abitanti di Pasqua costituirono un chiaro esempio di società che si auto distrusse attraverso lo sfruttamento eccessivo delle sue risorse. (…) I paralleli che si possono tracciare tra l’isola di Pasqua e il mondo moderno sono così ovvi da apparirci agghiaccianti. Grazie alla globalizzazione, al commercio internazionale, agli aerei a reazione e a Internet, tutti i paesi sulla faccia della terra condividono, oggi, le loro risorse e interagiscono, proprio come i dodici clan dell’isola di Pasqua, sperduti nell’immenso Pacifico come la Terra è sperduta nello spazio. Quando gli indigeni si trovarono in difficoltà, non poterono fuggire né cercare aiuto al di fuori dell’isola, come non potremmo noi, abitanti della Terra, cercare soccorso altrove, se i problemi dovessero aumentare. Il crollo dell’isola di Pasqua, secondo i più pessimisti, potrebbe indicarci il destino dell’umanità nel prossimo futuro”.[15]
Questa premessa recuperata per intero dal saggio di Diamond ci ammonisce sul fatto che la capacità dell’ecosistema Terra non è illimitata e che, come ad un certo punto si è verificato per l’isola di Pasqua in scala ridotta, qualcosa di simile può riprodursi nel prossimo futuro se l’umanità non saprà amministrare adeguatamente le sue risorse.
In verità esiste un parallelo immediato che potremmo fare proprio a livello di deforestazione, che è andata avanti dalle origini delle civiltà primitive ad oggi a livello serrato e che sciaguratamente continua ad andare avanti distruggendo i polmoni verdi residuali della Terra, come la foresta amazzonica. Come è noto, mantenere queste parti verdi sulla superficie terrestre è importante non solo per preservare una serie di specie animali e vegetali, ma anche per assicurare un adeguato equilibrio tra biossido di carbonio ed ossigeno (la vegetazione si sviluppa appunto consumando CO2 e producendo glucosio ed ossigeno).
Come abbiamo già visto rispetto al caso della contaminazione da mercurio, la borghesia è consapevole dei rischi che corre su questi piani, come dimostrato dal nobile intervento di uno scienziato del secolo 19°, Rudolf Julius Emmanuel Clausius, che sul problema dell'energia e delle risorse si era espresso in maniera molto chiara, anticipando di ben oltre un secolo i cosiddetti discorsi sulla sostenibilità ambientale: “Nell’economia di una nazione c’è una legge di validità generale: non bisogna consumare in ciascun periodo più di quanto è stato prodotto nello stesso periodo. Perciò dovremmo consumare tanto combustibile quanto è possibile riprodurre attraverso la crescita degli alberi.”[16]
Ma a giudicare da quanto sta avvenendo oggi possiamo dire che si sta facendo giusto l’opposto di quanto raccomandava Clausius e stiamo andando dritto nella direzione fatale dell’isola di Pasqua.
Per affrontare adeguatamente il problema delle risorse occorre tenere presente anche un’altra variabile fondamentale, che è quella della variazione della popolazione mondiale:
“Fino al 1600 la crescita della popolazione mondiale era così lenta da far registrare un aumento del 2-3% per ogni secolo: furono necessari ben 16 secoli perché dai 250 milioni di abitanti all'inizio dell'era cristiana si passasse a circa 500 milioni di abitanti. Da questo momento in poi il tempo di raddoppio della popolazione è andato sempre diminuendo tanto che, oggi, in alcuni Paesi del mondo ci si avvicina al cosiddetto "limite biologico" nella velocità di crescita di una popolazione (3-4% l'anno). Secondo l’ONU si supereranno gli otto miliardi di abitanti intorno al 2025 (…).
Bisogna considerare le notevoli differenze che, attualmente, si registrano fra Paesi avanzati, arrivati quasi al "punto zero" della crescita, e Paesi in via di sviluppo che contribuiscono al 90% dell'incremento demografico odierno. (…) Nel 2025, secondo le previsioni dell'ONU, la Nigeria ad esempio, avrà una popolazione superiore a quella degli Stati Uniti e l'Africa supererà di tre volte l'Europa per numero di abitanti. Il sovrappopolamento, unito ad arretratezza, analfabetismo e mancanza di adeguate strutture igienico-sanitarie, costituisce sicuramente un grave problema non solo per l'Africa a causa delle inevitabili conseguenze di tale fenomeno a livello mondiale. Si verifica, infatti, uno squilibrio tra domanda e offerta di risorse disponibili, dovuto anche all'utilizzo di circa l'80% delle risorse energetiche mondiali da parte dei Paesi industrializzati.
Il sovrappopolamento comporta un forte abbassamento del tenore di vita in quanto diminuisce la produttività per addetto e la disponibilità pro capite di generi alimentari, acqua potabile, servizi sanitari e cure mediche. La forte pressione antropica in atto sta portando ad un degrado ambientale che, inevitabilmente, si ripercuote sugli equilibri dell'intero sistema Terra.
Lo squilibrio, negli ultimi decenni, si sta accentuando: la popolazione continua non solo a crescere in modo non omogeneo ma si addensa sempre più nelle aree urbane.”[17]
Come si vede da queste brevi notizie, l’incremento della popolazione non fa che acuire il problema dell’esaurimento delle risorse, anche perché, come indicato dallo stesso documento, questa carenza si avverte soprattutto dove è più forte l’esplosione demografica, con scenari per il futuro che disegnano crescenti calamità di massa.
Cominciamo dunque a esaminare la prima risorsa naturale per eccellenza, l’acqua, un bene così universalmente necessario e così fortemente compromesso oggi dall’azione irresponsabile del capitalismo.
L’acqua è una sostanza che si trova abbondante sulla superficie terrestre (si pensi solo agli oceani, le calotte polari, le acque sotterranee e quelle superficiali), ma solo una parte molto piccola è adatta all’uso potabile, quella che si trova confinata nelle falde sotterranee e alcune acque di corsi d’acqua incontaminati. Purtroppo lo sviluppo di attività industriali condotte senza alcun rispetto per l’ambiente e lo scarico diffuso di reflui urbani hanno contaminato porzioni consistenti di falde acquifere, che sono il deposito naturale delle acque potabili della collettività. Ciò ha condotto, da una parte, all’insorgenza di tumori e patologie di varia natura nelle popolazioni, dall’altra alla riduzione crescente delle fonti di approvvigionamento di questo bene così prezioso.
“Entro la metà del XXI secolo, secondo la più pessimistica delle previsioni, sette miliardi di persone in 60 paesi non avranno acqua a sufficienza. Se le cose dovessero andare invece per il meglio, saranno “solo” due miliardi di persone in 48 paesi a soffrire della penuria d’acqua. (…) Ma i dati più preoccupanti del documento dell’Onu sono probabilmente quelli sulle morti per l’acqua inquinata e le cattive condizioni igieniche: 2,2 milioni all’anno. L’acqua è inoltre il vettore di molte malattie, fra le quali la malaria, che uccide ogni anno circa un milione di persone.”[18]
La rivista scientifica inglese New Scientist, riportando i risultati del simposio sull’acqua di Stoccolma dell’estate del 2004, ha riferito che: “Nel passato sono stati impiantati decine di milioni di questi pozzi, molti senza alcun controllo, e le quantità d'acqua estratte dalle potenti pompe elettriche sono di gran lunga superiori all'acqua piovana che va a riempire le falde (…) L’estrazione di acqua consente a molti paesi abbondanti raccolte di riso e zucchero di canna (sementi che hanno un estremo bisogno di acqua per poter crescere, ndr), ma il boom è destinato ad una vita breve. (…) L’India è l’epicentro della rivoluzione degli emungimenti. Usando la tecnologia dell’industria estrattiva petrolifera, i piccoli coltivatori agricoli hanno scavato 21 milioni di pozzi nei loro campi, ed ogni anno il numero di pozzi aumenta di circa un altro milione. (…) In Cina: nelle pianure del nord, dove si produce la maggior quantità di prodotti agricoli, ogni anno i coltivatori estraggono 30 km cubi di acqua in più di quelli portati dalle piogge. (…). Nell’ultima decade il Vietnam ha quadruplicato il numero di pozzi, toccando quota 1 milione. Nel Punjab, regione del Pakistan dove si produce il 90% delle risorse alimentari del paese, le falde freatiche si stanno prosciugando”.[19]
Se dunque la situazione è in generale grave, anche molto grave, nei paesi cosiddetti emergenti come India e Cina la situazione è catastrofica e rischia di arrivare al collasso a breve:
“La siccità che attanaglia la provincia di Sichuan e Chongqing ha causato perdite economiche per almeno 9,9 miliardi di yuan e fa scarseggiare l'acqua da bere per oltre 10 milioni di persone, mentre nell'intera nazione almeno 18 milioni hanno carenza d'acqua.”[20]
“La Cina è colpita dalle peggiori inondazioni degli ultimi anni, con 60 milioni di persone colpite nella Cina centrale e meridionale, almeno 360 morti e perdite economiche dirette già pari a 7,4 miliardi di yuan, 200mila case distrutte o danneggiate, 528mila ettari di terre agricole distrutte e altri 1,8 milioni sommersi. Intanto avanza veloce la desertificazione, che copre un quinto delle terre e provoca tempeste di sabbia che arrivano fino al Giappone. (…) Se la Cina centrale e meridionale soffrono di inondazioni, a nord continua ad espandersi il deserto, che ormai copre un quinto delle terre, lungo il corso superiore del Fiume Giallo, sull’altopiano del Qinghai-Tibet e in parte della Mongolia interna e del Gansu.
La Cina ha il 20% circa della popolazione mondiale, ma solo il 7% della terra coltivabile.
Secondo Wang Tao, membro dell’Accadenia cinese delle scienze a Lanzhou, nell’ultimo decennio i deserti cinesi sono aumentati di 950 chilometri quadrati ogni anno. Ogni primavera le tempeste di sabbia flagellano Pechino e l’intera Cina settentrionale e giungono fino a Corea del Sud e Giappone.”[21]
Tutto questo ci deve fare riflettere sulla decantata forza del capitalismo cinese. In realtà il recente sviluppo dell’economia cinese, piuttosto che dare vigore ed energia al capitalismo mondiale senescente, esprime piuttosto l’orrore della sua agonia, con le sue città devastate dallo smog a stento mascherato nelle recenti olimpiadi, con i corsi d’acqua prosciugati e contaminati e con le mattanze quotidiane di operai che vengono falcidiati a migliaia nelle miniere e nelle fabbriche da condizioni di lavoro incredibilmente dure e prive di qualunque requisito di sicurezza.
Tante altre sono le risorse in via di esaurimento e, in chiusura di questo primo articolo, faremo solo un rapido accenno a due di queste.
La prima è quasi scontata e obbligata: il petrolio. Come è noto è dagli anni ’70 che si parla dell’esaurimento delle scorte naturali di petrolio ma adesso, anno 2008, sembra che siamo veramente arrivati al picco di produzione di petrolio, il cosiddetto picco di Hubbert, ovvero il momento in cui avremmo già esaurito e consumato la metà delle risorse naturali di petrolio previste dalle varie prospezioni geologiche. Il petrolio rappresenta oggi quasi il 40% dell'energia primaria generata e circa il 90% dell’energia usata nei trasporti; importanti sono anche le sue applicazioni nell'industria chimica, in particolare quella dei fertilizzanti per l'agricoltura, nonché plastiche, colle,vernici, lubrificanti, detersivi. Tutto questo è stato possibile perché il petrolio ha costituito una risorsa a basso costo e apparentemente senza limiti. Ma adesso che la carenza di petrolio ne fa aumentare vertiginosamente il prezzo, il mondo capitalista si volge verso delle alternative meno onerose. Ma, ancora una volta, l’invito di Clausius a non consumare in una generazione più di quello che la natura è capace di riprodurre resta senza ascolto e il mondo capitalista è proiettato in una corsa folle ai consumi di energia dove paesi come la Cina e l’India la fanno da padroni, bruciando tutto quello che c’è da bruciare, tornando al tossico carbon fossile, pur di creare energia, e producendo tutto intorno una contaminazione senza precedenti.
Naturalmente anche il ricorso miracoloso al cosiddetto biodiesel ha fatto il suo tempo e ha mostrato tutte le sue insufficienze. Produrre combustibile dalla fermentazione alcolica di amido di mais o da prodotto vegetali oleaginosi non solo non riesce a coprire l’esigenza di combustibile che richiede il mercato oggi ma soprattutto innesca un rialzo dei prezzi alimentari che porta ad affamare le popolazioni povere contadine. Il vantaggio, ancora una volta, è delle singole aziende capitaliste, come quelle alimentari che si stanno riconvertendo verso il business dei biocarburanti. Ma per i poveri mortali questo significa solo che vasti tratti di foresta vengono abbattuti per fare posto alle piantagioni (milioni e milioni di ettari). Infatti la produzione di biodiesel comporta l’utilizzazione di grandi distese di terreno. Per avere un’idea del problema basti pensare che un ettaro di terra coltivata a colza o girasole o altri semi oleaginosi produce circa 1000 litri di biodiesel, che sono in grado di far marciare un automezzo per circa 10.000 km. Se ipotizziamo che in media le automobili di un certo paese sviluppano un chilometraggio di 10.000 km per anno, ogni singola automobile consuma tutto il biodiesel prodotto da 1 ettaro di terreno. Ciò comporta che un paese come l’Italia, dove circolano 34 milioni di autovetture, se volesse recuperare il suo combustibile per autotrazione dall’agricoltura, avrebbe bisogno di una superficie coltivabile di 34 milioni di ettari. Se alle auto aggiungiamo i circa 4 milioni di camion, che hanno motori più grossi e fanno almeno 10 volte più Km/anno, si ha un consumo almeno doppio, arrivando ad impegnare una superficie di circa 70 milioni di ettari, che corrisponde a una superficie grande quasi due volte e mezzo la penisola italiana, comprese le montagne, le città, ecc. ecc.
Anche se non se ne parla allo stesso modo, un problema analogo a quello dei combustibili fossili si pone, naturalmente, per qualunque altra risorsa di tipo minerale, ad esempio per quei minerali da cui si estraggono metalli. E’ vero che, in questo caso, il metallo non viene distrutto dall’uso, come succede per il petrolio o il gas metano, ma l’incuria della produzione capitalista finisce per disperdere sulla superficie della terra e dentro le discariche quantitativi significativi di metalli, con la conseguenza che la disponibilità di questi materiali va anch’essa, prima o dopo, verso l’esaurimento. Tra l’altro l’uso di certi materiali in leghe o in materiali poliaccoppiati rende ancora più ardua l’impresa di un eventuale recupero del singolo materiale “puro”.
Per avere un’idea del problema si pensi che, entro pochi decenni, risulteranno quasi esaurite le seguenti risorse: uranio, platino, oro, argento, cobalto, piombo, manganese, mercurio, molibdeno, nichel, stagno, tungsteno e zinco. Come si vede si tratta di materiali praticamente indispensabili alla moderna industria e la cui carenza peserà gravemente sul prossimo futuro. Ma anche altri materiali non sono inesauribili: si calcola che vi siano disponibili ancora (nel senso di economicamente convenienti da estrarre): 30 miliardi di tonnellate di ferro, 220 milioni di tonnellate di rame, 85 milioni di tonnellate di zinco. Per avere un’idea delle quantità basti pensare che per portare i paesi poveri al livello dei paesi avanzati occorrerebbero rispettivamente 30 miliardi di tonnellate di ferro, 500 milioni di tonnellate di rame, 300 milioni di tonnellate di zinco, cioè decisamente di più di quanto tutto il pianeta Terra potrebbe offrire.
Di fronte a questa catastrofe annunciata c’è da chiedersi se progresso e sviluppo si debbano coniugare necessariamente con inquinamento e sconvolgimento dell’ecosistema Terra. C’è da chiedersi se tali disastri siano da attribuire alla cattiva educazione degli uomini o se siano da attribuire ad altro. E’ quanto vedremo appunto nel prossimo articolo.
14 agosto 2008 Ezechiele
[1] Rivoluzione comunista o distruzione dell’umanità, Manifesto adottato dal IX Congresso della CCI di luglio 1991 (Revue Internationale n° 67, ott.-dic. 1991).
[2] G. Barone et al., Il metano e il futuro del clima, in Biologi Italiani, n°8 del 2005.
[3] idem
[4] G. Pellegri, Terzo mondo: nuova pattumiera creata dal buonismo tecnologico [14].
[5]Vivere di rifiuti
[6] Roberto Saviano, Gomorra, viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, Arnoldo Mondadori Editore, 2006
[7] La Repubblica on-line, 29/10/07
[8] La Repubblica, 6/02/08. In the USA alone every year more than 100 billion plastic bags are used, 1.9 million tons of oil are needed to produce them, most of them end up being thrown away, they take years before being decomposed. The US- production of some 10 billion paper bags requires the chopping of some 15 million trees alone.
[9] Vedi l’articolo: Mediterraneo, un mare di plastica, da La Repubblica del 19 luglio 2007.
[10] Non è escluso naturalmente che il rincaro vertiginoso del petrolio, a cui stiamo assistendo dalla fine dell’anno scorso, non metta in discussione l’uso di questa materia prima per la produzione di plastiche sintetiche non biodegradabili, inducendo nel prossimo futuro un processo di conversione alla nuova fede ecologica da parte di attenti imprenditori, attenti ancora una volta a salvaguardare i propri interessi!
[11] R. Troisi, Le discarica del mondo luogo di miseria e di speranza nel ventunesimo secolo.
[12] Vedi l’articolo “Alcuni effetti collaterali dell’industria. La Chimica, la diga, il nucleare”
[13] Jared Diamond, Collasso, edizioni Einaudi.
[14] “Ancora su petrolio e capitalismo” dalla redazione dell’Archivio Storico della Nuova Sinistra “Marco Pezzi” [15]
[15] Jared Diamond, Collasso, edizioni Einaudi.
[16] R.J.E. Clausius (1885), nato a Koslin (Prussia, ora Polonia) nel 1822 e morto a Bonn nel 1888.
[17] Associazione Italiana Insegnanti Geografia, La crescita della popolazione, in
[18] G. Carchella, Acqua: l’oro blu del terzo millennio, su “Lettera22, associazione indipendente di giornalisti”.
[19] Asian farmers sucking the continent dry [16], 28 agosto 2004, su Newscientist,
[20] PB, Cina: oltre 10 milioni di persone assetate dalla siccità, su Asianews, www.asianews.it/index.php?l=it&art=6977 [17]
[21] La Cina stretta tra le inondazioni e il deserto che avanza, 18/08/2006, su Asianews, www.asianews.it/index.php?l=it&art=9807 [18]
Questioni teoriche:
- Ambiente [19]
